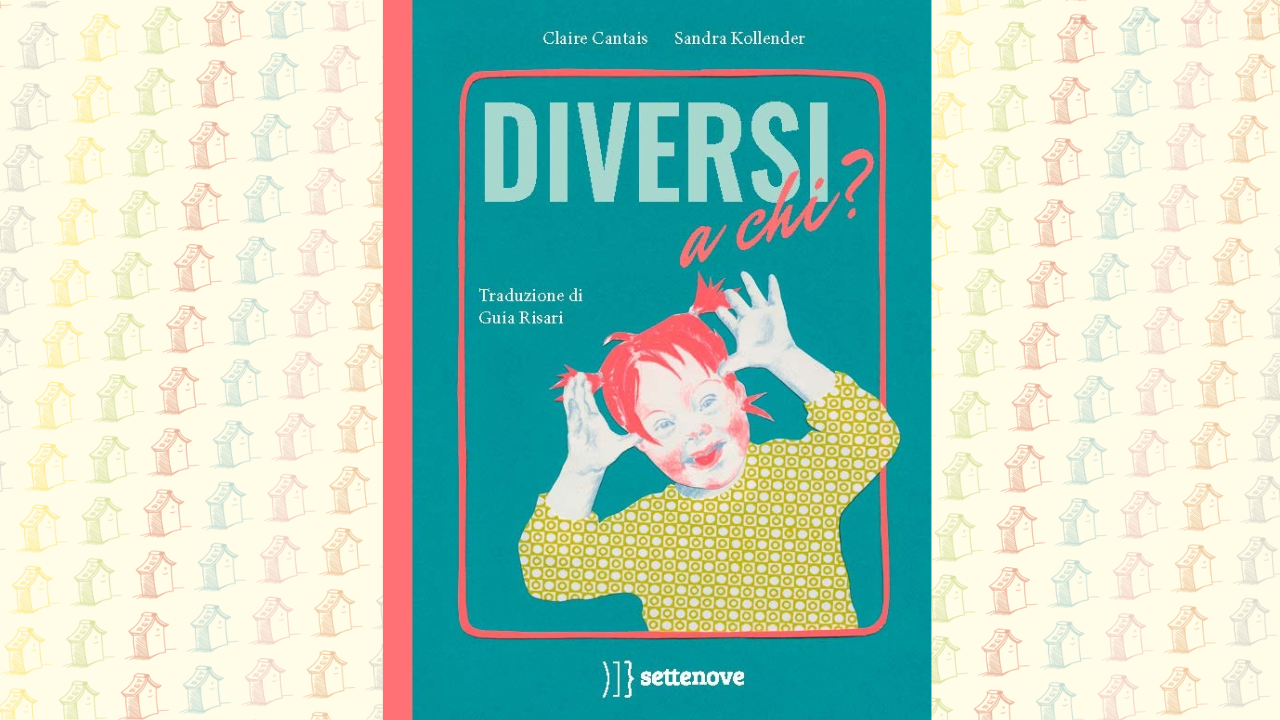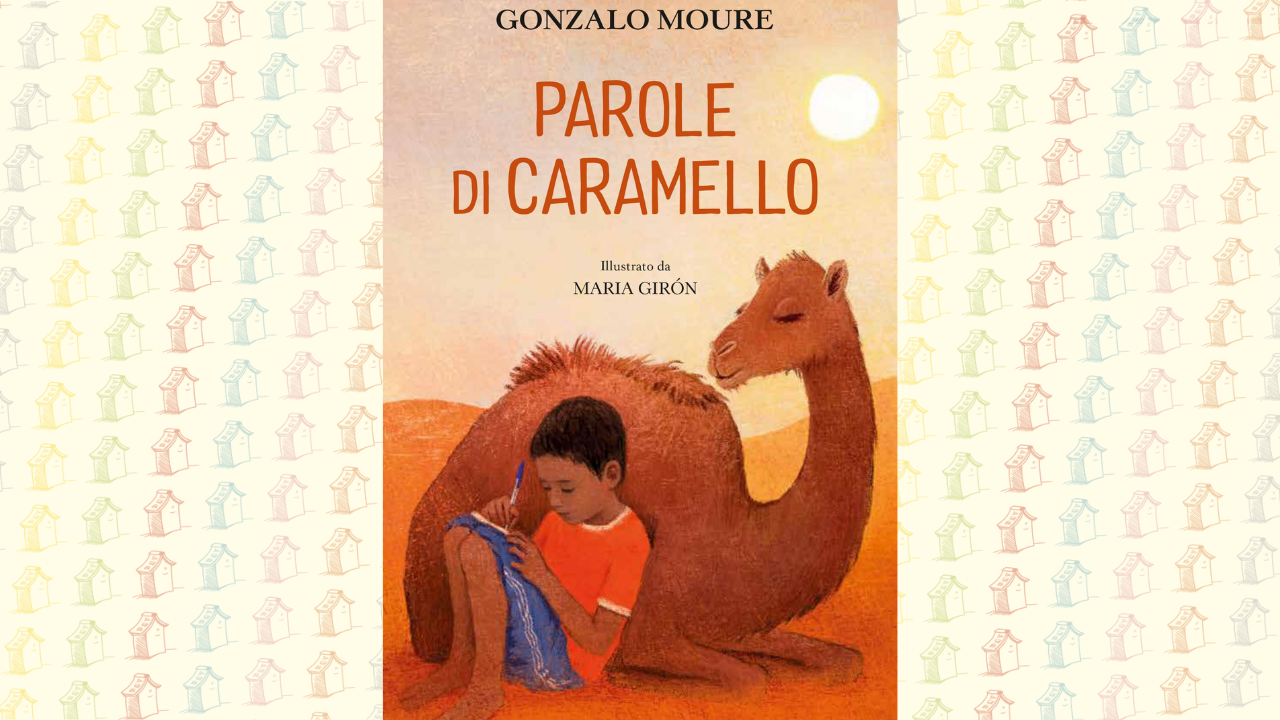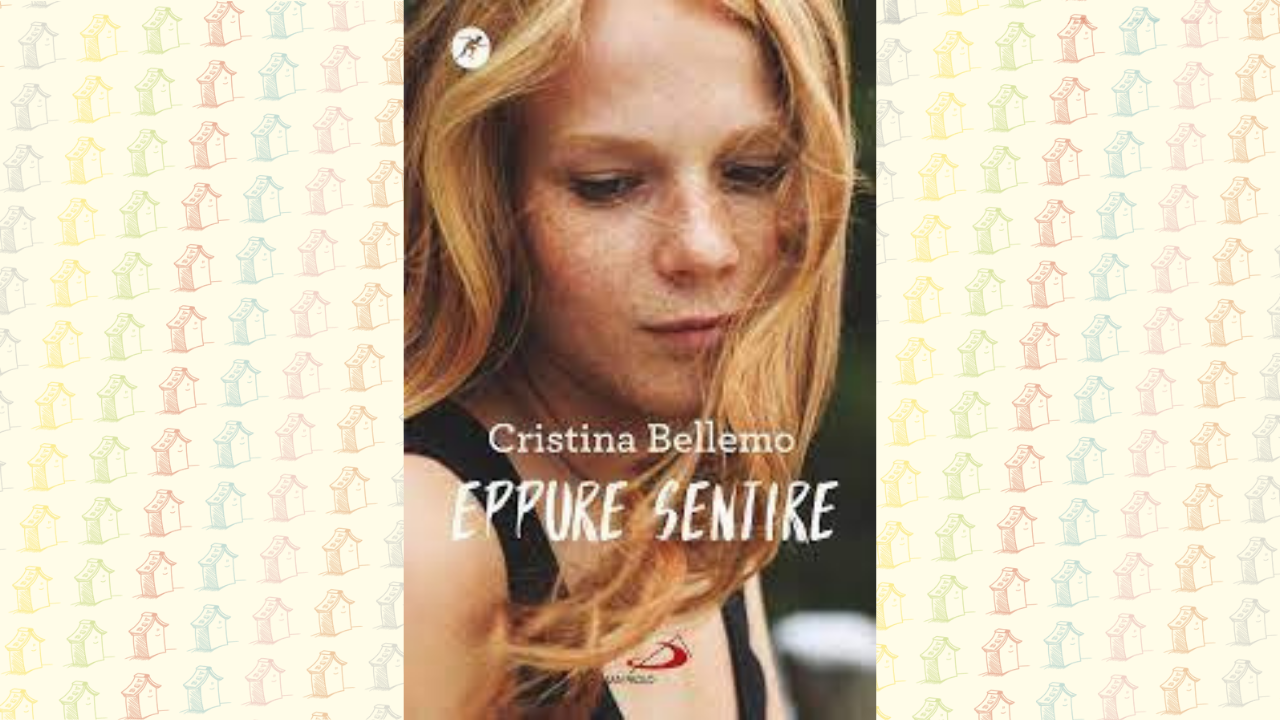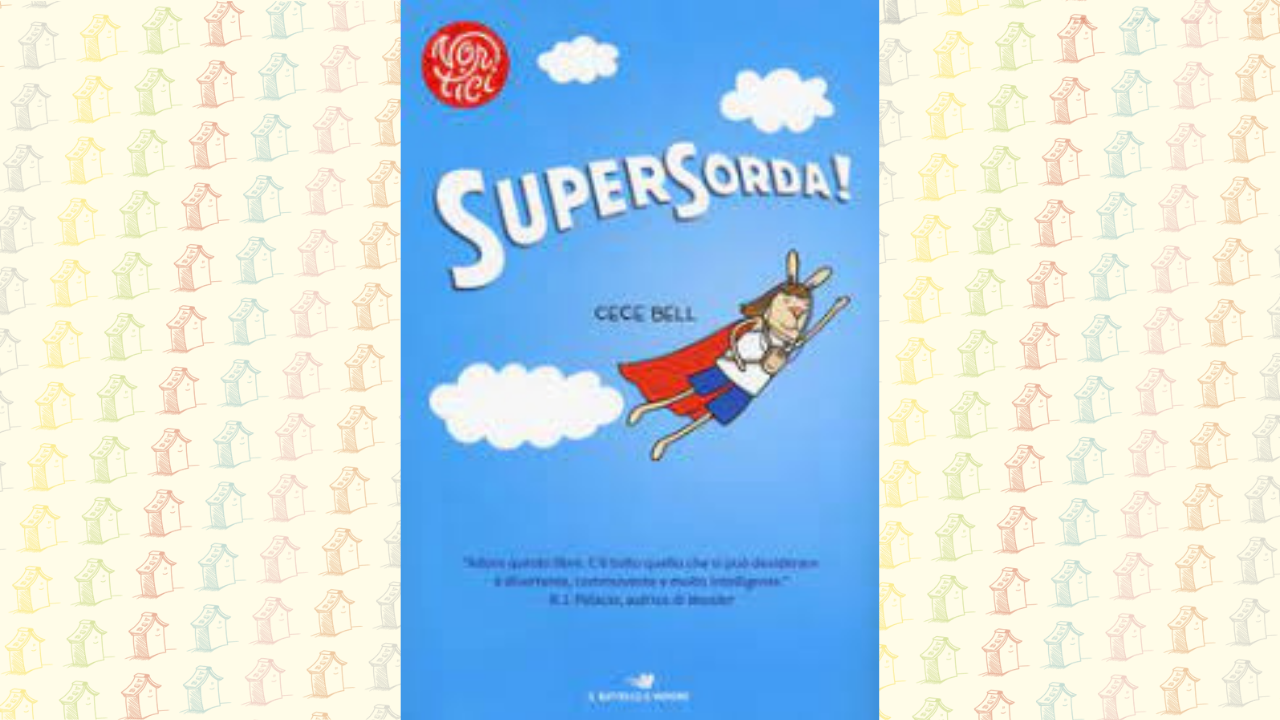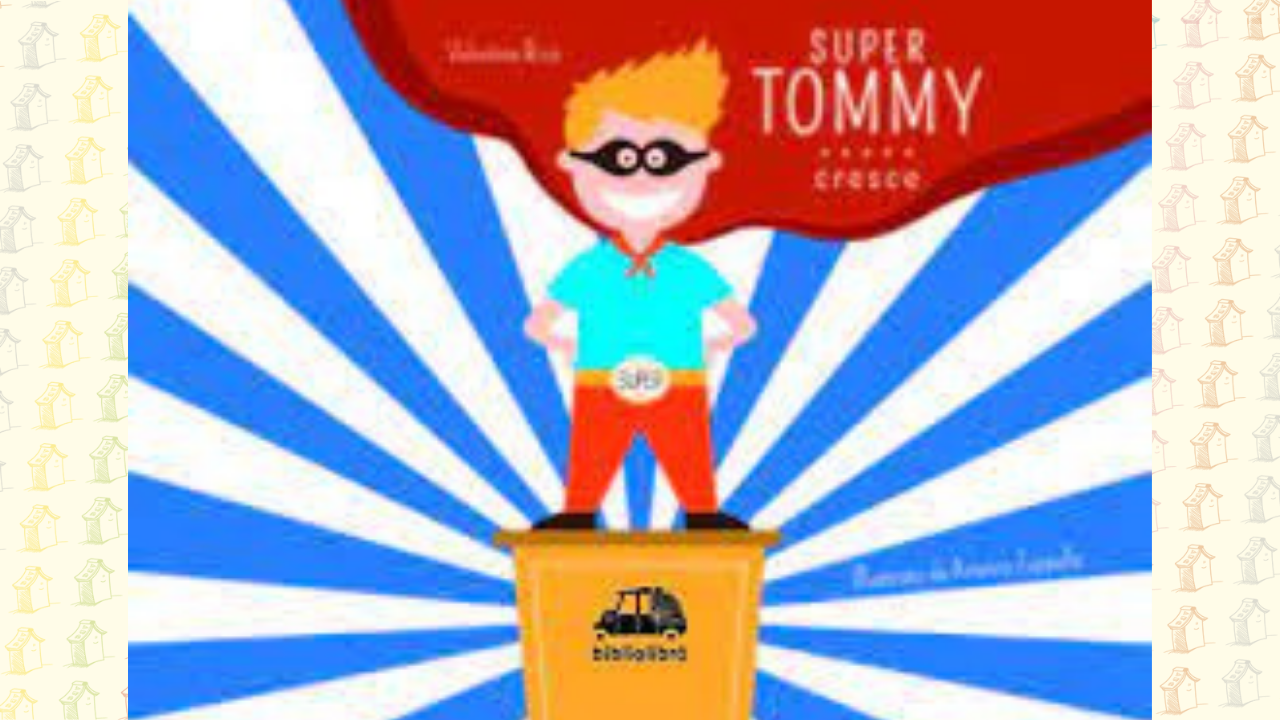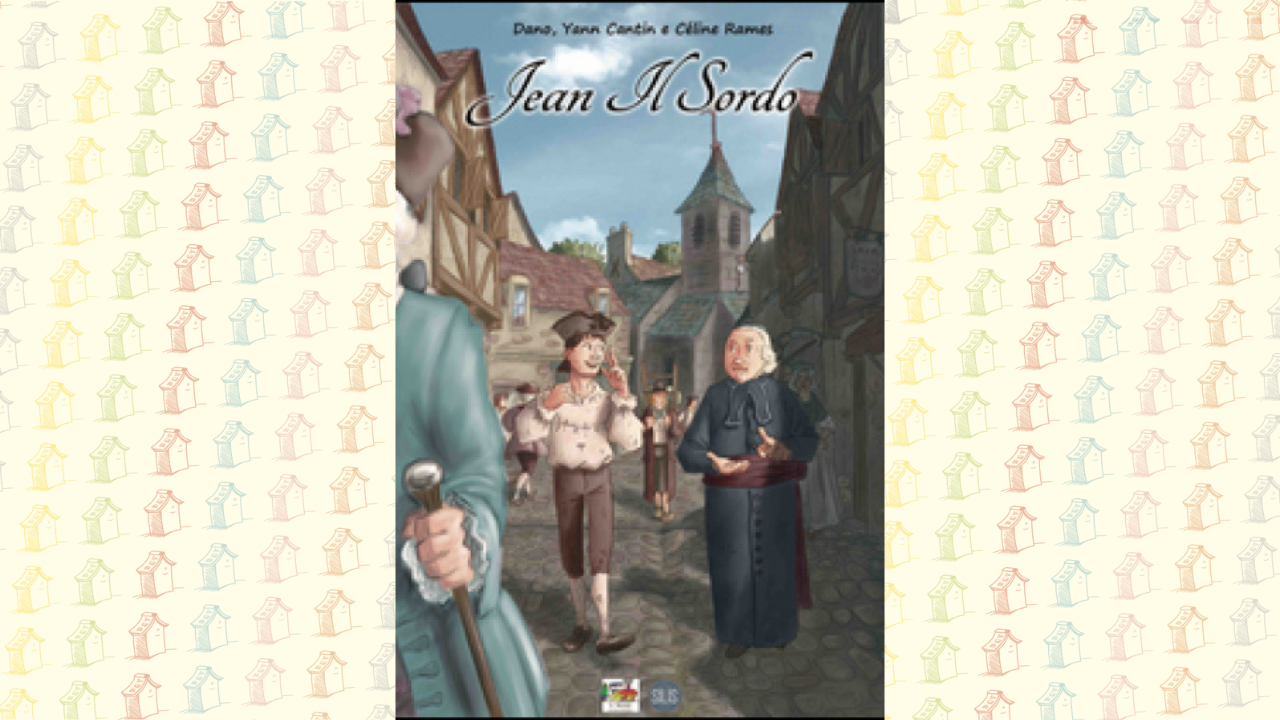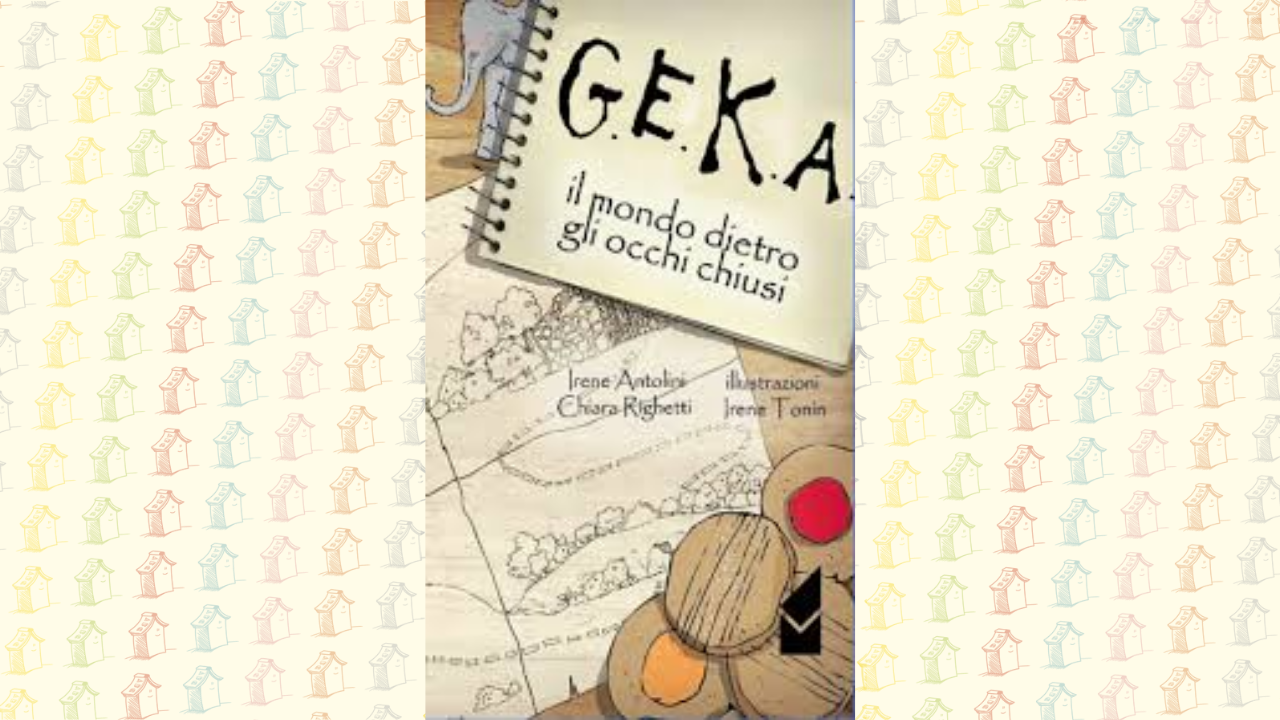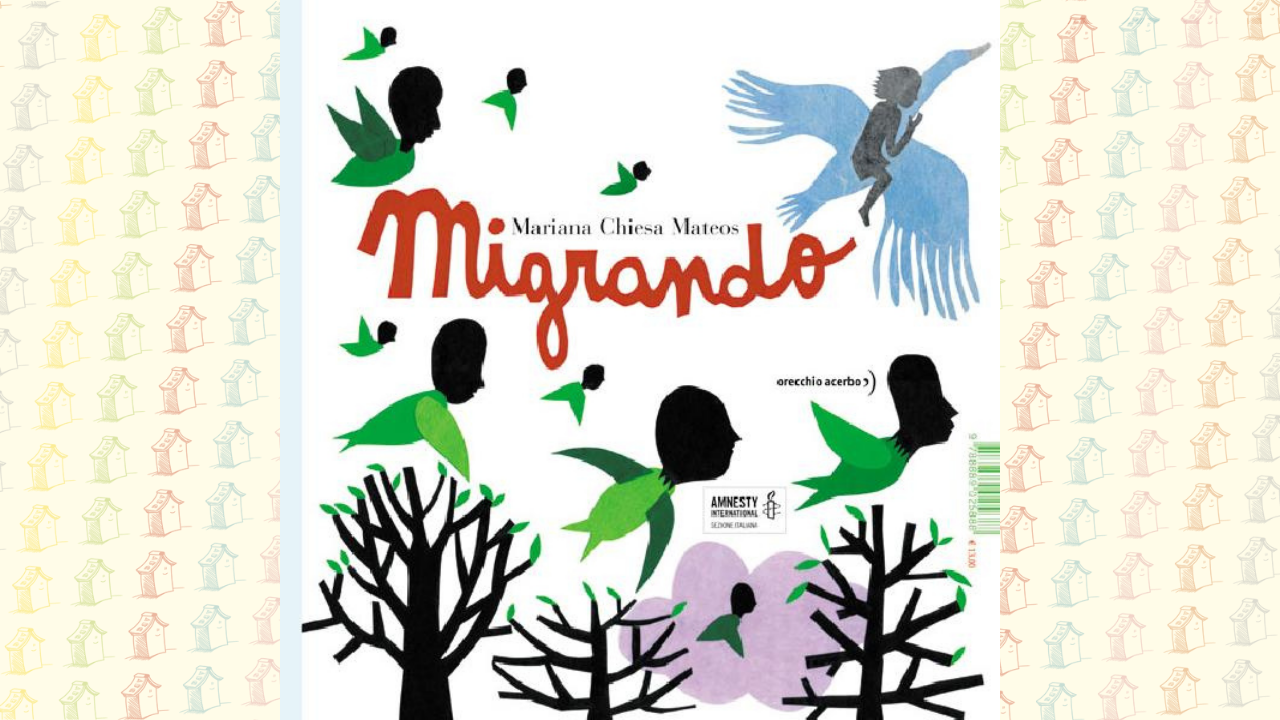La cosa più preziosa
Quando pensiamo al ruolo che libri e narrazioni possono giocare in favore del radicamento di una nuova cultura dell’inclusione, non possiamo assolutamente trascurare quei volumi che la disabilità la sfiorano senza affrontarla di petto. Come e più dei libri che mettono di diversità al centro del racconto, infatti, queste proposte offrono al lettore la possibilità di incontrare, conoscere e riconoscere la varietà che popola il mondo in maniera autentica e incisiva. Proprio in quei racconti che sembrano stare a margine, cioè, il valore della differenza tende spesso a emergere con maggiore forza e con minore forzatura.
Il libro di Victor D.O. Santos e Anna Forlati è proprio uno di questi. Qui la protagonista è una cosa preziosa – quella più preziosa addirittura, stando al titolo dell’edizione italiana (la cosa che ci rende umani, per affidarci in maniera più letterale al titolo dell’edizione originale) – qualcosa che risale a moltissimo tempo fa, che si può trovare dappertutto, che si impara pian piano e che permea le nostre giornate, che è mutevole e multiforme e che può fare cose davvero straordinarie. Protagonista del libro è – svelando l’arcano – la lingua, o meglio l’insieme delle lingue che animano il mondo. Il libro ne rivela l’identità solo nell’ultima pagina costruendo nelle pagine precedenti un ritratto per immagini e parole evocative che ne fanno emergere tutta la forza. Il libro si pone dunque come un omaggio a qualcosa che è molto presente nella nostra storia e nella nostra vita, senza che spesso ce ne accorgiamo o che gli attribuiamo la dovuta importanza. Gli autori ne costruiscono l’identikit in maniera efficace, attraverso riferimenti sempre più evidenti e attraverso piccoli indizi visivi che aiutano a trovare la soluzione prima che questa venga esplicitata.
Ma come si colloca la disabilità in questa cornice? In una maniera molto rispettosa e significativa. Dal libro emerge infatti che si può comunicare in tanti modi diversi e ciascuno di essi è messo esattamente sullo stesso piano. Parole, segni, punti, icone trovano posto, cioè, con pari dignità e questo non è poca cosa se si considera il fatto, per esempio, che solo nel 2021 la LIS è stata riconosciuta come lingua a tutti gli effetti nel nostro paese. Mettere per iscritto e raccontare con le immagini che la lingua ha tante forme, che si può vedere, sentire o percepire, significa a tutti gli effetti fare e promuovere l’inclusione. E significa farlo con un mezzo potente. Rappresentare inoltre sulla pagina persone che segnano o che si orientano con un bastone bianco significa contribuire a rendere la disabilità reale, presente. Anna Forlati, già apprezzata per le illustrazioni di Se un bambino, è molto brava in questo: la varietà del mondo passa con delicatezza attraverso le sue matite che suggeriscono senza urlare e arricchiscono ogni tavola di citazioni, rimandi e guizzi inventivi forieri di spunti e significati da scovare.