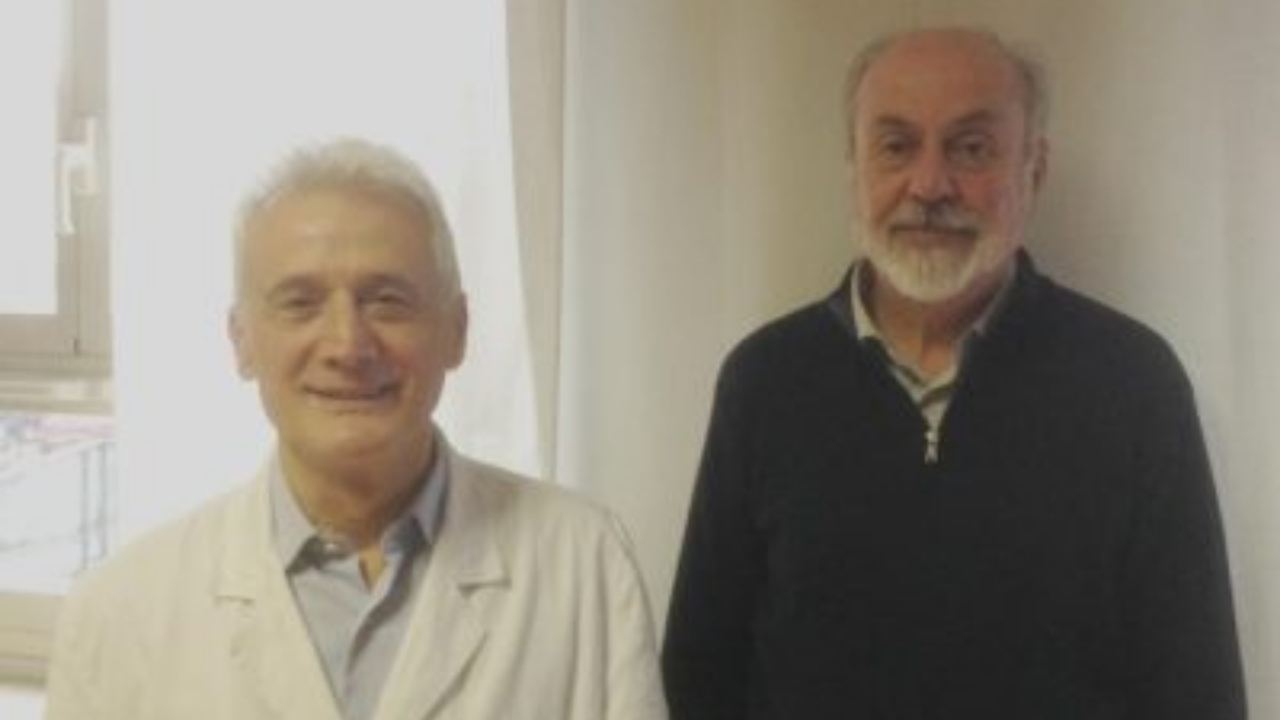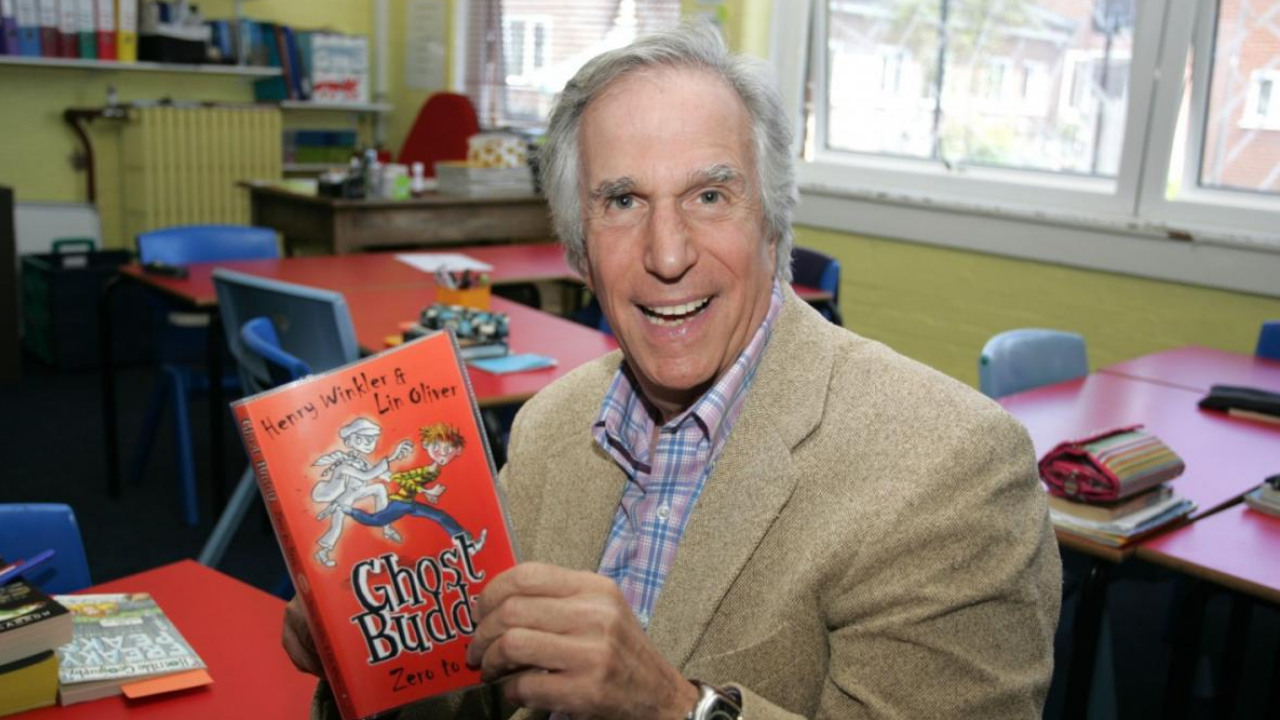Avviamento al lavoro: Intervista a Simona Franceschin – Coop. Il Margine
Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità, Educatrice professionale, in organico alla Coop. Il Margine, Case Manager per le politiche attive del lavoro per il Servizio al Lavoro del Consorzio NAOS di cui la Cooperativa Il Margine fa parte.
Simona mi riceve presso i locali del Servizio al Lavoro del Consorzio NAOS. Gli uffici e la stanza in cui avvengono i colloqui e l’orientamento rivolti alle persone con disabilità si trovano al piano terra e sono accessibili alla disabilità motoria.
Ciao Simona, dove ci troviamo?
Ci troviamo presso i Servizi al Lavoro (S.A.L.) del consorzio NAOS, un consorzio tra cooperative. In particolare questa sala è quella in cui ci troviamo con i gruppi per l’orientamento.
Tengo a dire che a differenza da altri SAL, il nostro ha la caratteristica di avere un organico interamente composto da educatori professionali, quindi con un background in questo ambito, oltre alle politiche attive del lavoro messe a disposizione dalla Regione Piemonte per l’orientamento, la formazione e l’inserimento lavorativo.
Di quali politiche attive di cui si occupa il SAL?
Le due politiche attive di cui ci stiamo occupando in questo momento principalmente sono:
• il progetto G.O.L.
• il Fondo regionale Disabili
Garanzia Occupabilità Lavoratori (G.O.L.) è rivolto a persone che vogliono rimettersi in gioco nell’ambito lavorativo attraverso la formazione. L’Europa attraverso il PNRR finanzia una serie di percorsi formativi per persone che possono fruire di questi percorsi, sulla base di una profilazione.
La profilazione viene fatta dal Centro per l’Impiego, che valuta l’occupabilità della persona in base all’assestment quali-quantitativo (patto di servizio GOL).
I profili sono quattro e vanno da “101” – Profili con alta occupabilità a “104” – Profili con bassa occupabilità. Per questo profilo sono previsti un percorso di inclusione socio-lavorativa e l’attivazione di una rete territoriale multidisciplinare.
Una volta fatto il profilo da parte del centro dell’Impiego, cosa succede?
Il Centro per l’Impiego invia la persona a uno dei S.A.L. sul territorio, ma può anche succedere che sia la persona ad indicare un S.A.L. specifico. A quel punto viene presa in carico ed inserita in un percorso idoneo alla sua profilazione.
Il percorso G.O.L. fa sia ricerca attiva di posti di lavoro, sia ricerca della formazione più idonea. Nel caso del profilo “104” la formazione prevede delle ore di Stage in azienda, che si auspica, prosegui con un tirocinio o un’assunzione.
E il Buono Servizi al Lavoro -Fondo Regione Disabili?
In questo caso i beneficiari sono persone iscritte al collocamento mirato, che abbiano già la diagnosi funzionale.
Quindi si tratta di persone che abbiano un certificato d’invalidità civile con percentuale almeno del 46%, che si siano iscritte al Centro per l’Impiego e alle Liste speciali e in più che abbiano già avuto l’accertamento di “disabilità – Legge 68/99”).
La diagnosi funzionale resta sempre la stessa? Per es. se è indicato che non posso avere relazioni, ma nel tempo acquisisco questa abilità, si può modificare?
La diagnosi funzionale deve essere ripetuta in tre casi:
• quando cambiano le abilità e le competenze, come nel tuo esempio
• quando si compiono i 18 anni, nei casi in cui la richiesta sia fatta prima della maggiore età
• quando cambia la percentuale d’invalidità, per esempio a seguito di una richiesta di aggravamento
In cosa consiste il Buono Servizi al Lavoro Fondo Regionale Disabili?
Prevede l’orientamento e la ricerca attiva delle aziende interessate, quindici ore, da parte degli operatori del SAL.
Se dopo la fase di orientamento e di ricerca attiva avviene il cosiddetto match fra ricerca e offerta, il percorso può sfociare in un tirocinio, oppure la persona può anche scoprire di essere interessata a una nuova formazione.
Il Fondo Regionale Disabili prevede anche l’erogazione di contributi rivolti ai datori di lavoro per favorire l’inserimento e il mantenimento del posto di lavoro delle persone con disabilità, finalizzato a favorire l’inclusione socio-lavorativa delle persone con disabilità, con le caratteristiche descritte all’art. 1 della L.68/99.
Che tipo di consulenze?
Le consulenze finanziate dal fondo regionale disabili (Linea D) possono essere di natura organizzativa (limitatamente ai contesti in cui è inserita una persona con disabilità) e del tutor aziendale, sulle opportunità offerte dalla legge 68/99.
Per esempio proponendo interventi sul come rendere il contesto lavorativo più idoneo a far emergere le competenze della persona inserita.
La mancata assunzione di dipendenti appartenenti alle Categorie Protette prevede una sanzione amministrativa per ogni giorno lavorativo non in regola con l’assunzione.
Tali somme sono destinate proprio al Fondo regionale.
Le aziende ricevono incentivi?
Oltre agli incentivi di defiscalizzazione previsti dalla Legge 68/99, in Piemonte il Fondo regionale incentiva l’assunzione con un contributo una tantum che si calcola in base alla tipologia di contratto.
Il principale obiettivo del bando è, infatti, quello di favorire l’inclusione socio-lavorativa delle persone con disabilità, e in particolare, le misure previste si configurano come un aiuto all’ingresso e alla permanenza nel mercato del lavoro delle persone con disabilità.
A chi può fare riferimento un’azienda che volesse assumere persone con disabilità e fruire di questi incentivi?
Può fare riferimento al sito della Regione Piemonte – Bando Contributi Fondo Regionale Disabili
Il Fondo Regionale ha una scadenza?
Solitamente hanno una scadenza triennale, l’ultimo è stato prorogato a tutto il 2025.
Si può partecipare a entrambe le politiche attive (GOL e FRD)?
No, al momento è possibile partecipare alternativamente all’una o all’altra, mentre è possibile partecipare contemporaneamente a una politica attiva e candidarsi per una selezione per “art. 14”, di cui ti parlerò dopo
Oltre ai Buoni Servizi al Lavoro, di cosa vi occupate nell’ambito delle politiche attive?
Come educatori della cooperativa Il Margine lavoriamo per diversi progetti legati all’inserimento lavorativo, in stretta collaborazione con i Centri per l’Impiego, ASL e Servizi Sociali del territorio di competenza.
In merito all’inclusione e inserimento lavorativo in co-progettazione con Asl Città di Torino- Dipartimento di Salute Mentale offriamo percorsi di attività di orientamento individuali o in piccolo gruppo con focus sulla motivazione, sull’emersione e valorizzazione delle skills spendibili nel mondo del lavoro. Strumento che si sta rivelando importante anche rispetto al periodo storico, in cui afferiscono agli ambulatori sempre più giovani che hanno necessità di comprendere come approcciarsi al mondo del lavoro, nonostante le difficoltà.
Una parte degli educatori del Margine ha fatto una specifica formazione IPS.
IPS significa Individual Placement & Support e consiste in un percorso di inserimento lavorativo sviluppato negli Stati Uniti nei primi anni ’90. Significa arrivare al lavoro partendo dalle motivazioni, attitudini, caratteristiche personali. E’ quella che si definisce una “buona pratica”, che dovrebbe essere applicata in realtà sempre. Ribalta un po’ l’ottica dell’inserimento lavorativo. Ascoltiamo e accogliamo le istanze della persona e la supportiamo nella ricerca del lavoro. Non siamo noi a definire di cosa abbia bisogno, ma lei stessa ad arrivare a chiarirsi rispetto ai valori che cerca nel lavoro, alle istanze, alla rappresentazione personale di cosa significa lavorare.
In Italia questa metodologia ha preso piede in alcune regioni virtuose: Emilia Romagna, Veneto, Trentino, Piemonte… Partita dall’ambito della salute mentale, sta prendendo piede anche nei Servizi che si occupano di dipendenze.
Gli educatori IPS formati applicano questa metodologia per gli inserimenti lavorativi delle persone in carico al Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL TO3.
Inoltre ci occupiamo di fornire consulenze alle aziende o stipulare convenzioni tramite l’Articolo 14.
Ci sono altre politiche attive?
Sì, ci sono opportunità sotto il cappello delle politiche attive che trattiamo direttamente come Cooperativa Il Margine.
Si tratta della cosiddetta Convenzione Art. 14 (Legge 68/99 n.d.r.), a cui ti accennavo prima: le aziende stipulano con la nostra cooperativa (e con altre cooperative) una convenzione di due anni, rinnovabile. La persona viene assunta regolarmente da Il Margine, ma l’azienda in cui prestano servizio può decidere liberamente di assumerle prima della scadenza di questo periodo. Ci è capitato recentemente con tre persone assunte da Italgas. Sempre con Italgas è partita ora una seconda convenzione per ben 7 persone.
Oltre all’assunzione da parte dell’azienda, quali altri possibilità ci sono?
Può essere stipulata una nuova convenzione. presso la stessa o presso un’altra azienda.
E’ un ambito molto delicato, perché la Convenzione Art. 14 è rivolta a persone con disabilità elevata o psichica.
Nell’immaginario collettivo la Convenzione Art. 14 riguarda lavori di pulizie, svuotamento cassonetti, pulizie dei mercati…
In realtà, per fortuna, non è più così da tempo. Per noi il lavoro non è un contenitore per poter dire di aver trovato lavoro a qualcuno, sebbene il lavoro in sé significhi già molto in termini di identità sociale, di immagine di sé, di reddito, di autonomia economica e non solo, di relazioni, ecc..
Come si può partecipare alla Convenzione Art. 14?
La persona si mette in contatto con il Centro per l’Impiego (Agenzia Piemonte Lavoro), oppure si candida a una posizione che le interessa, direttamente sul sito di Agenzia Piemonte Lavoro.
La selezione viene fatta dal Centro per l’Impiego insieme alla Cooperativa che ha stipulato la convenzione.
A volte l’azienda svolge una seconda selezione, fra le persone individuate come idonee.
Una volta stipulato il contratto, la cooperativa attiva un tutoraggio per l’intera durata del contratto.
Come funziona l’orientamento?
L’orientamento prevede sia i colloqui individuali che attività di gruppo, un aiuto a confrontarsi con la propria motivazione, per esempio quando una persona è frenata per scarsa abitudine all’autonomia (imparare a prendere i mezzi pubblici, temere le critiche dei colleghi, ecc.). Supporto nella compilazione del curriculum.
Tengo a precisare una cosa che molte persone ignorano: essere iscritti alle liste speciali è un’opportunità in più. Non significa per nulla essere “bollati” come invalidi: significa poter candidarsi a ricerca di lavoro o concorso esattamente come tutti, ma in più avere un canale riservato. Per questo motivo noi facciamo sempre compilare due CV, uno in cui è indicato il diritto all’inserimento mirato, l’altro senza questa annotazione.
E l’accompagnamento al lavoro, in cosa consiste?
Dico sempre che ottenere un lavoro è la parte più “semplice”: il difficile è mantenerlo. Per questo motivo diamo importanza ai tirocini, che permettono alle persone di sperimentarsi in una determinata situazione lavorativa. Con il tutoraggio invece continuiamo ad essere un riferimento per la persona e per l’azienda, in modo che la persona possa gradualmente arrivare essere un lavoratore a tutti gli effetti, un valore aggiunto per l’azienda.
Infine, per noi è importante lavorare in sinergia con per il Centro per l’Impiego e la rete dei Servizi.
Una persona che è stata seguita da Il Margine, può contare su di voi come riferimento?
Certamente! Ci sono persone che nel tempo ci cercano per cambiare attività o per mettersi o rimettersi in gioco sul piano lavorativo
Ci sono ulteriori opportunità che è utile segnalare ai nostri lettori?
E’ sicuramente importante segnalare le Chiamate sui presenti, che sono riservate agli iscritti al collocamento mirato, e sono finalizzate ad assunzioni presso enti pubblici per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo.
Come si accede alle chiamate sui presenti?
In Piemonte si trovano sul sito di Agenzia Piemonte Lavoro – Offerte di lavoro – Offerte del collocamento mirato.
Da qui le persone interessate compilano un modulo online (https://agenziapiemontelavoro.it/scheda-informativa/offerte-di-lavoro/collocamento-mirato/chiamata-sui-presenti-l-68-99/)
La graduatoria, oltre all’iscrizione alle liste speciali, che è il requisito fondamentale, tiene conto della percentuale d’invalidità e dell’ISEE.
C’è infine qualcosa che secondo te è utile far sapere?
Spesso le persone leggendo sul verbale d’invalidità la dicitura “Totale e permanente incapacità lavorativa: 100%” credono di non poter svolgere alcun lavoro. E’ utile sapere che in presenza della diagnosi funzionale è invece possibile lavorare. Una persona in sedia a rotelle, per esempio, ha proprio questa dicitura, ma può svolgere una quantità di lavori (vai alla sezione Divento maggiorenne).
Area ETS ringrazia Simona Franceschin e la Coop. Sociale “Il Margine”