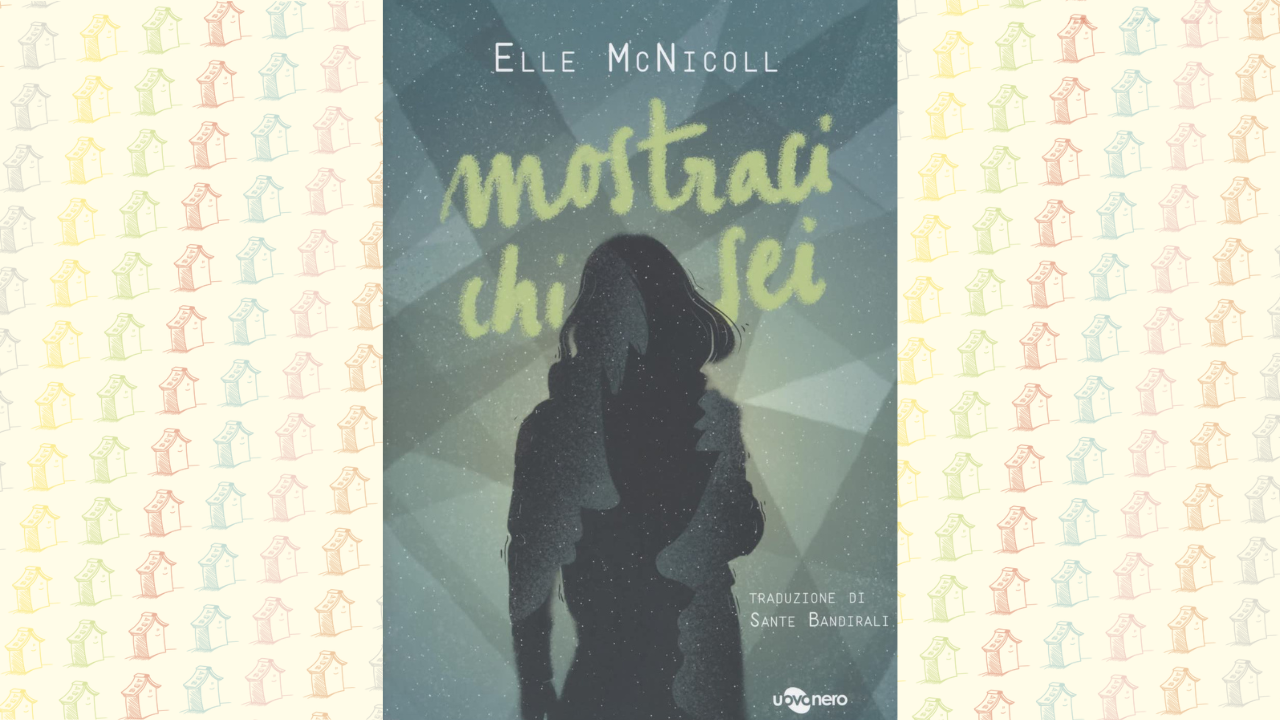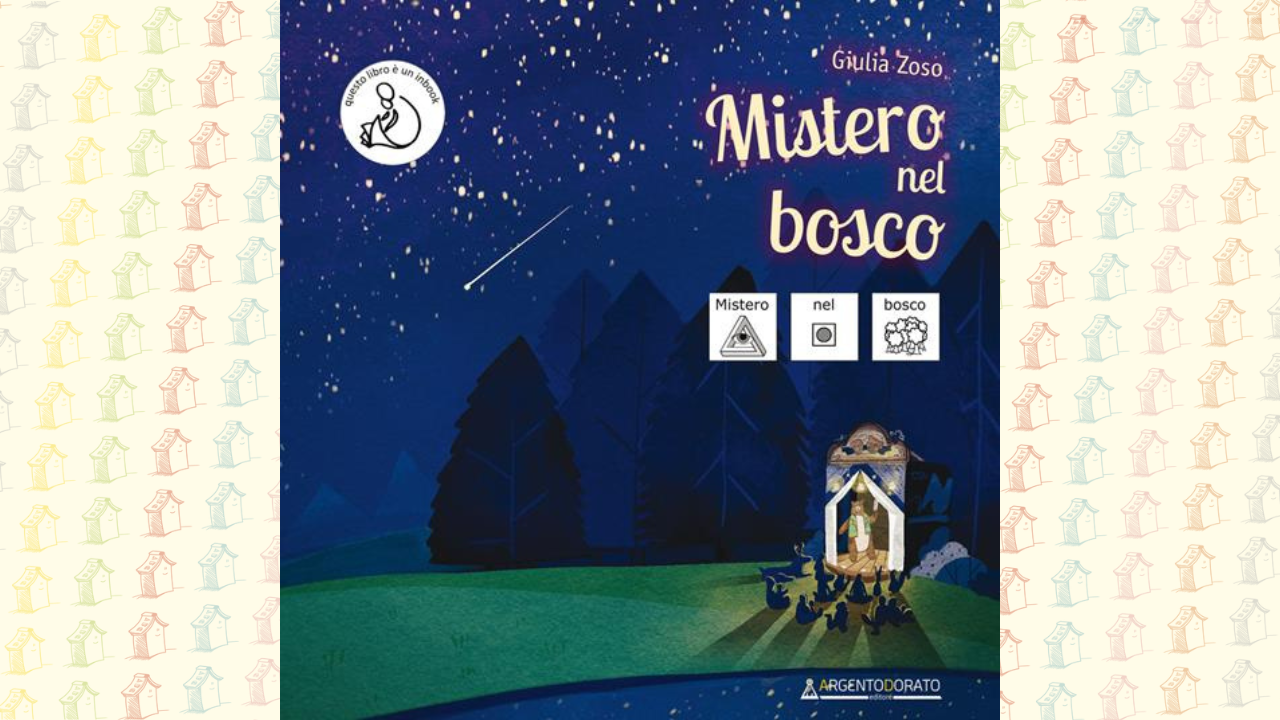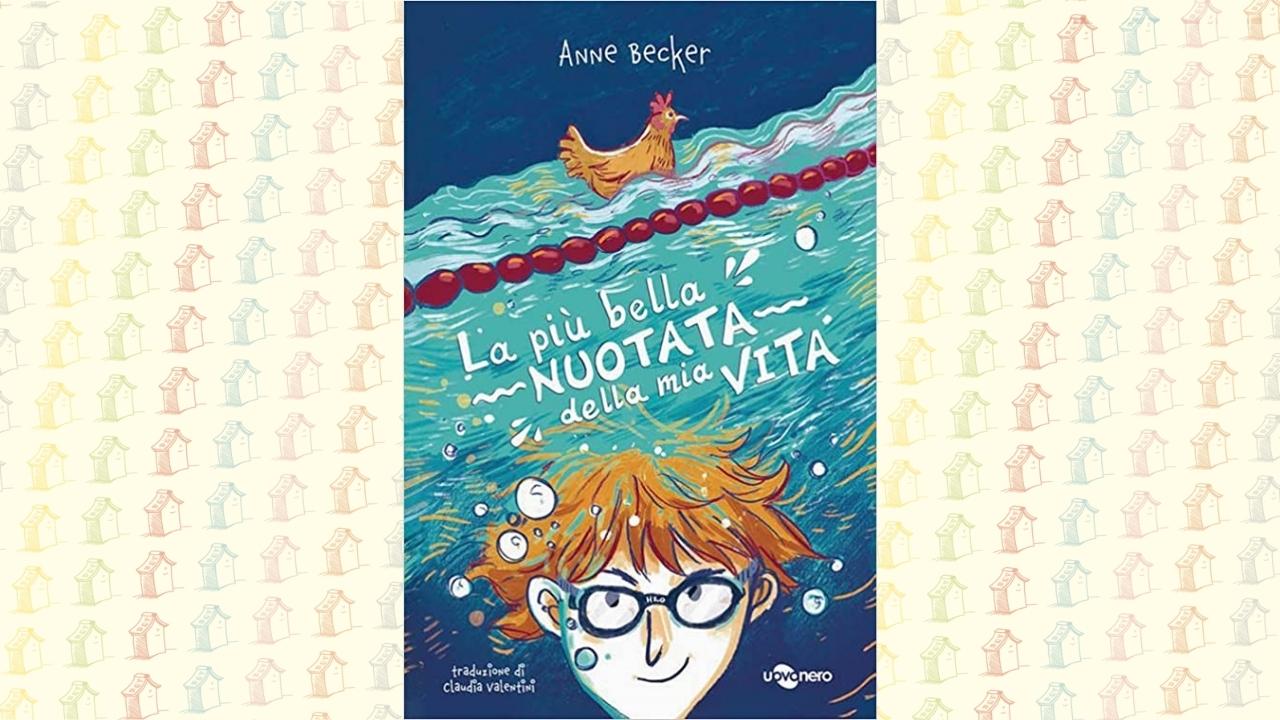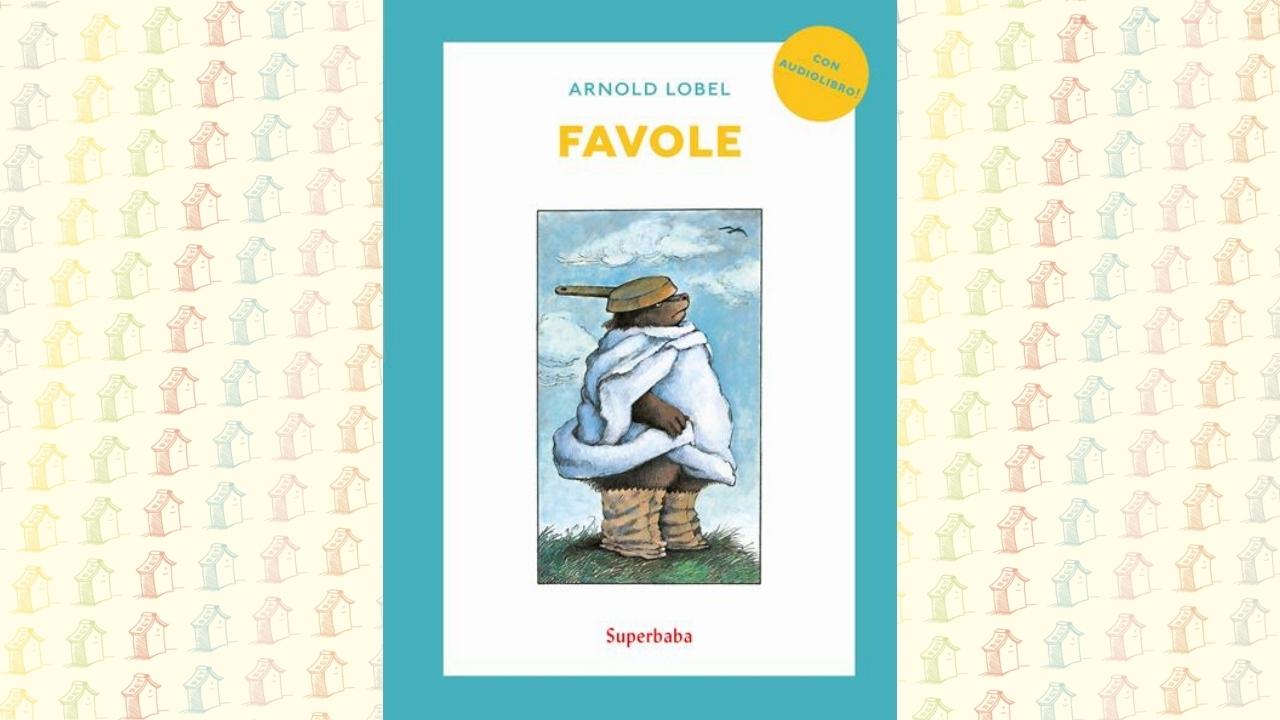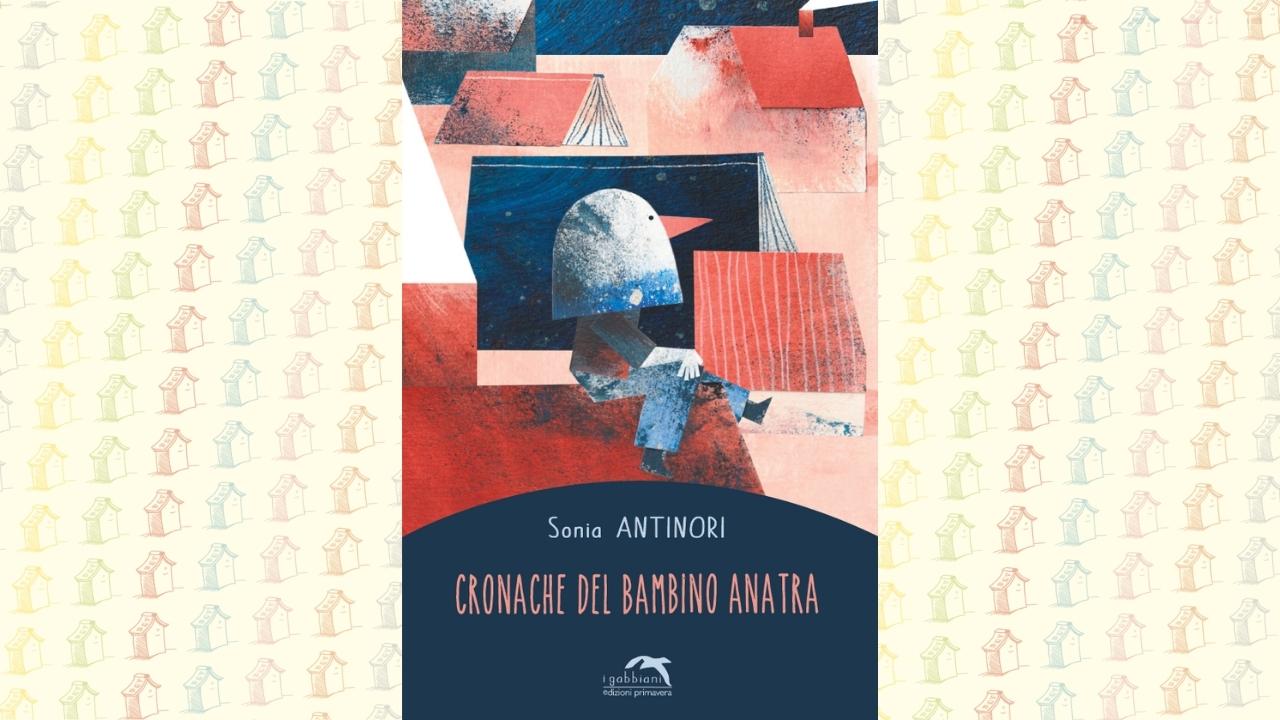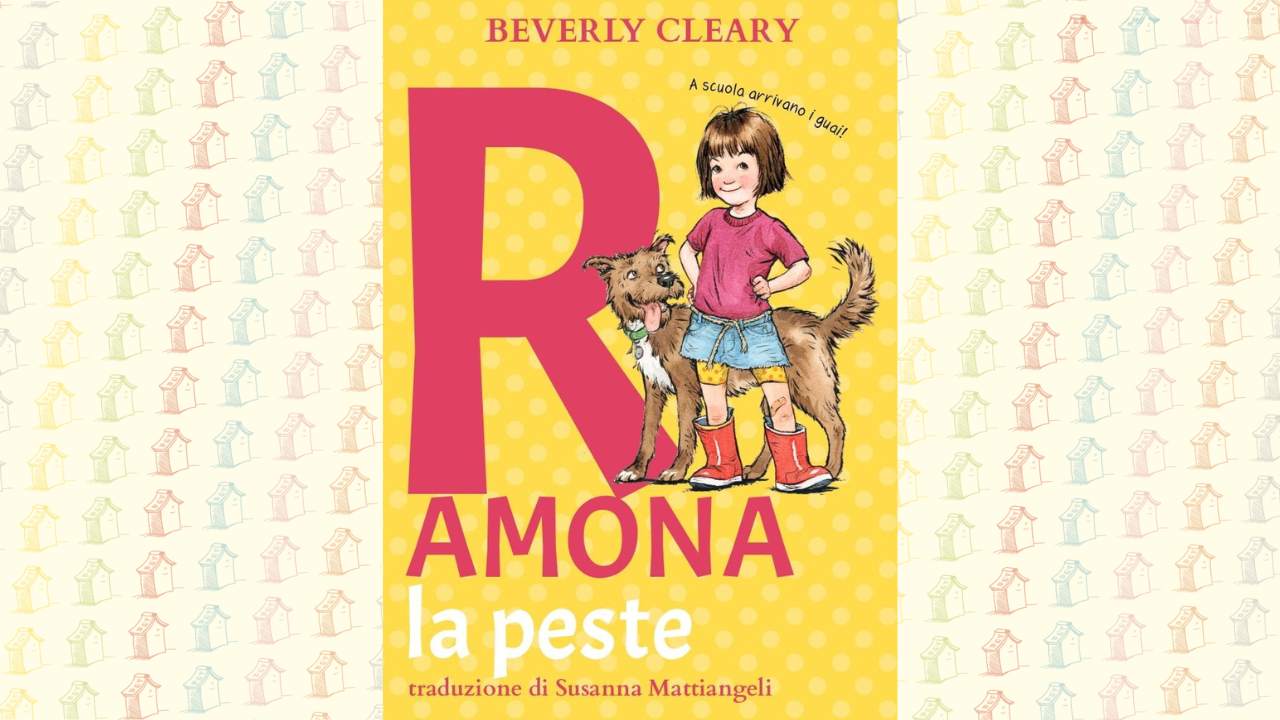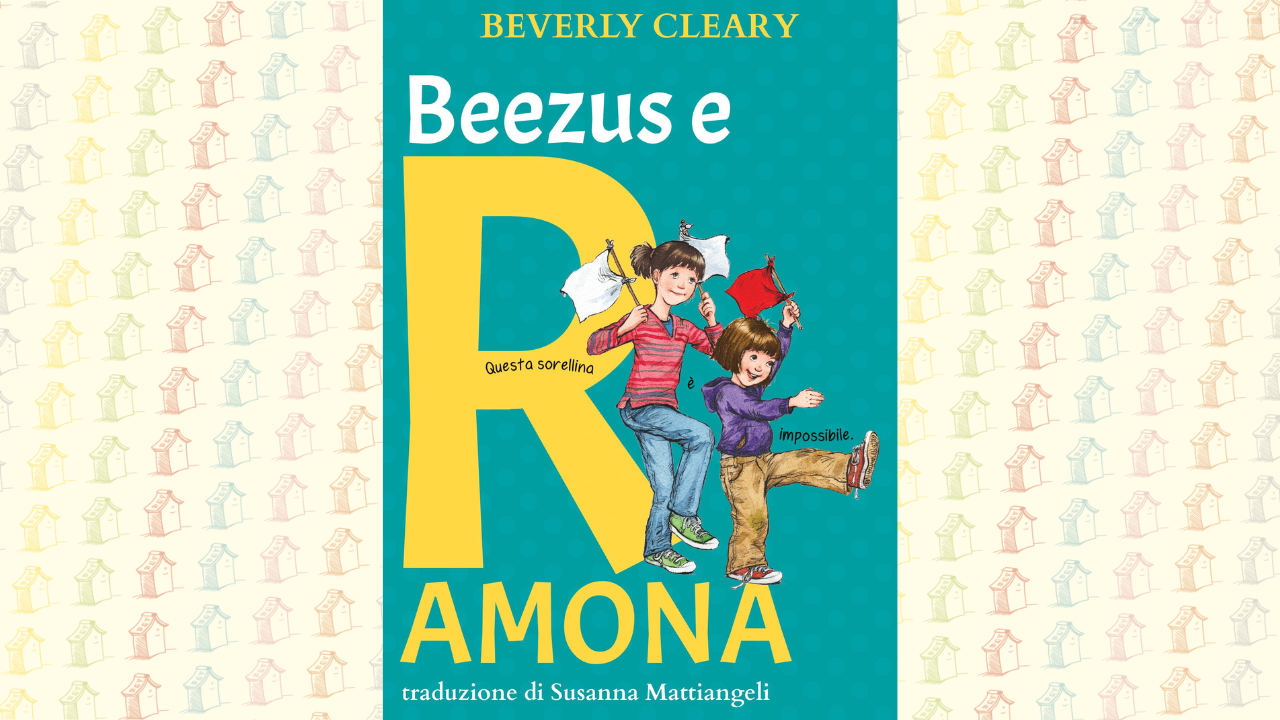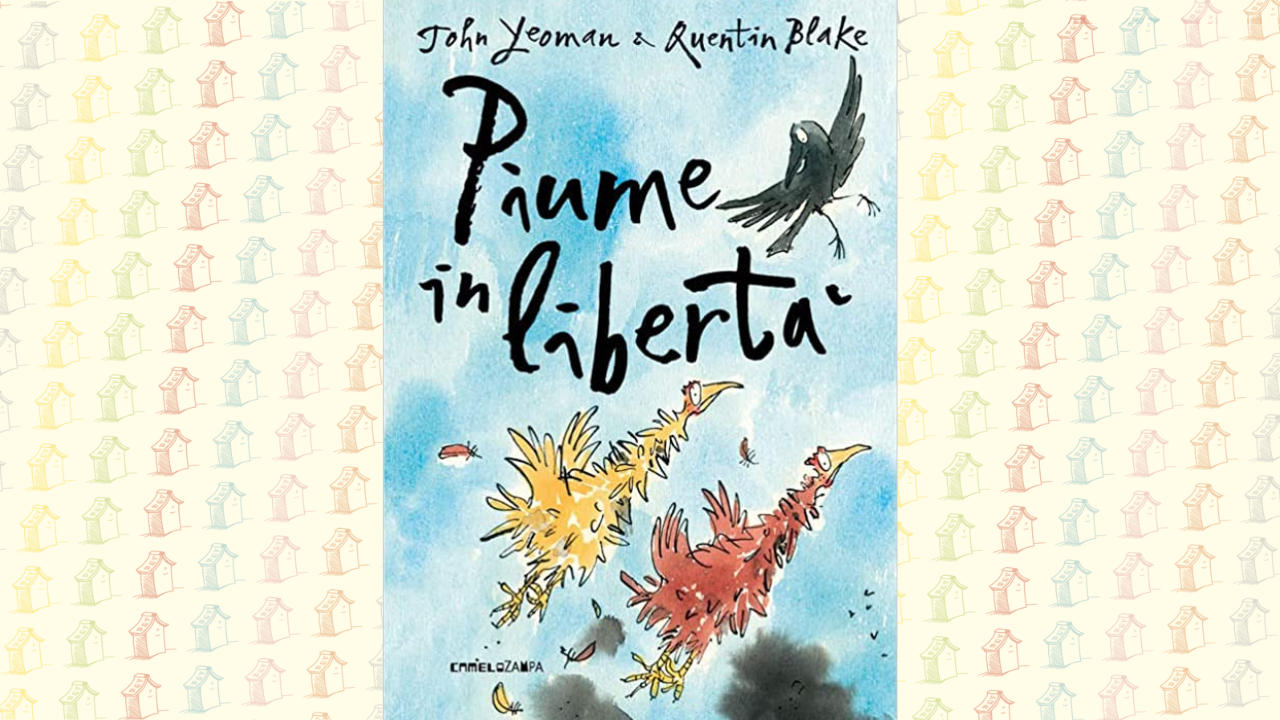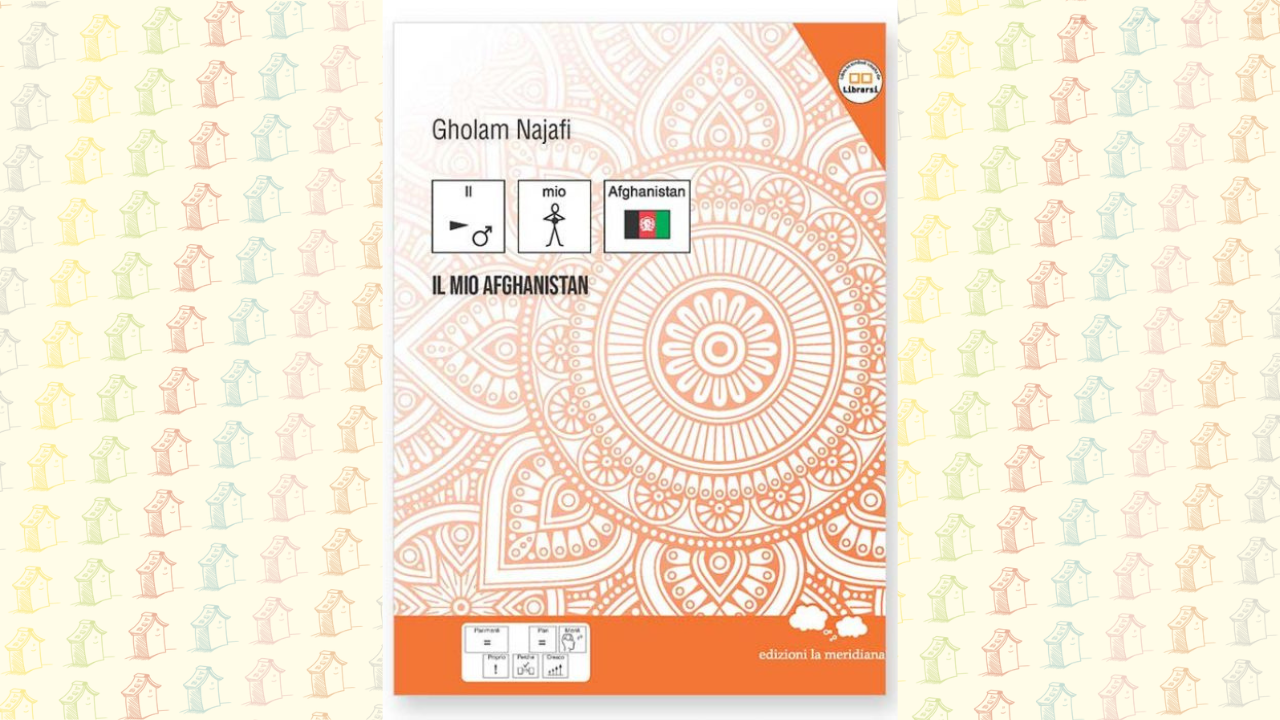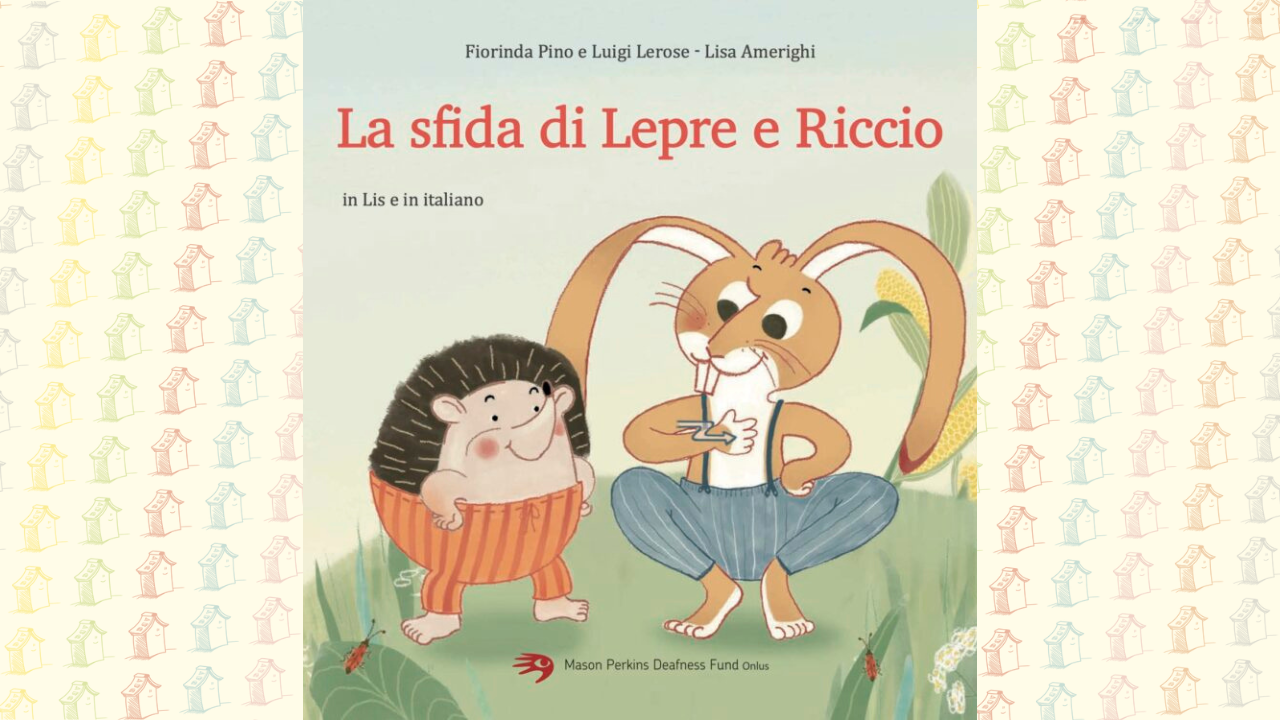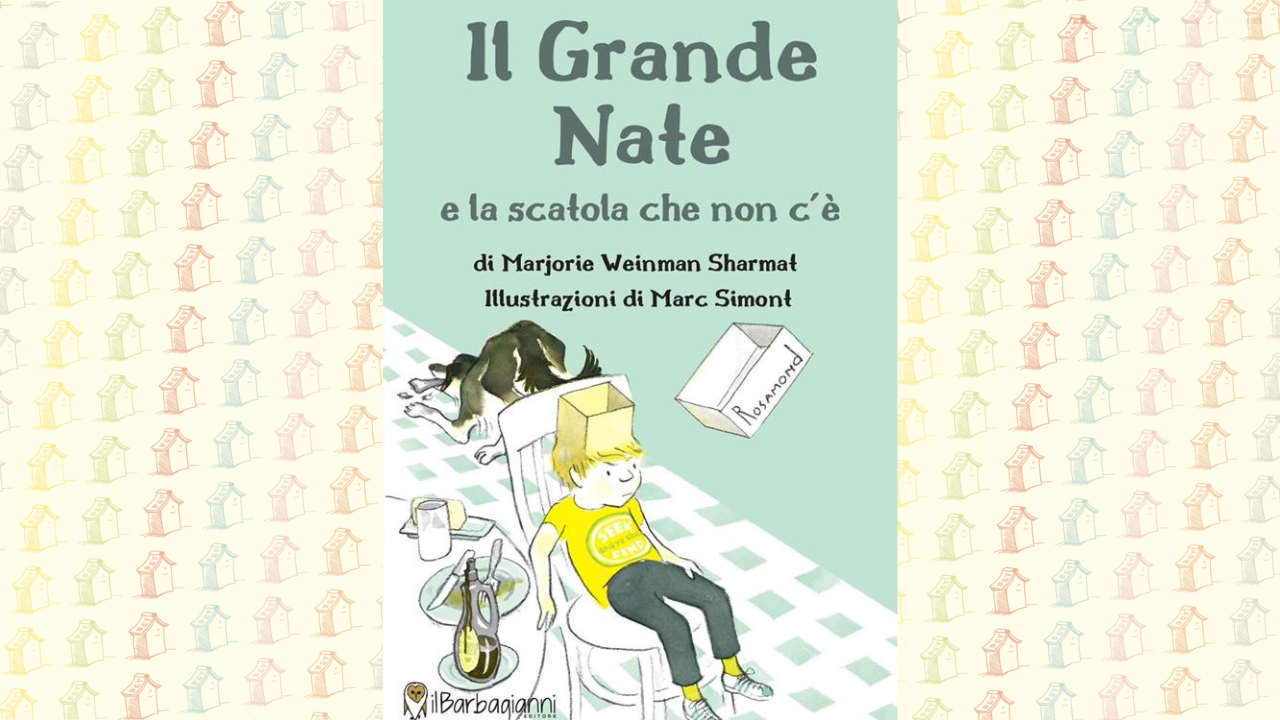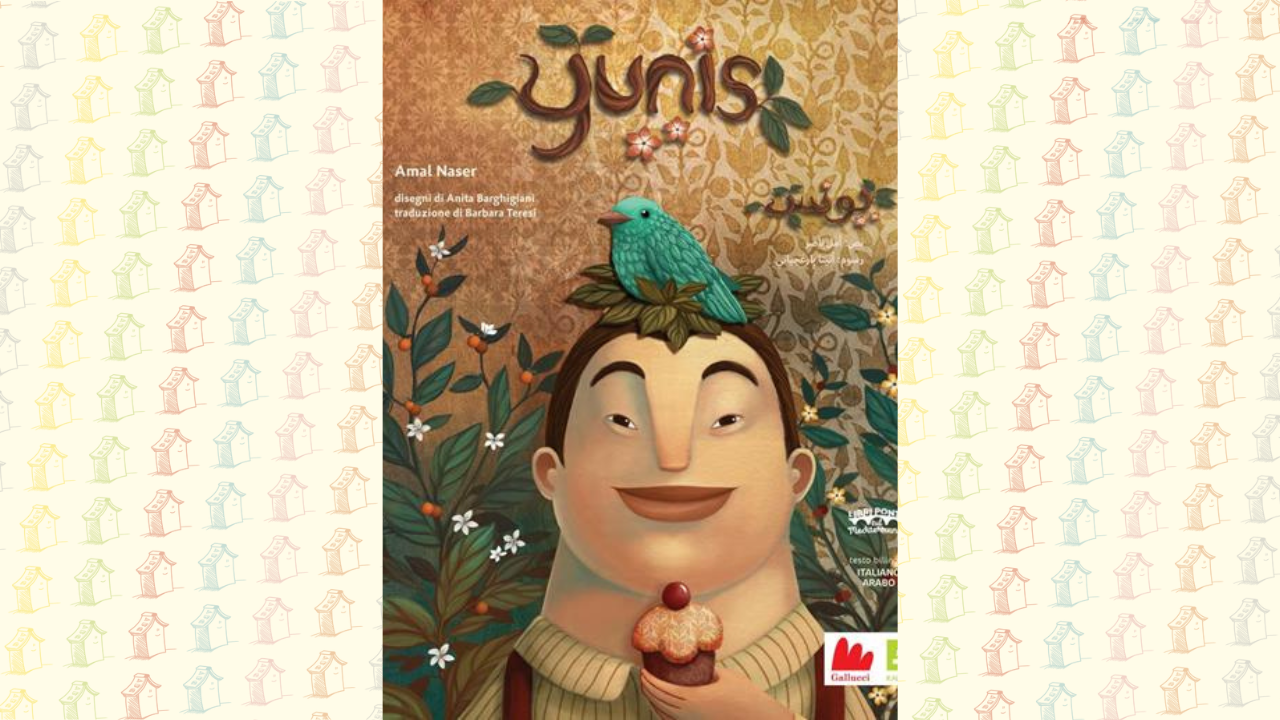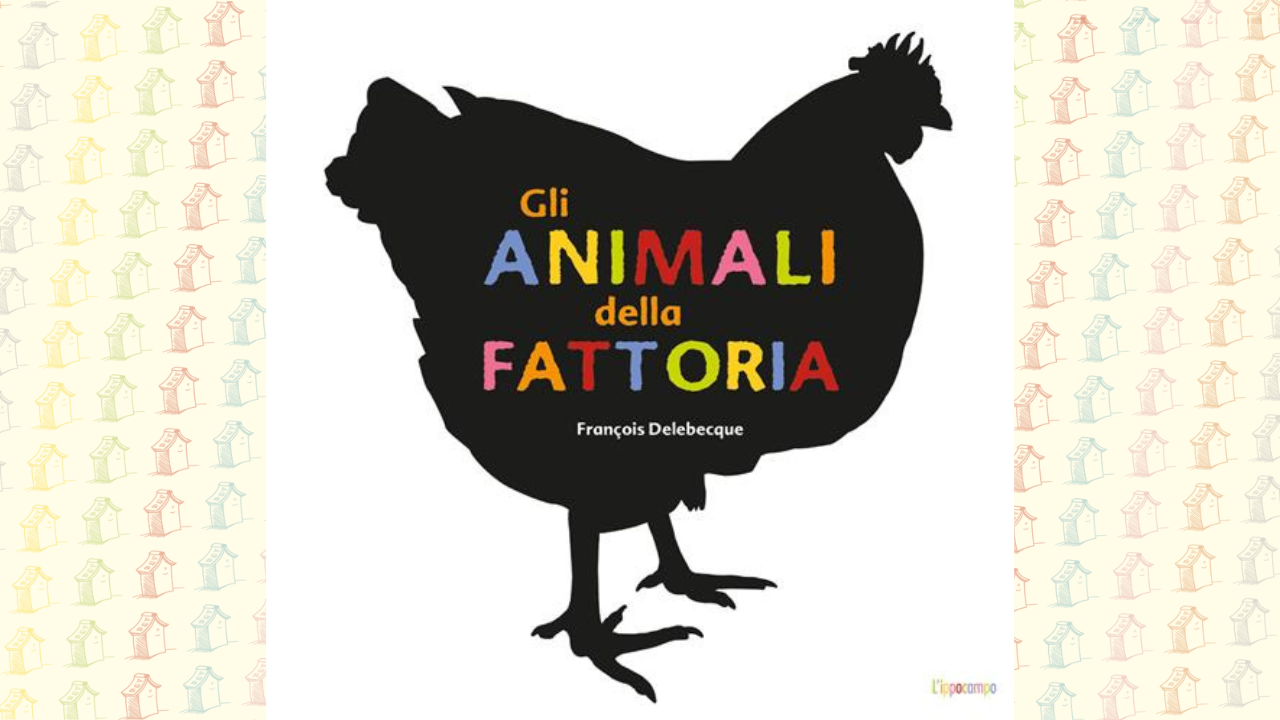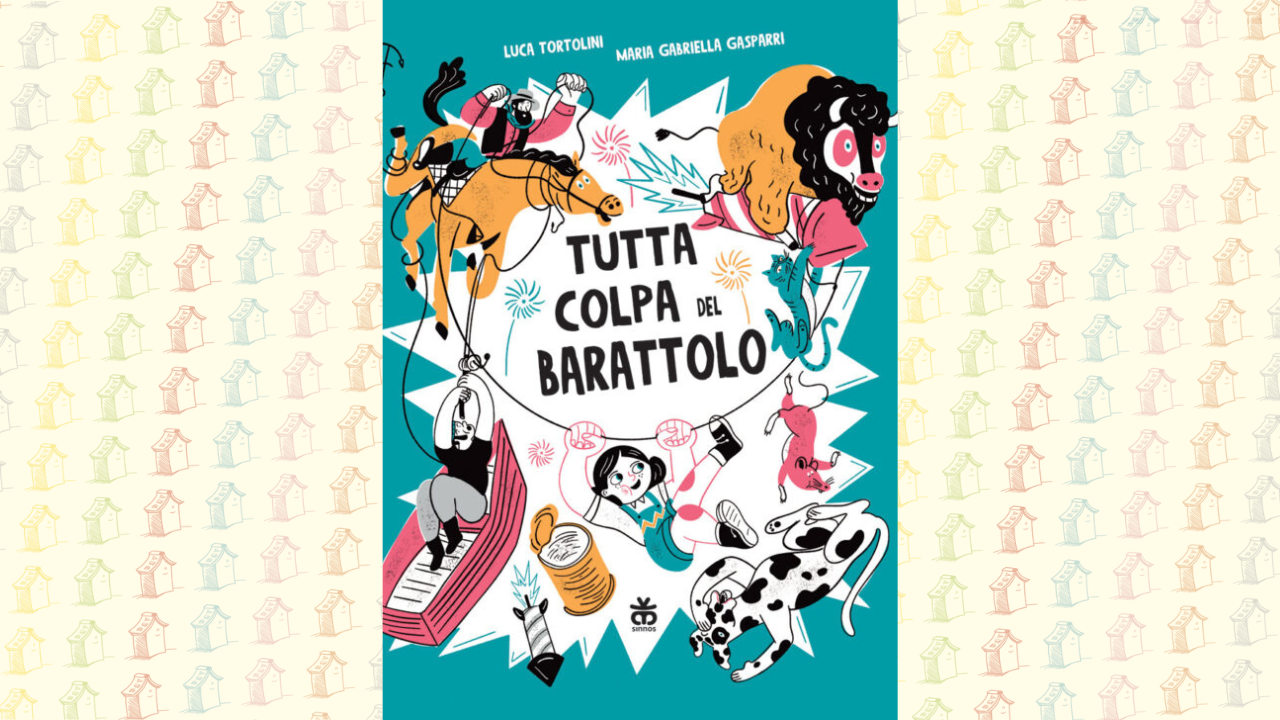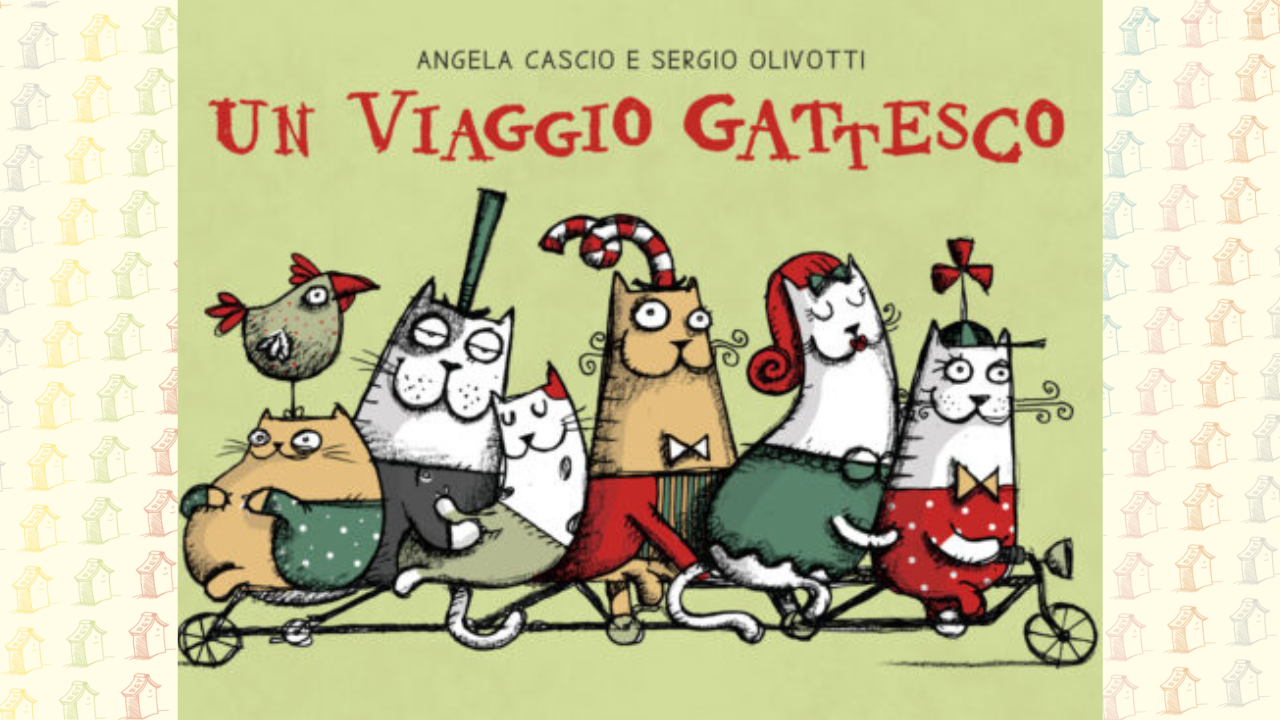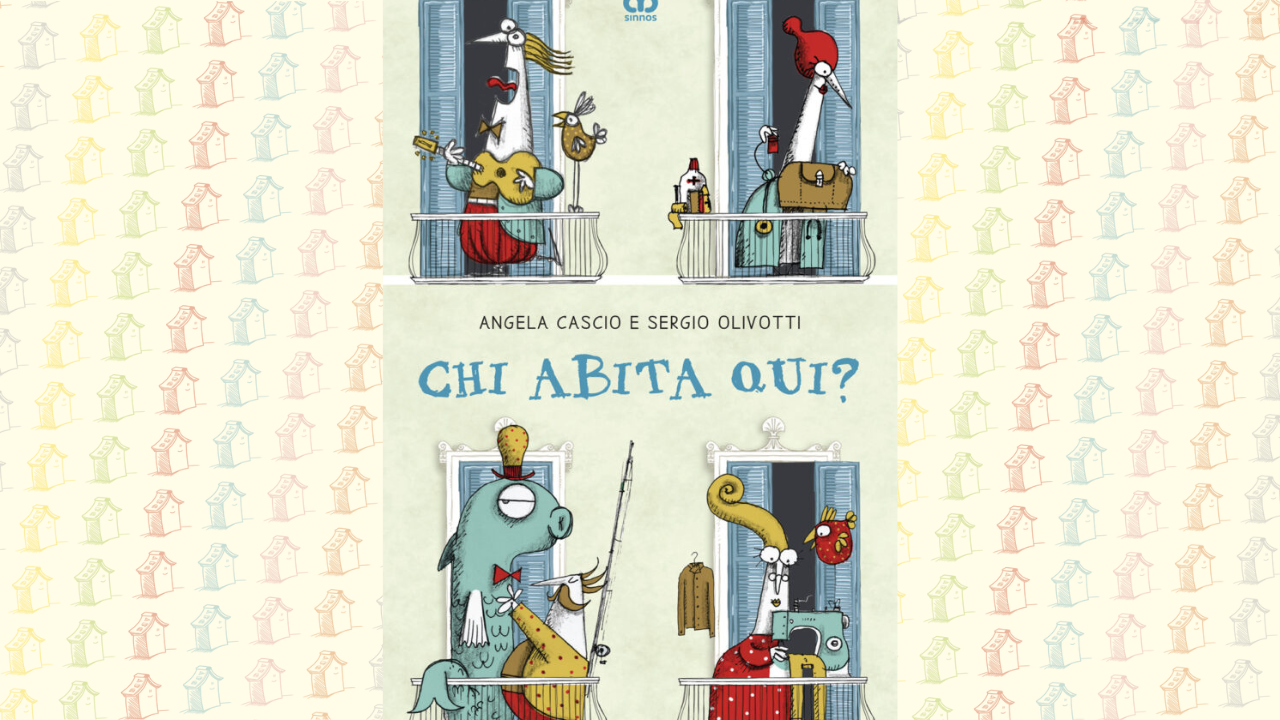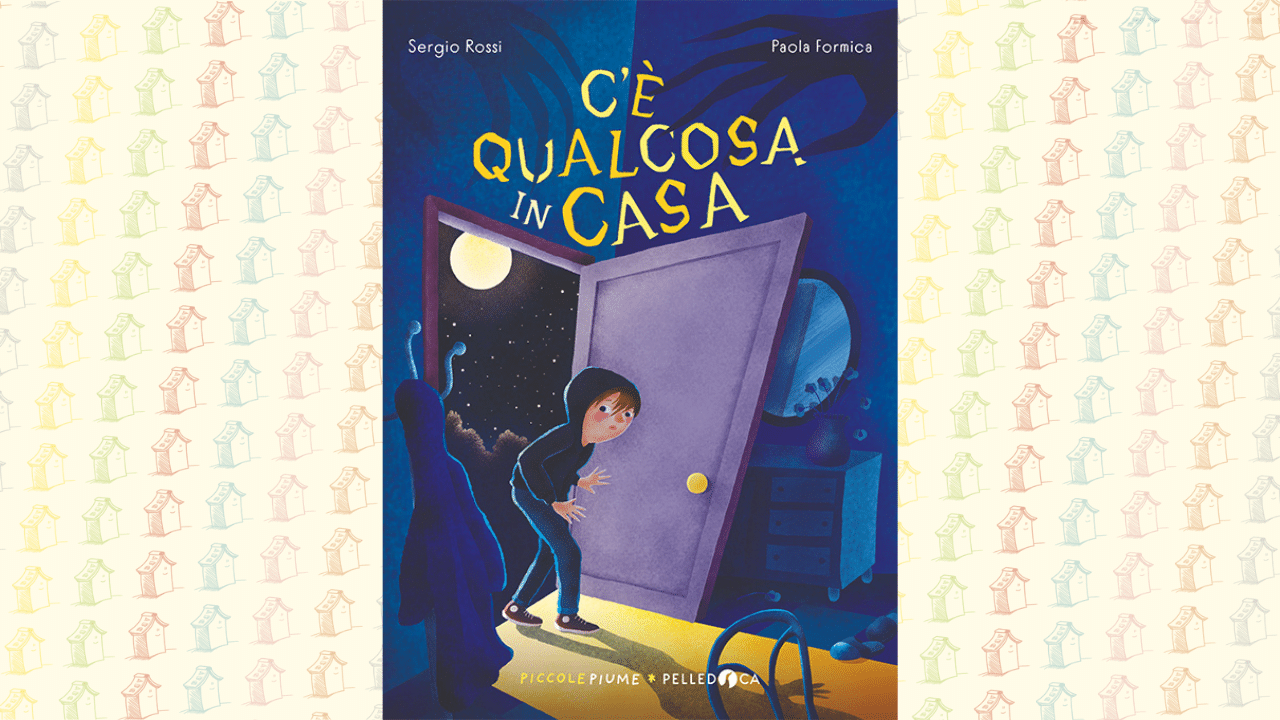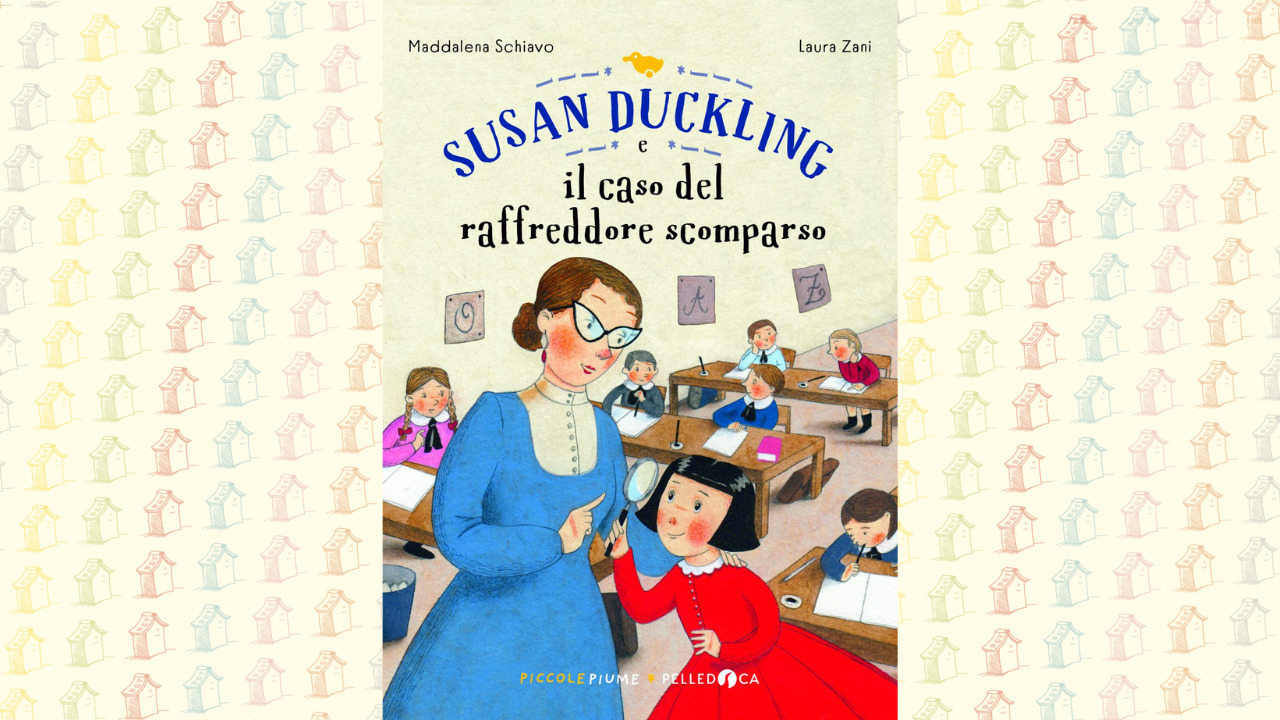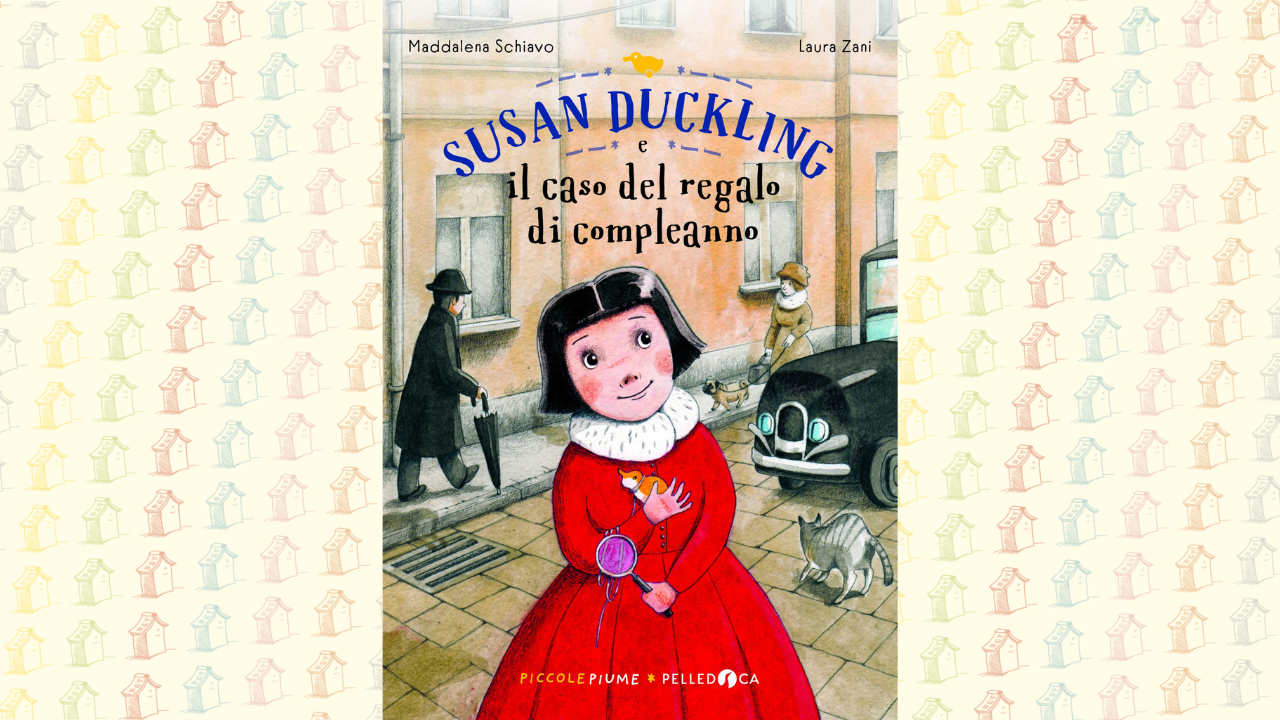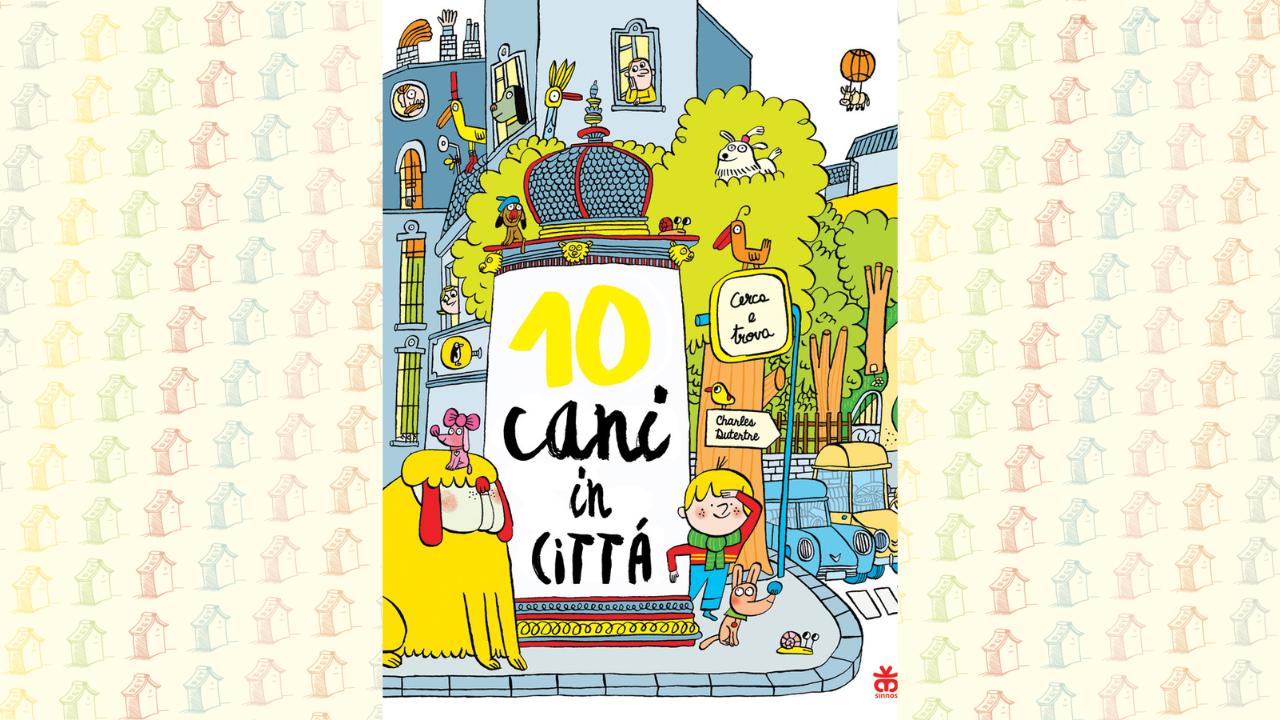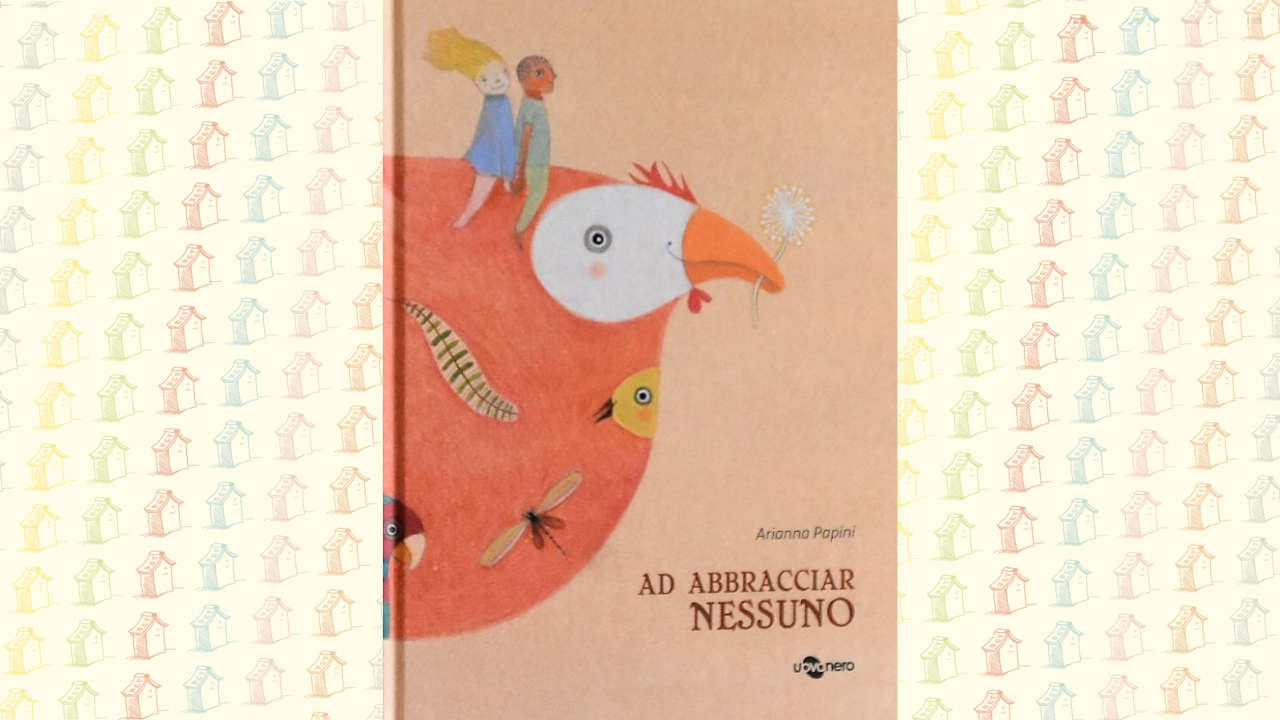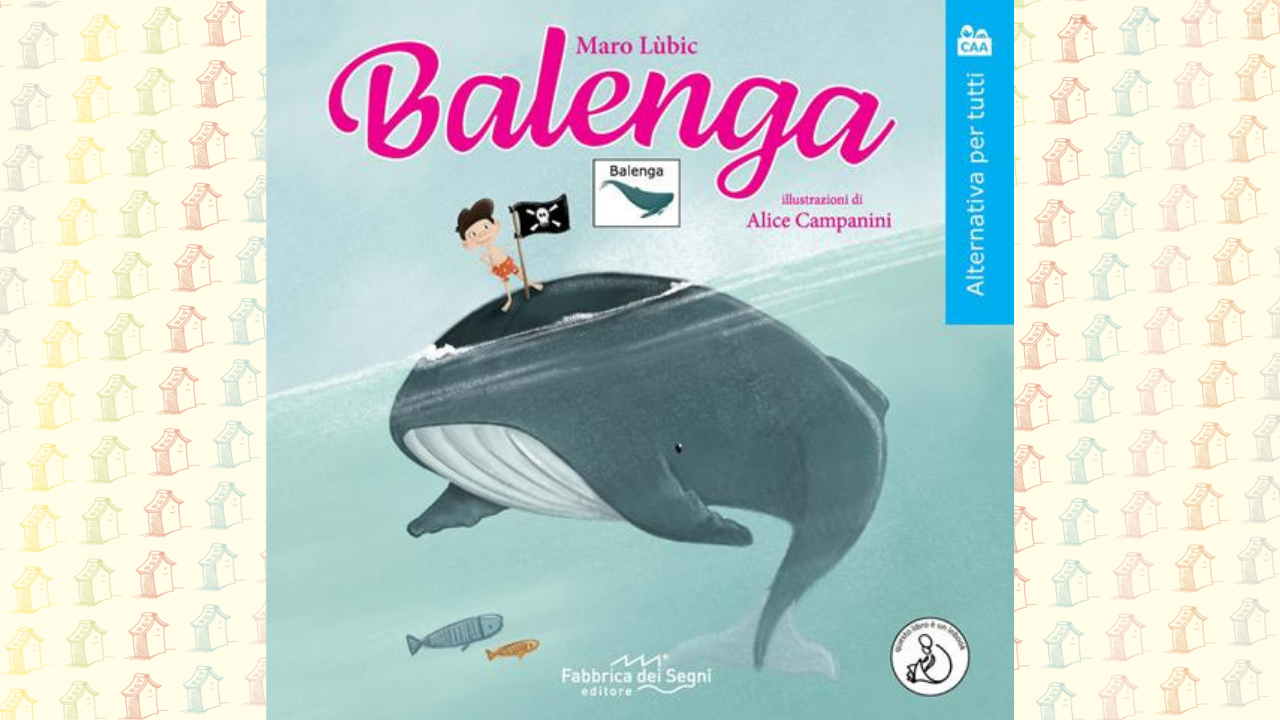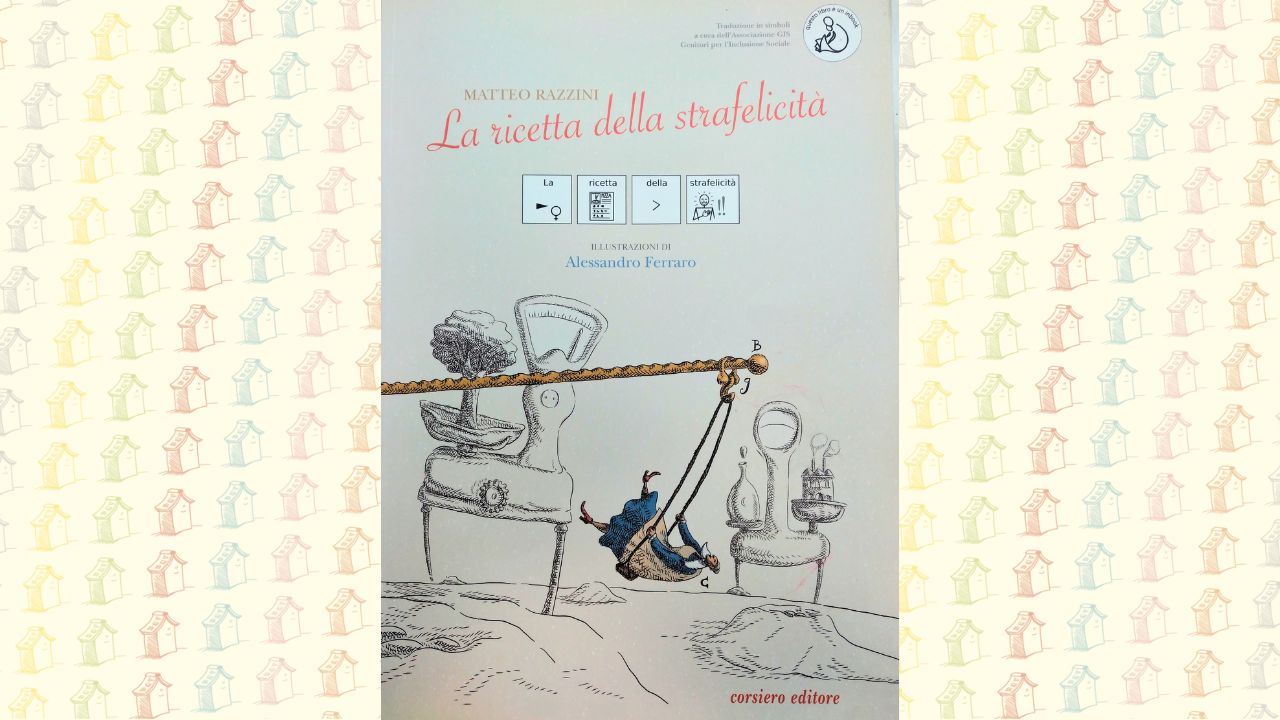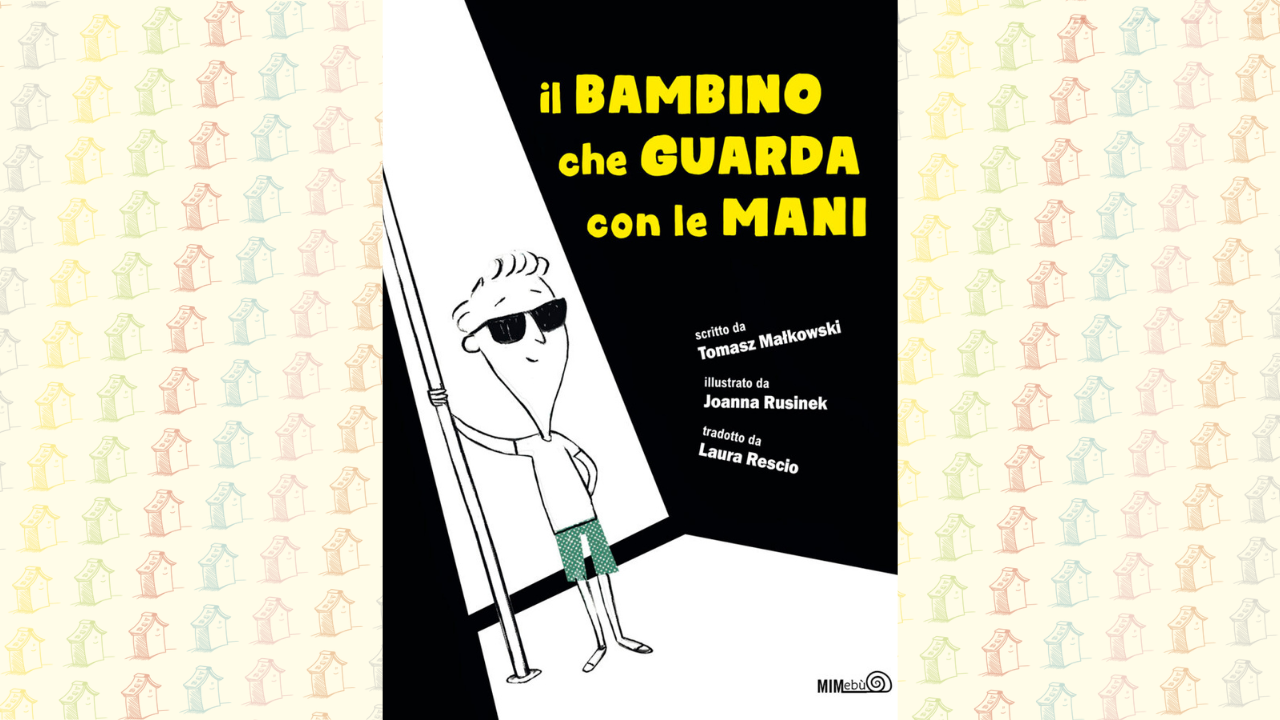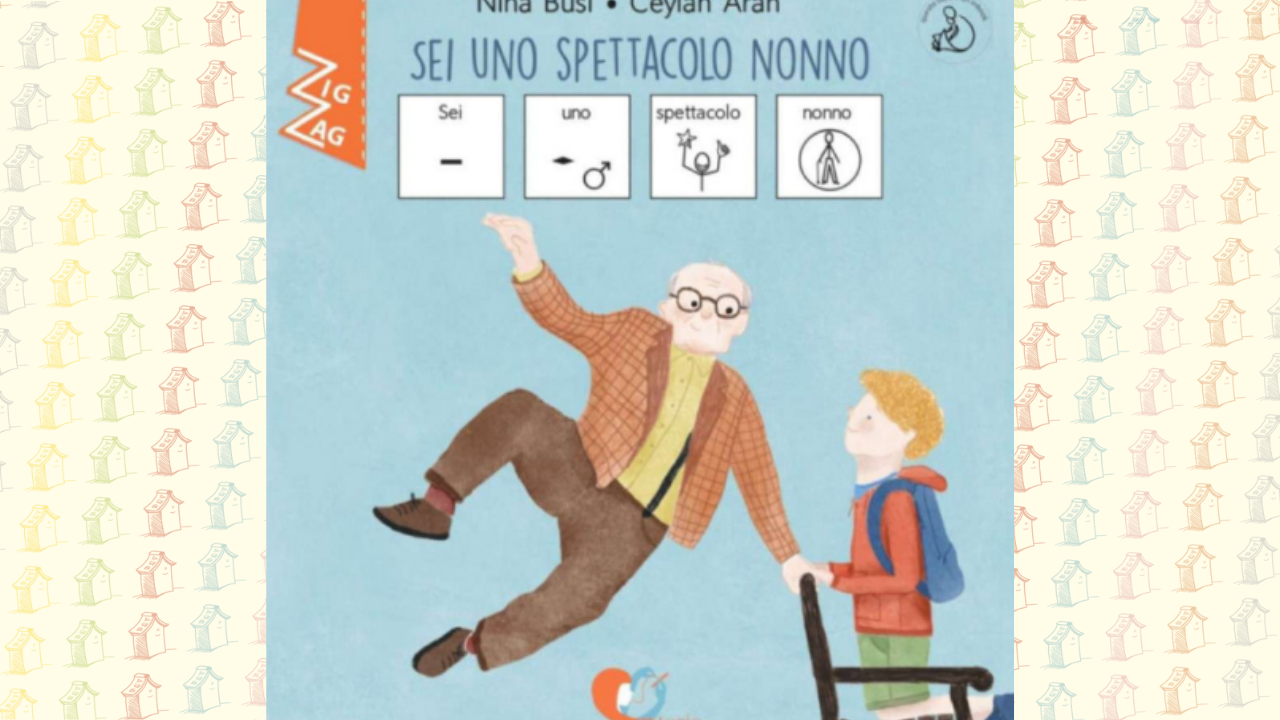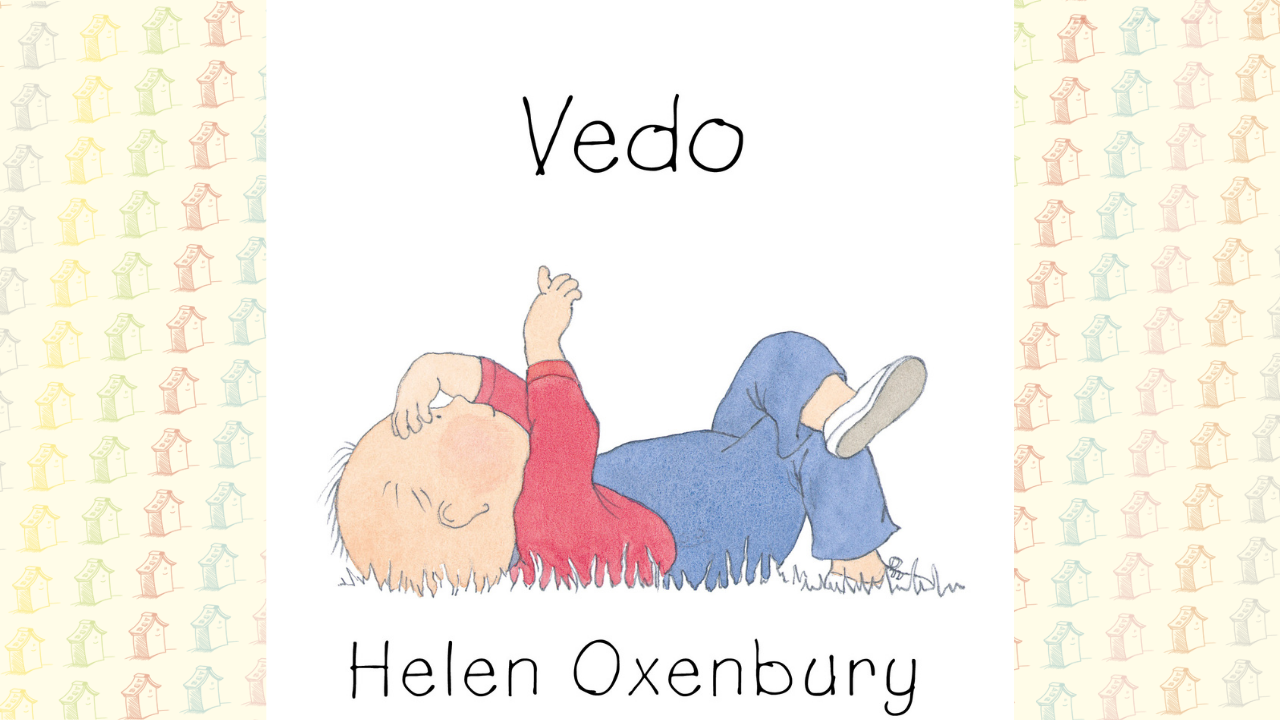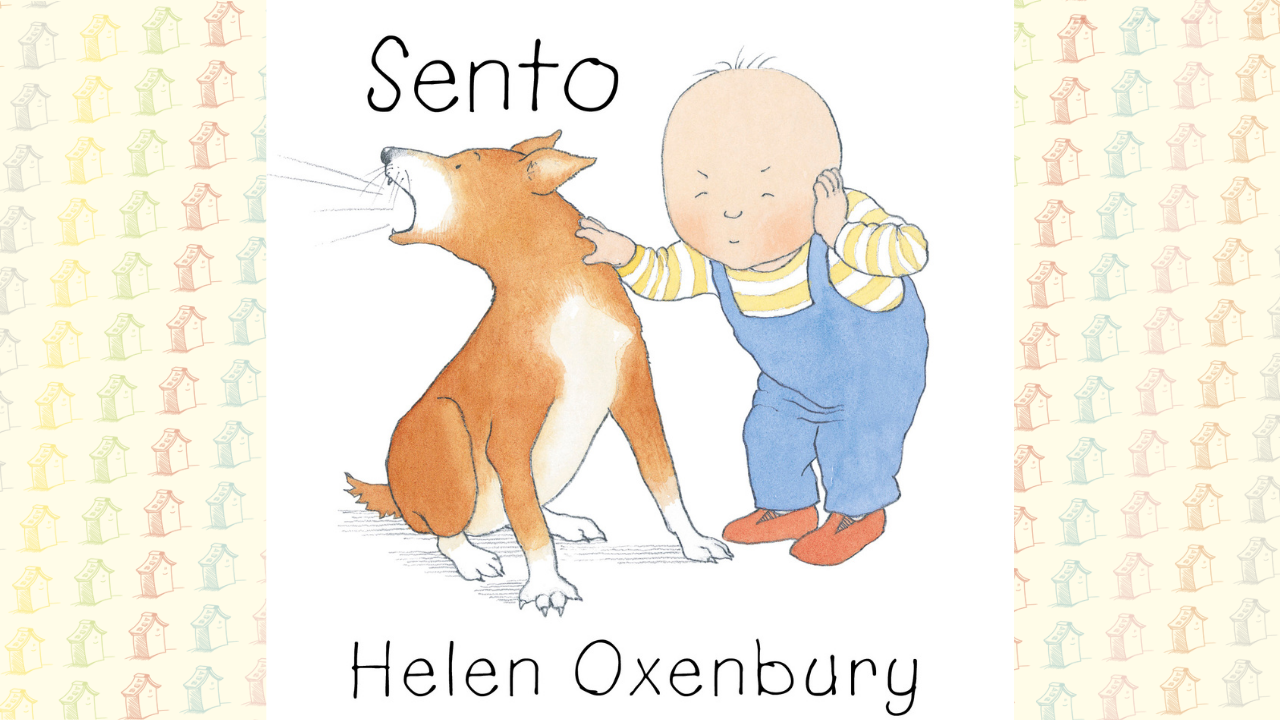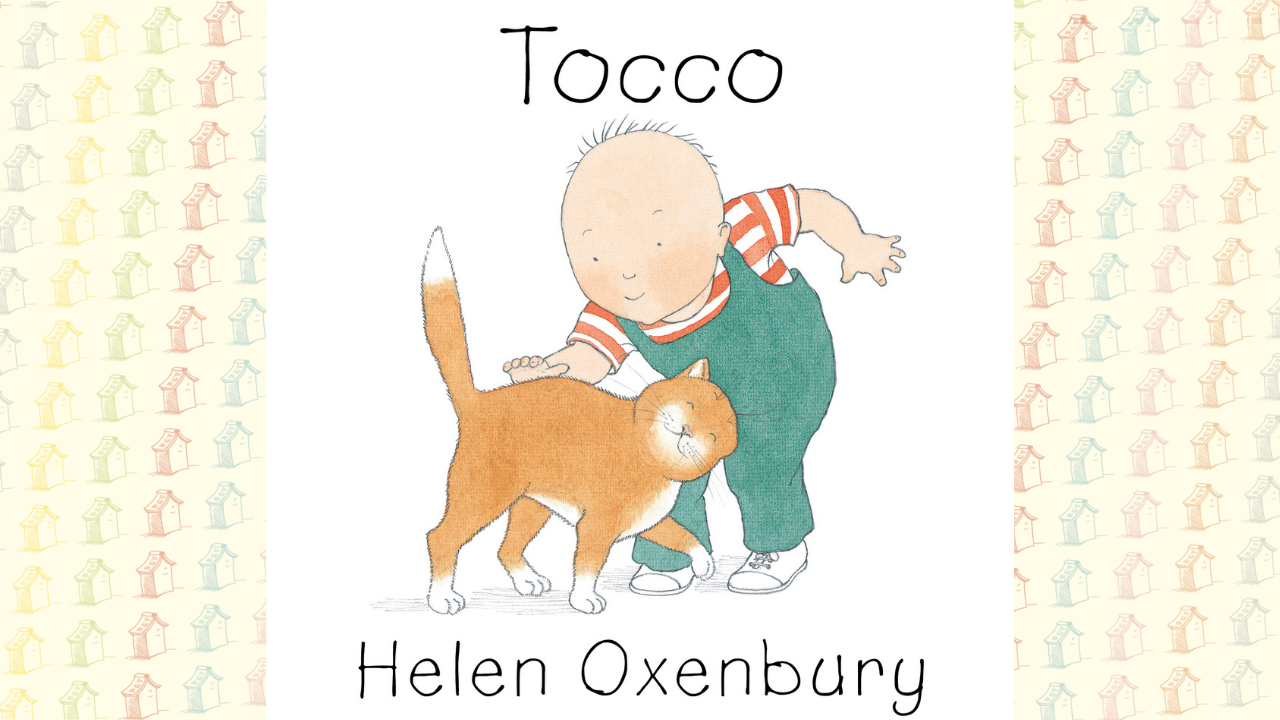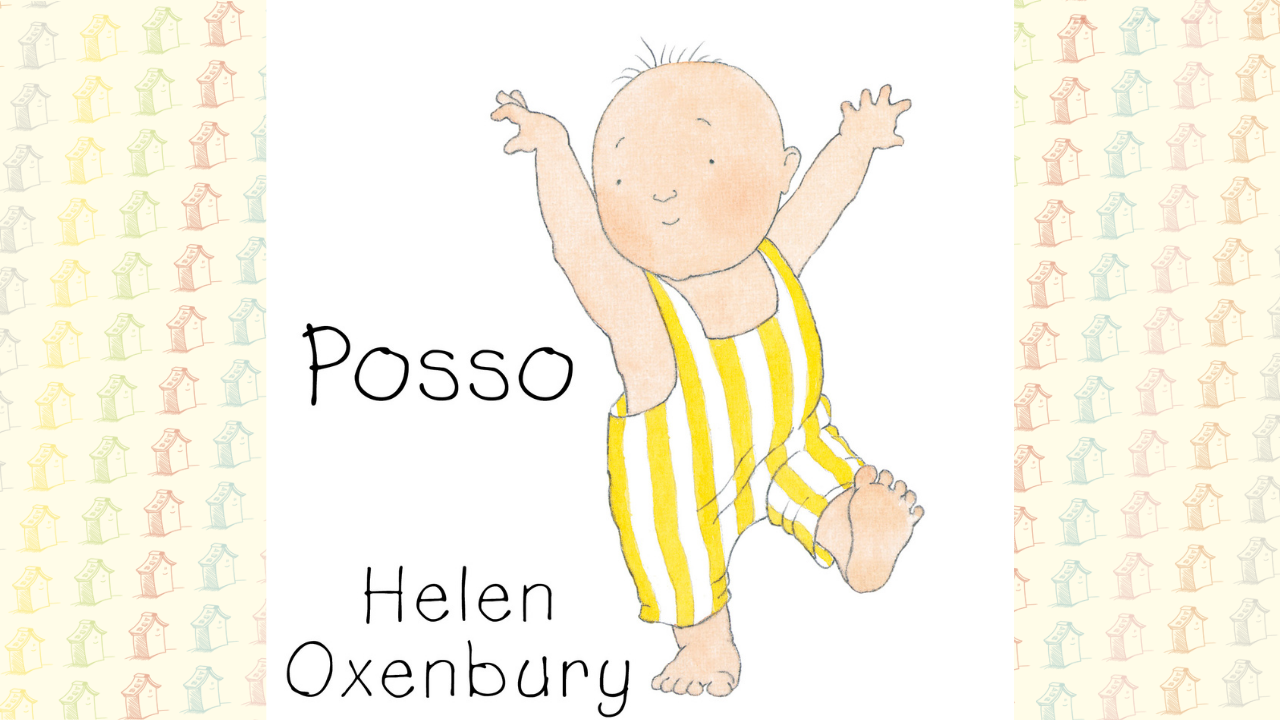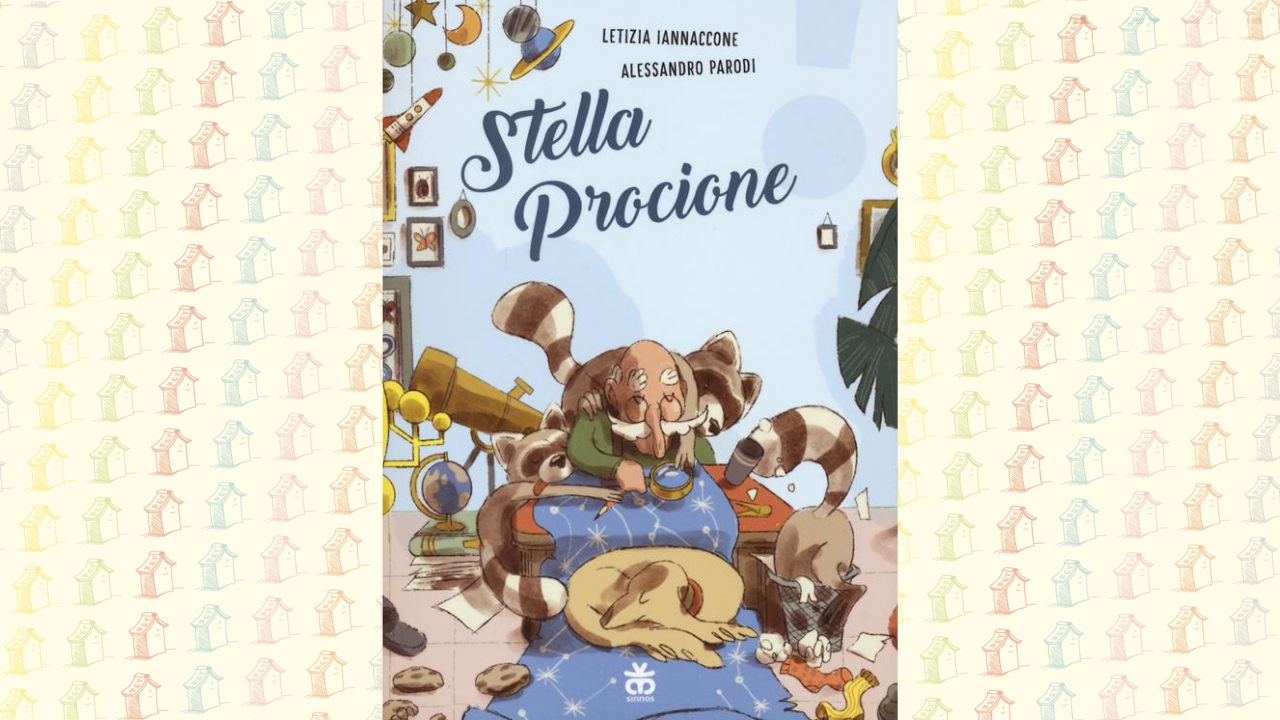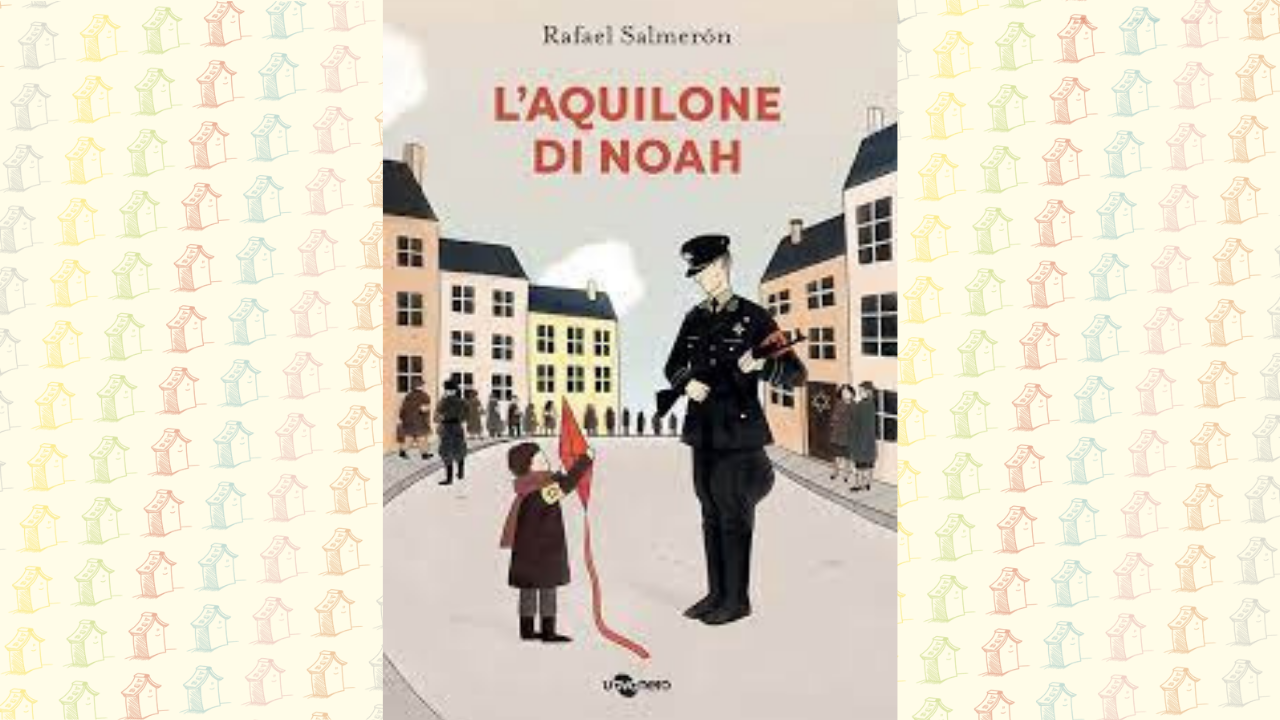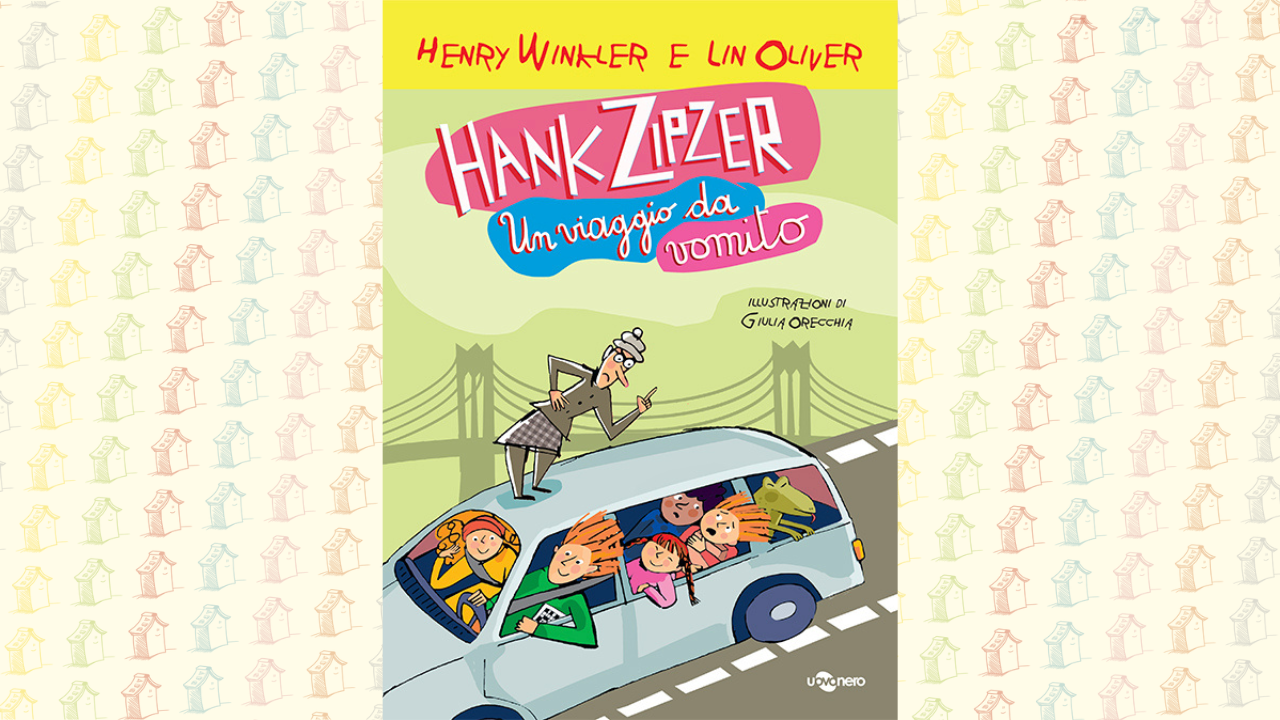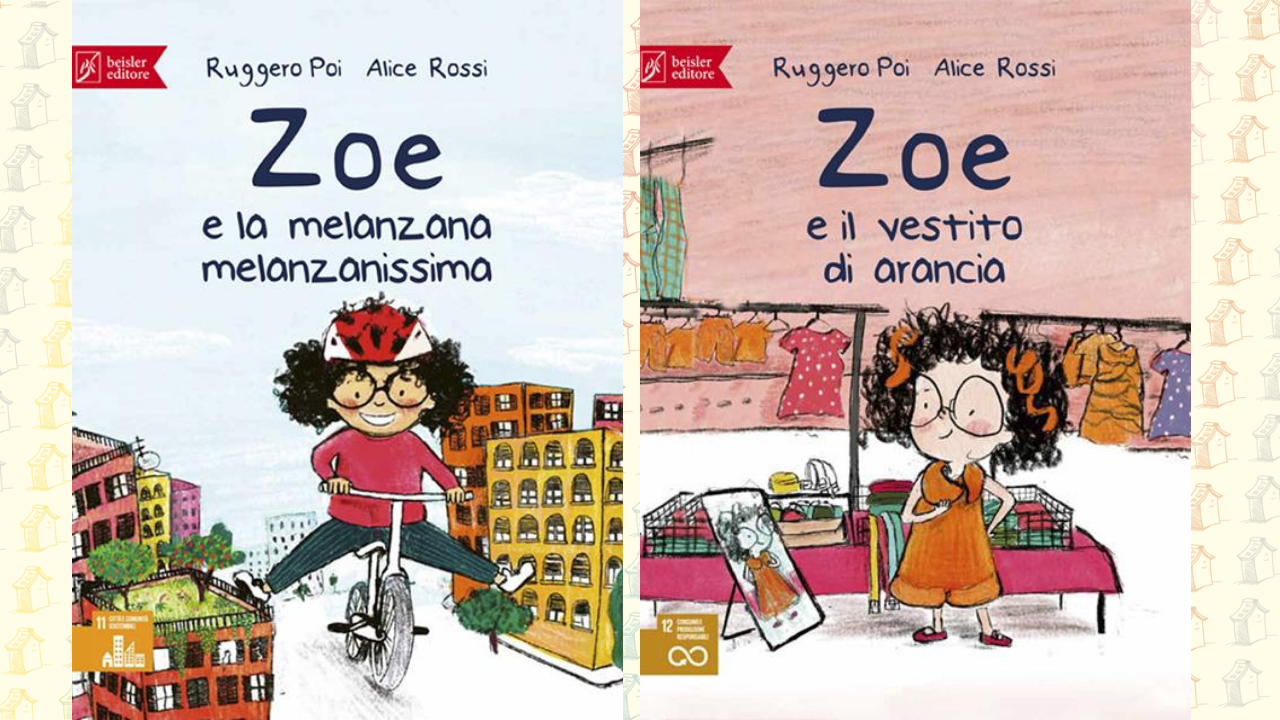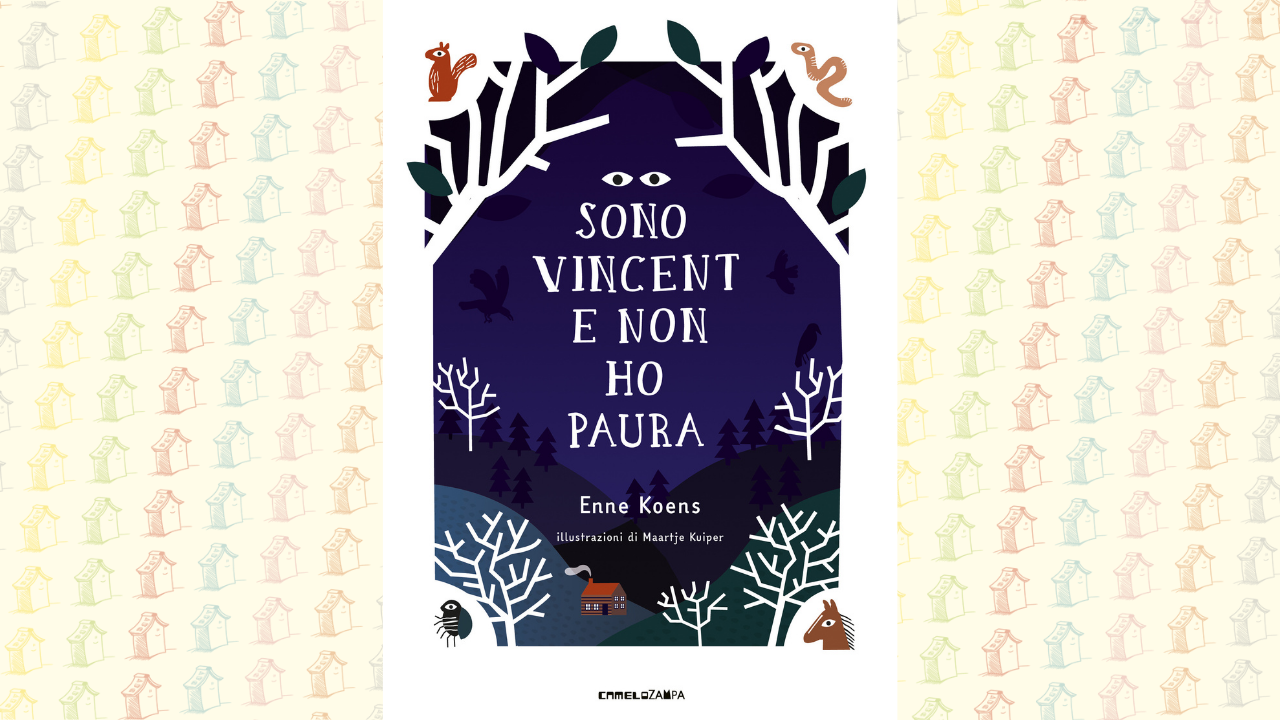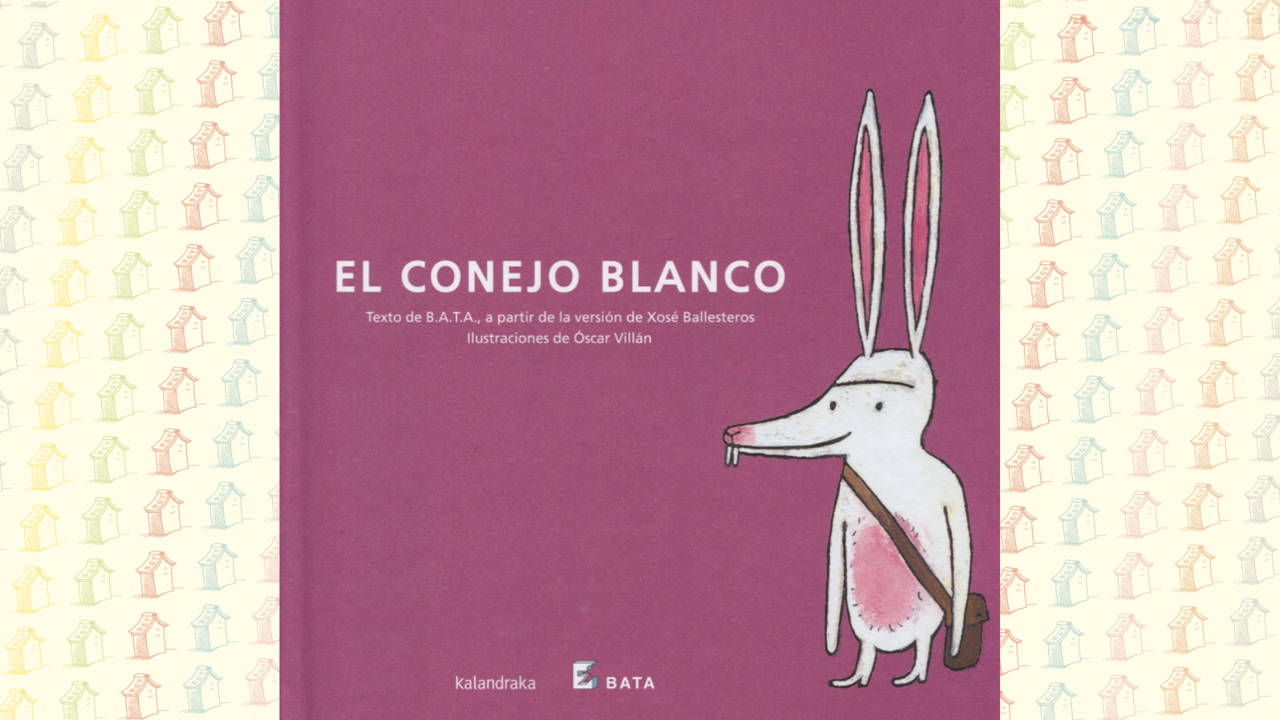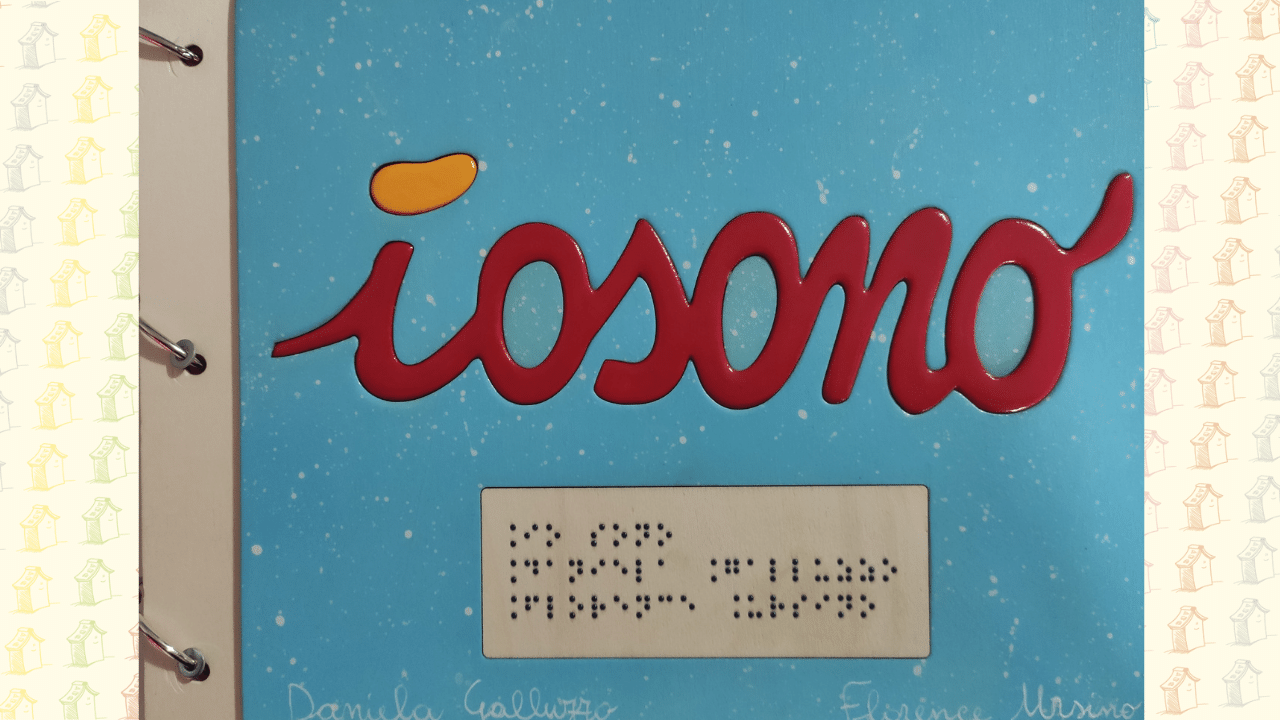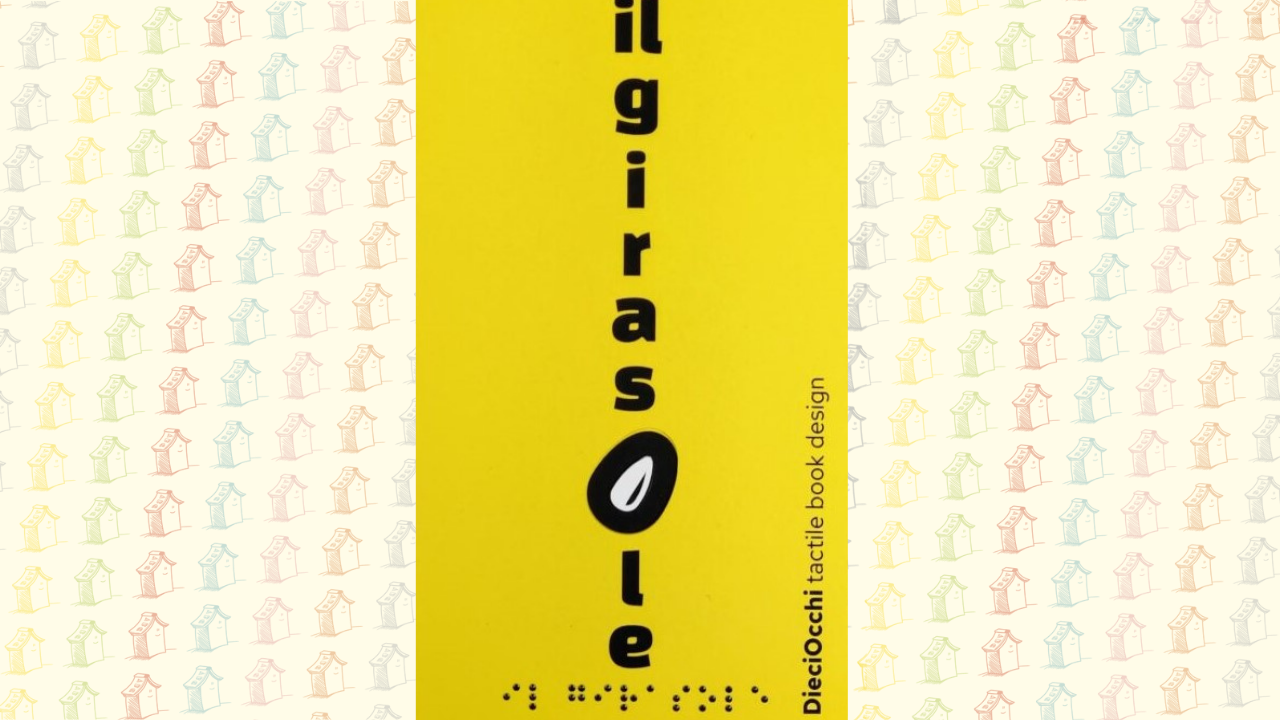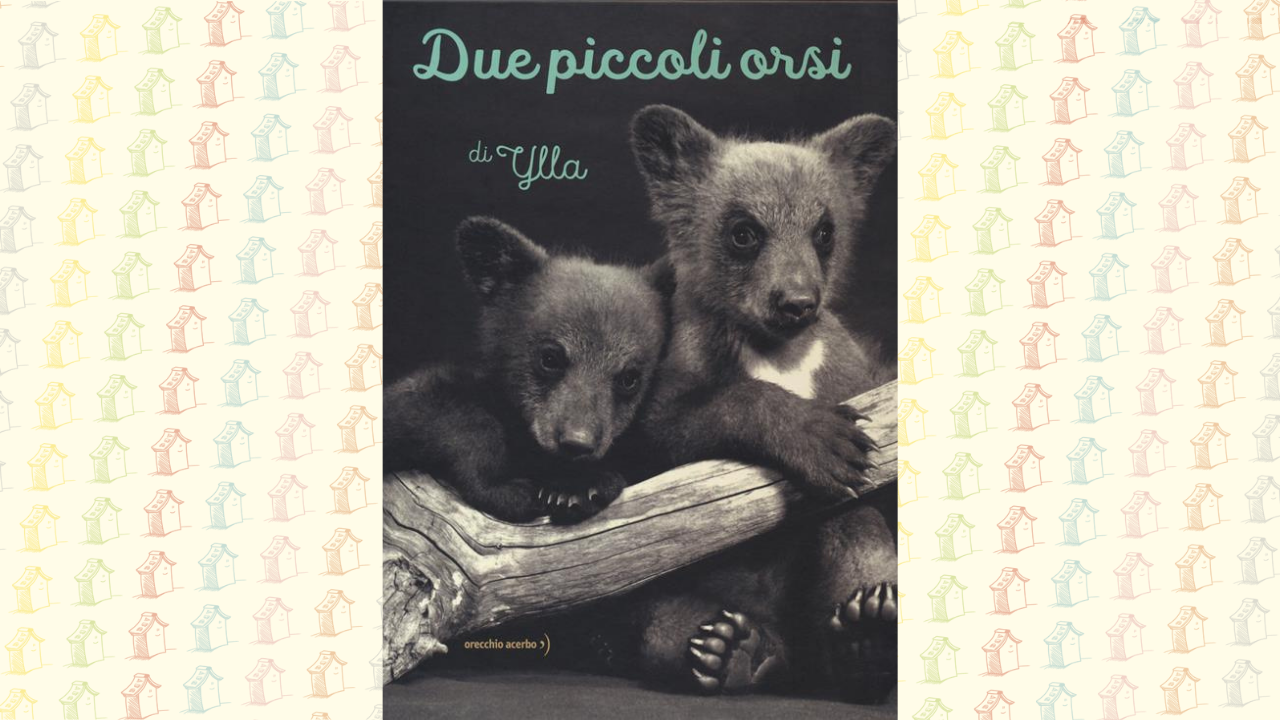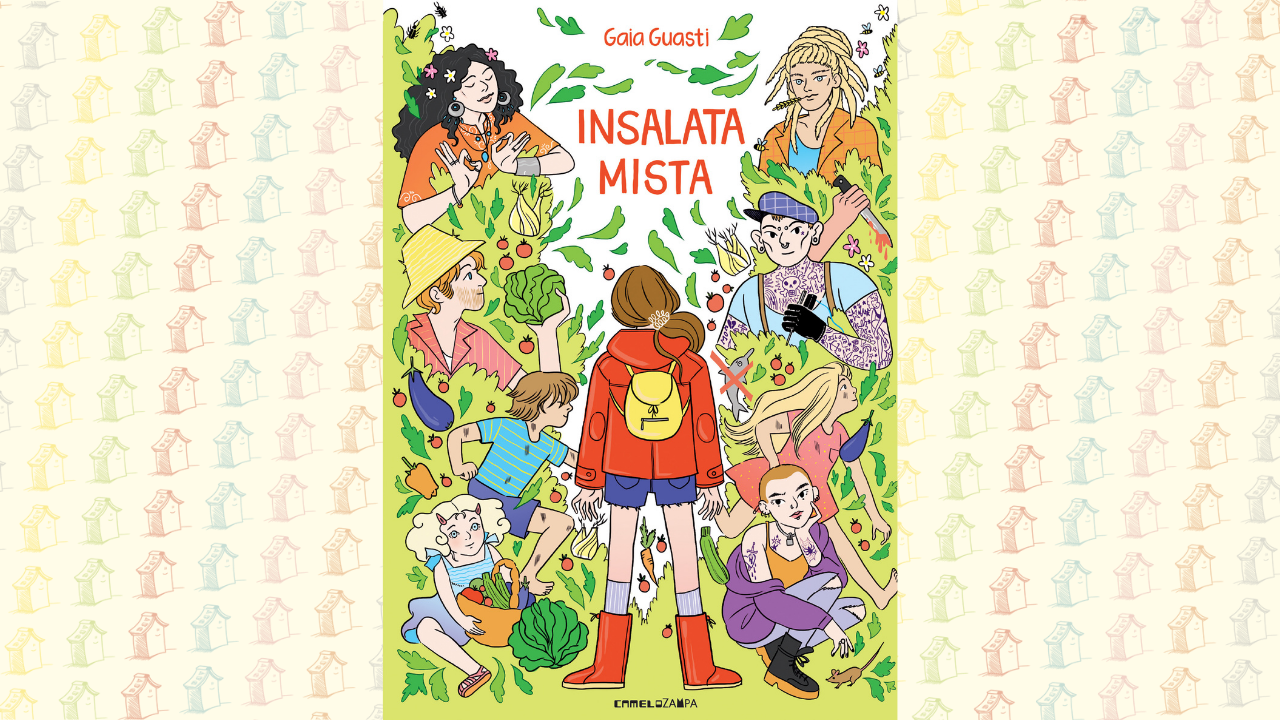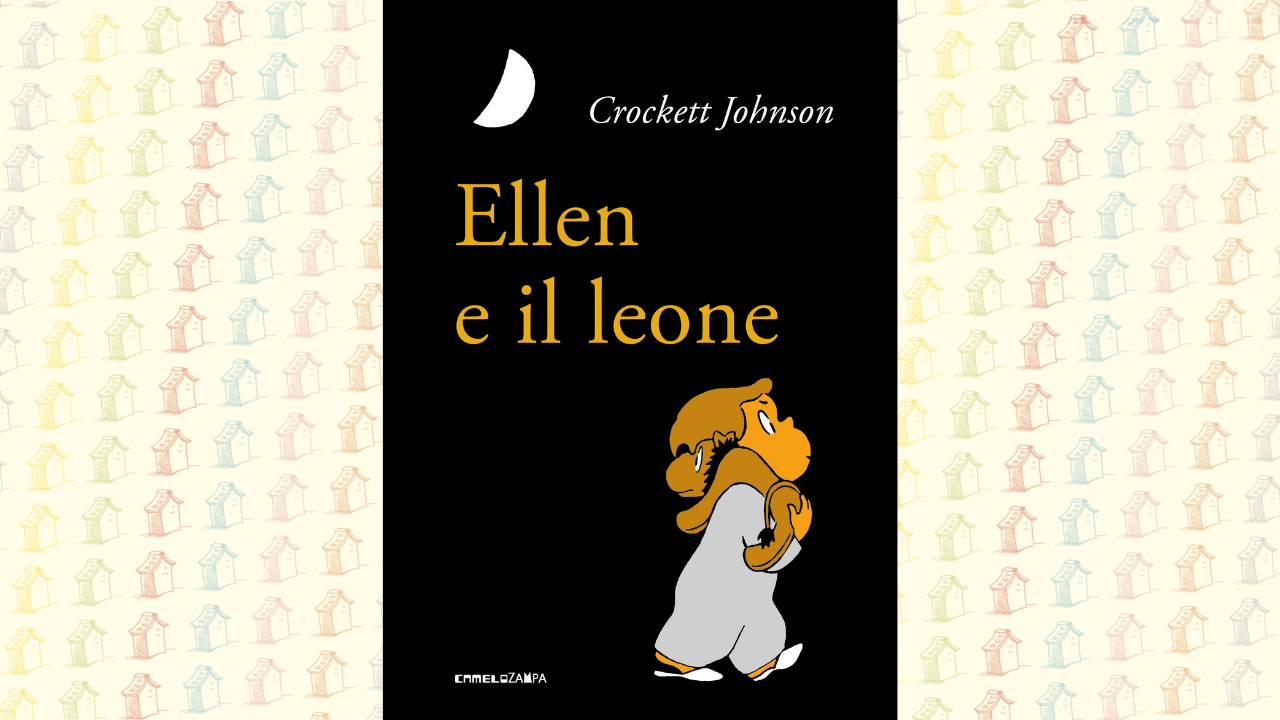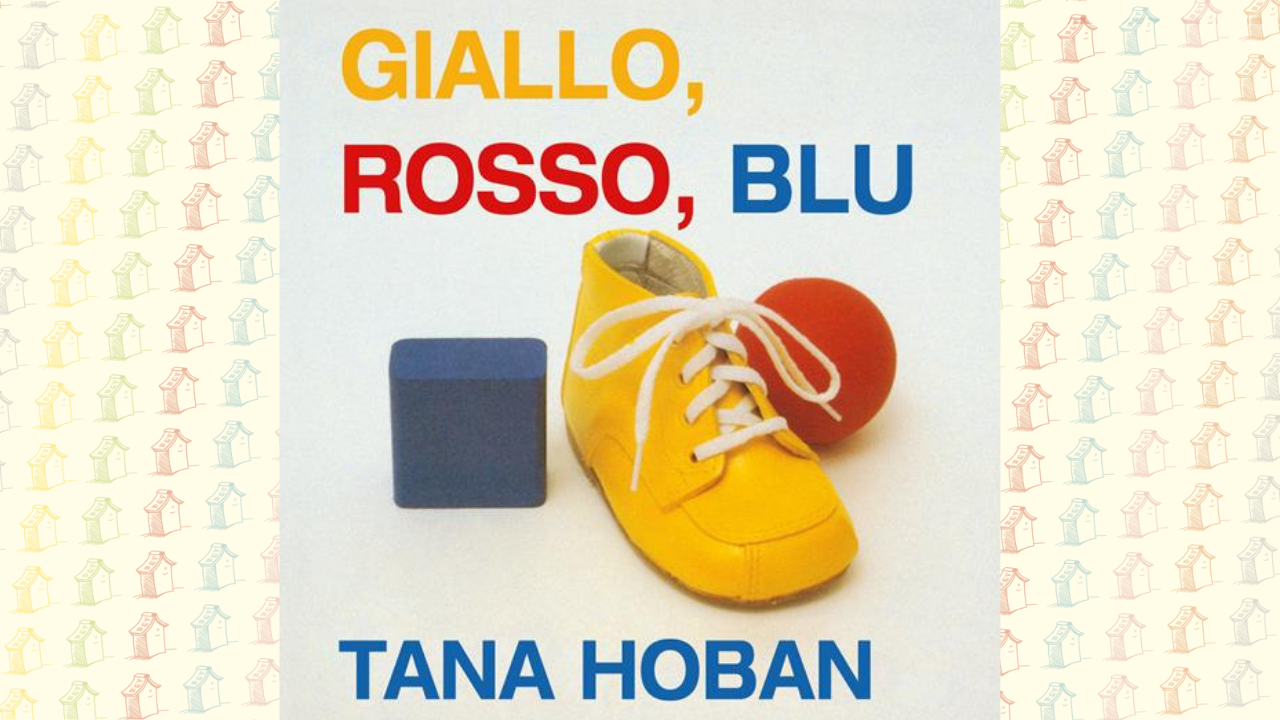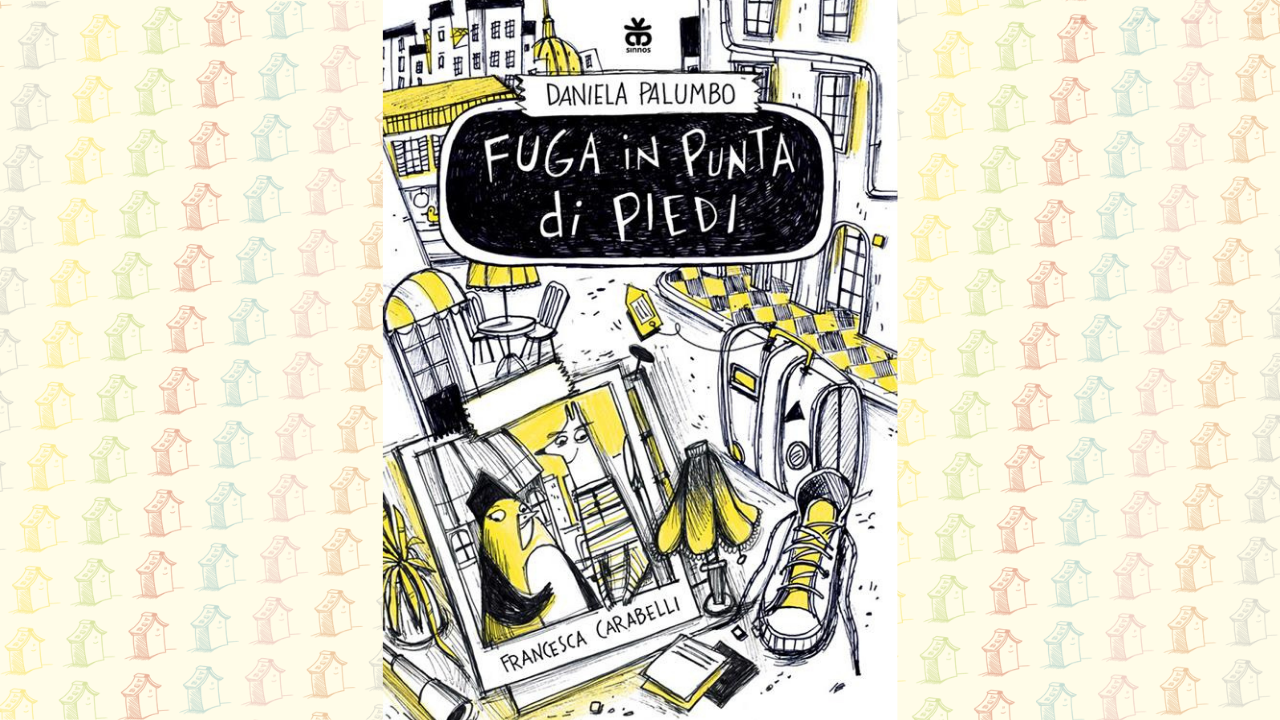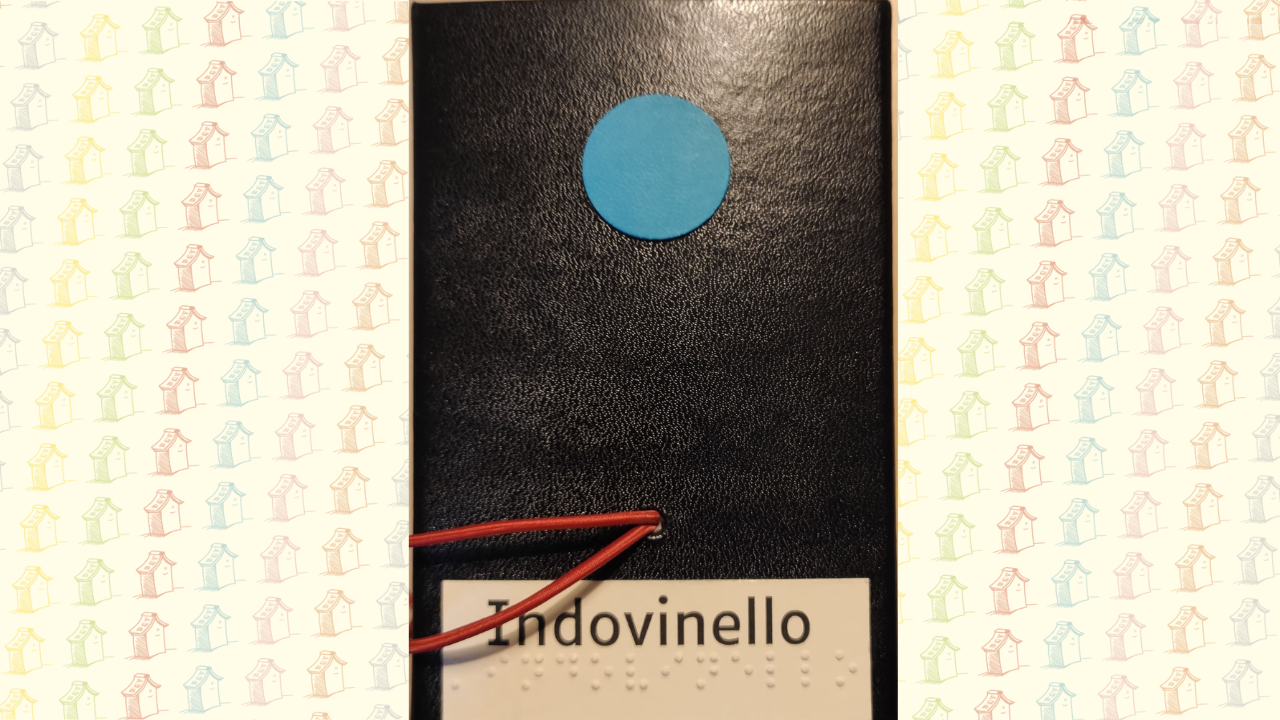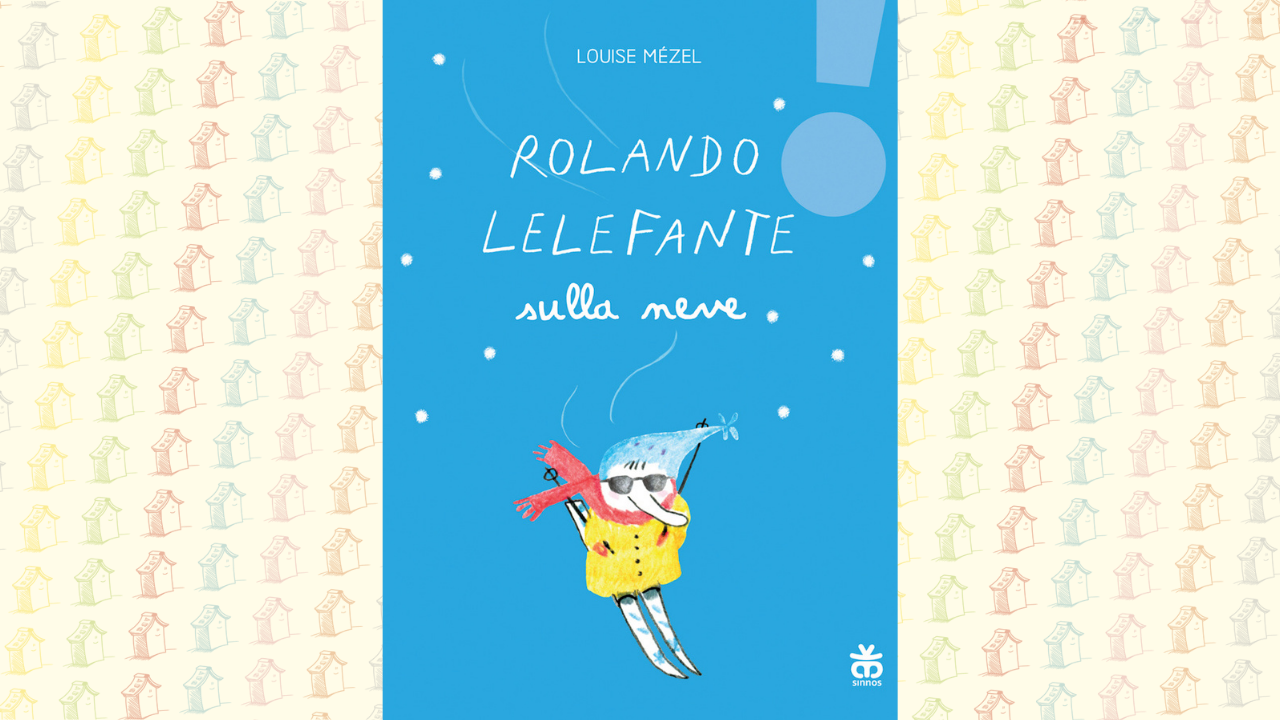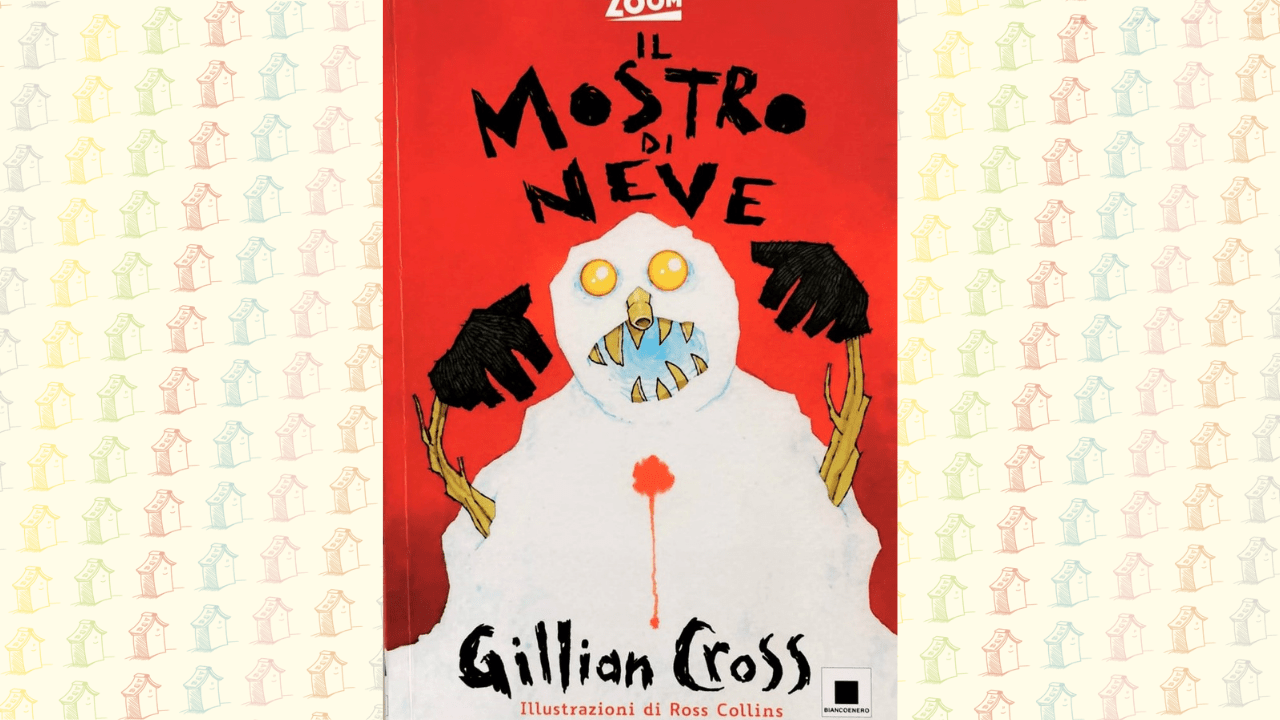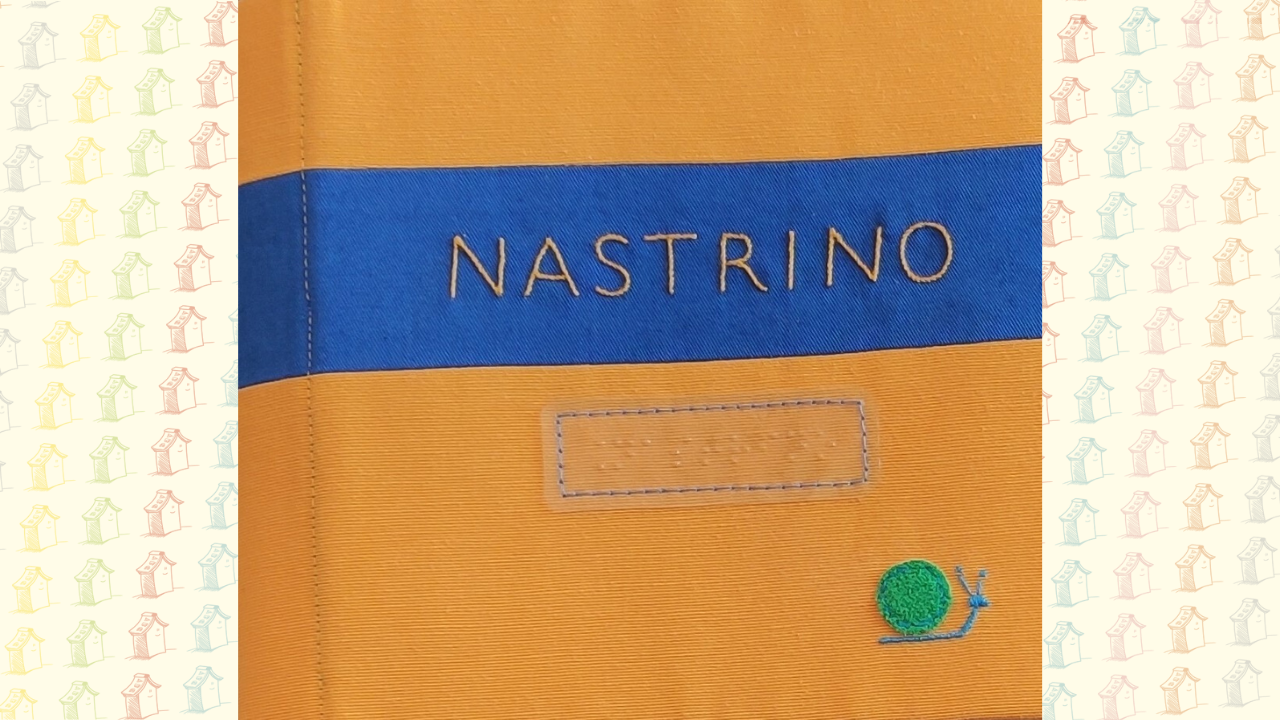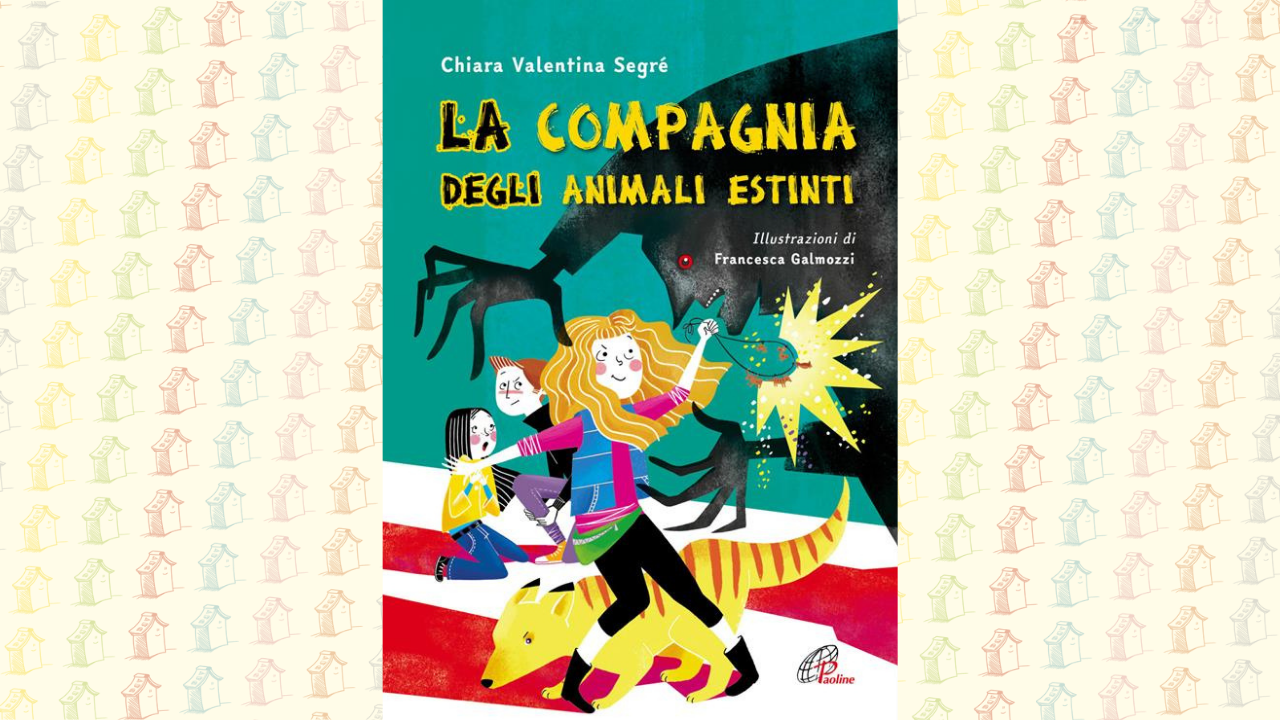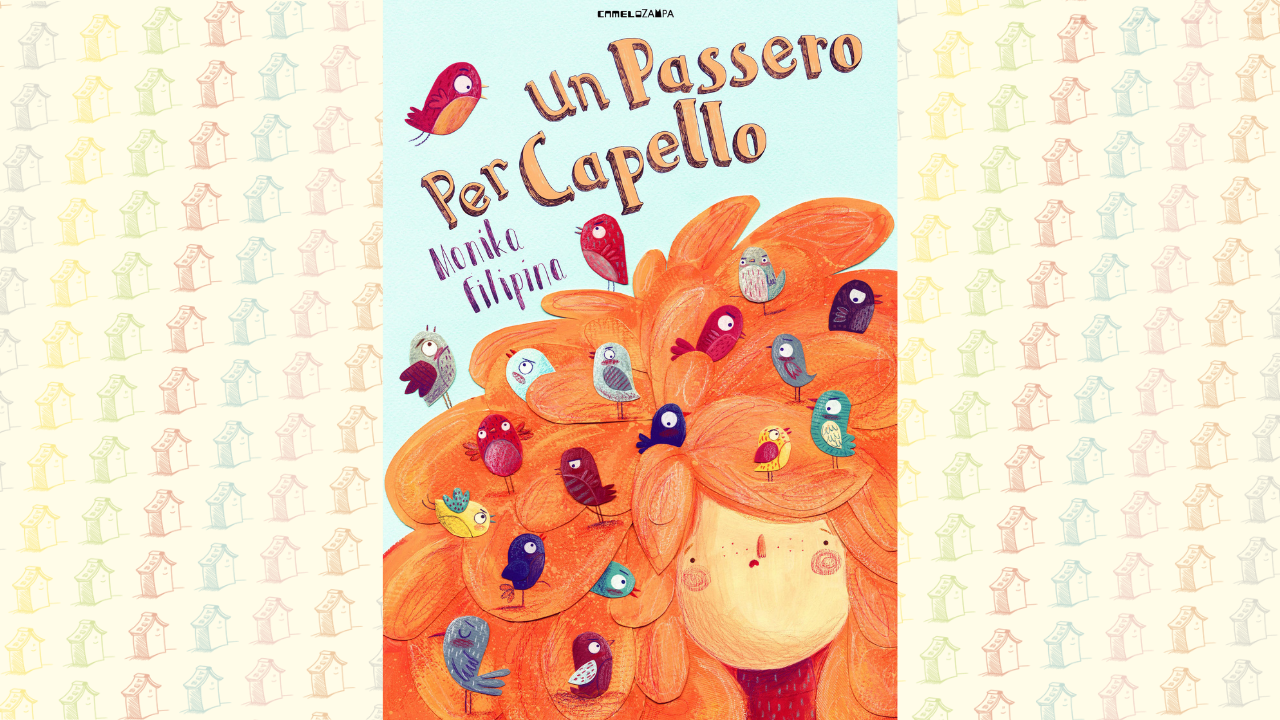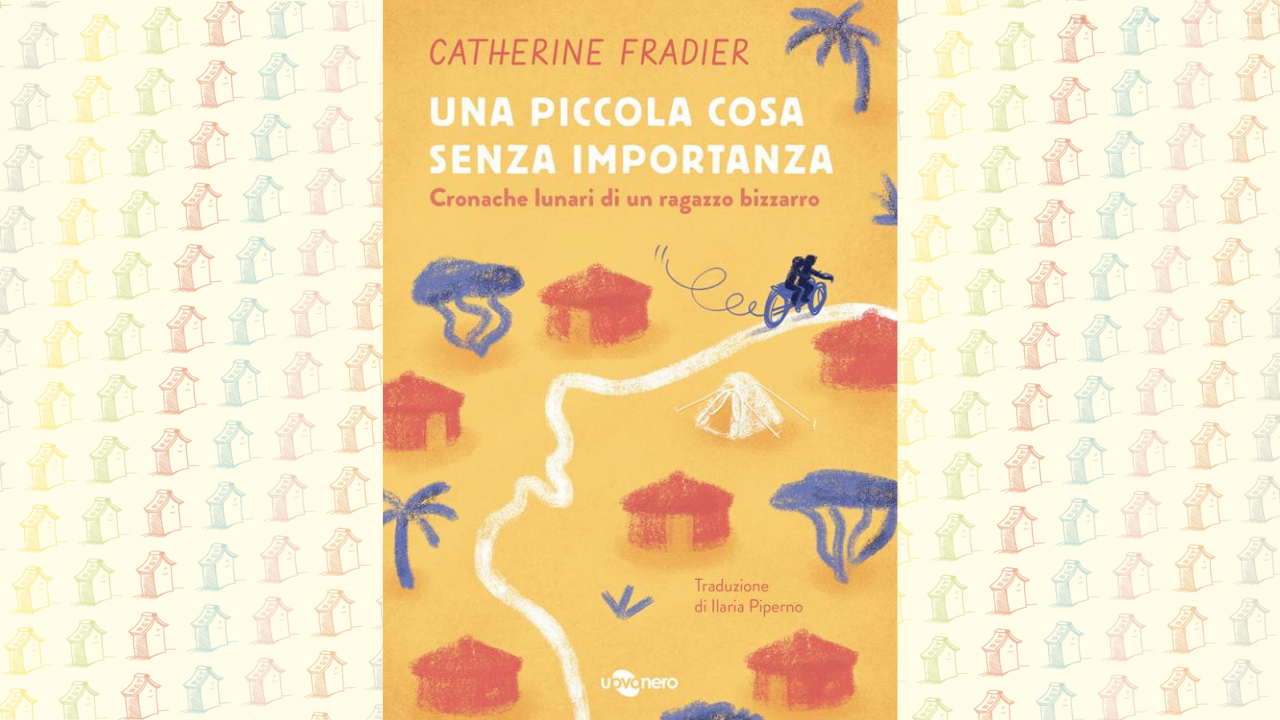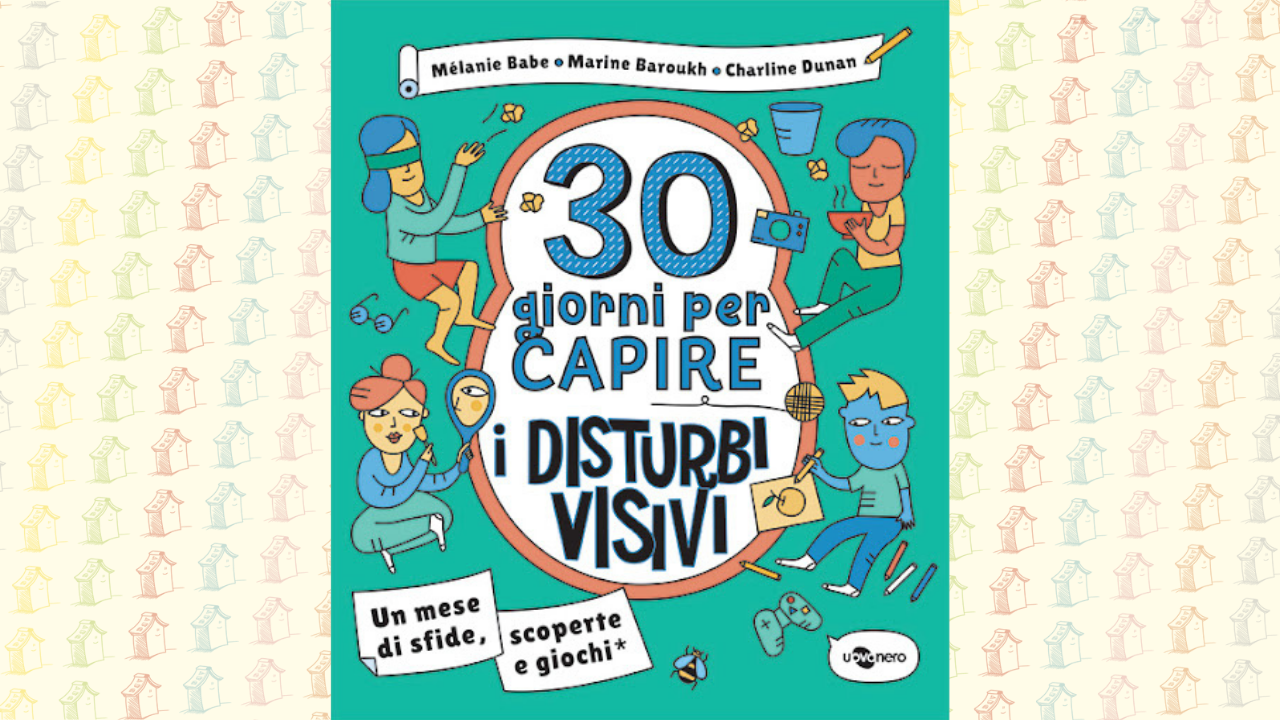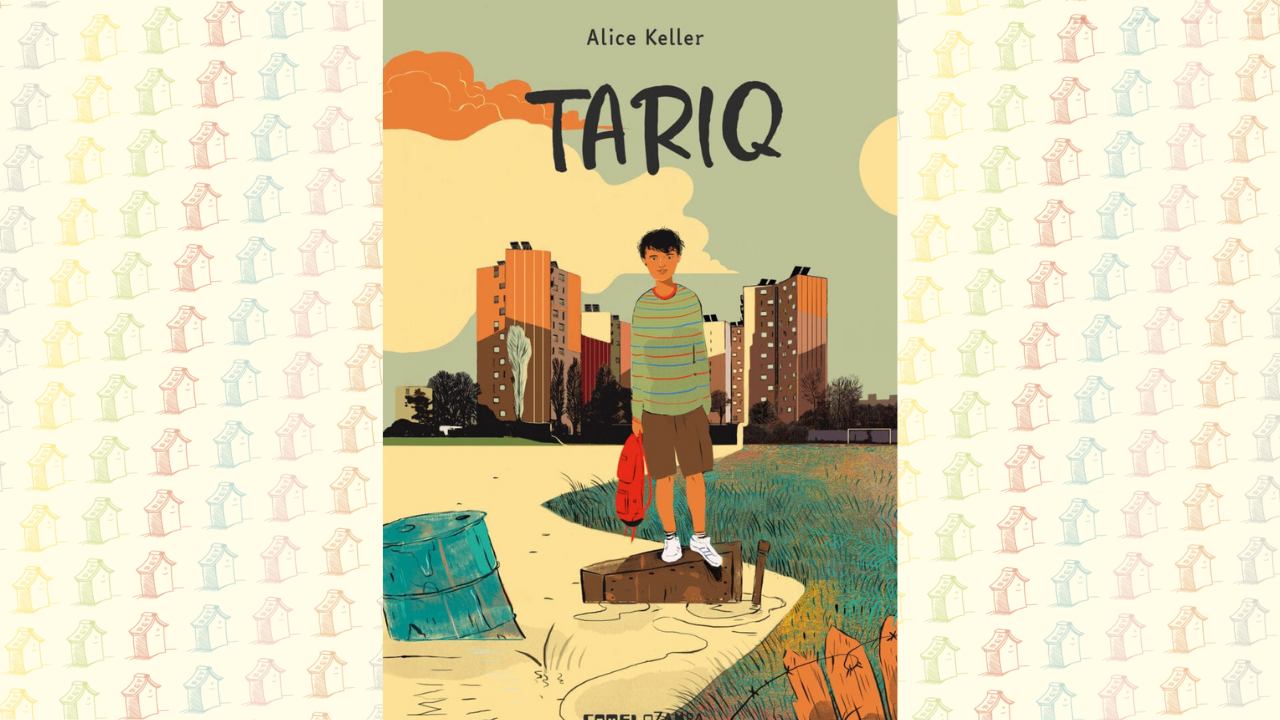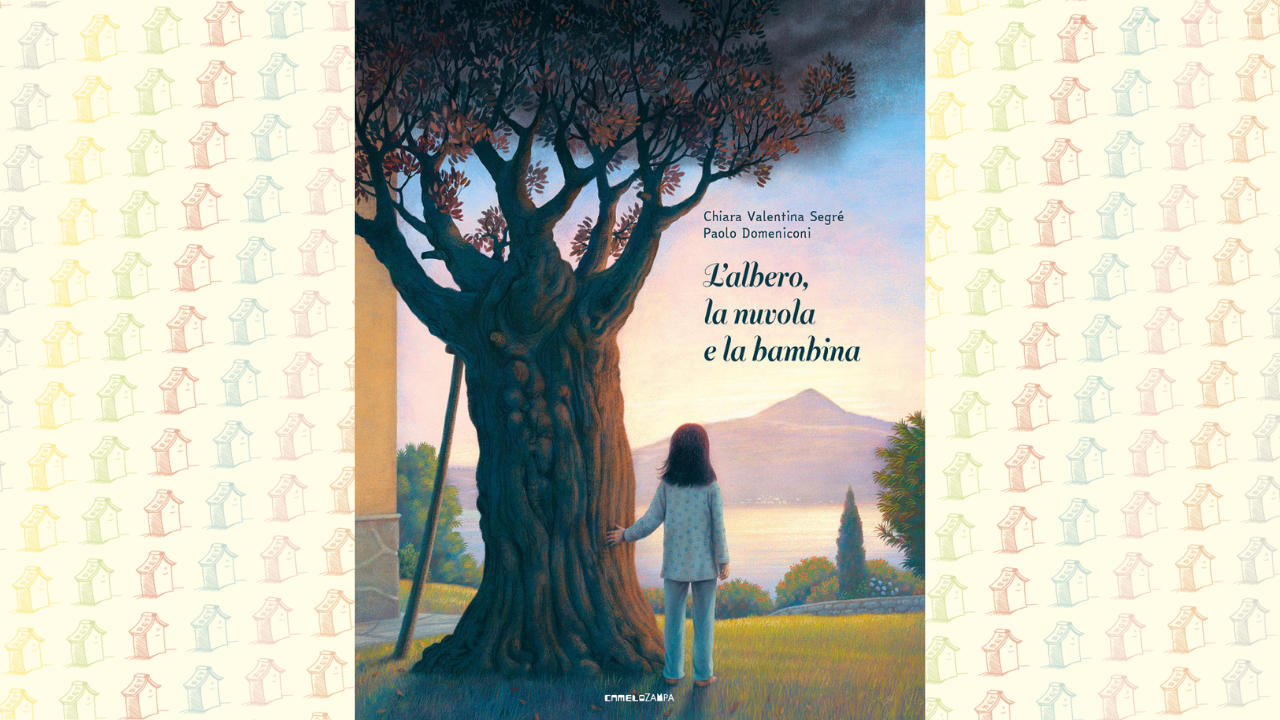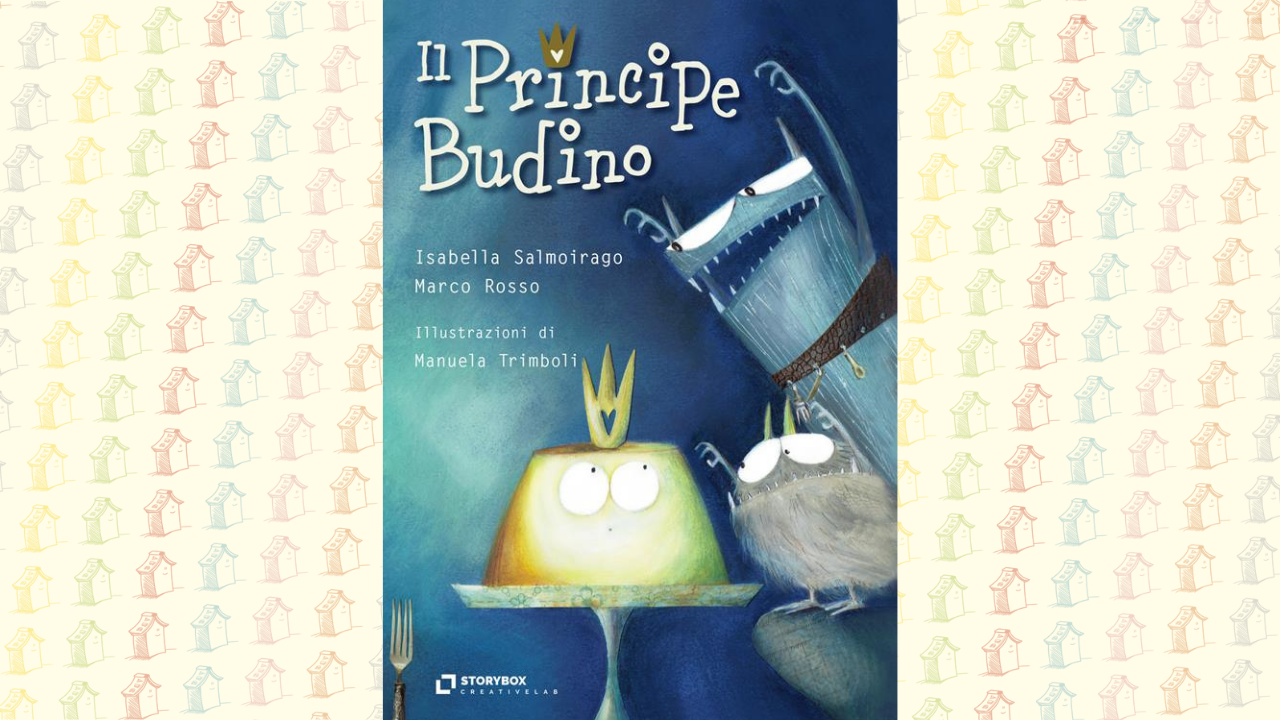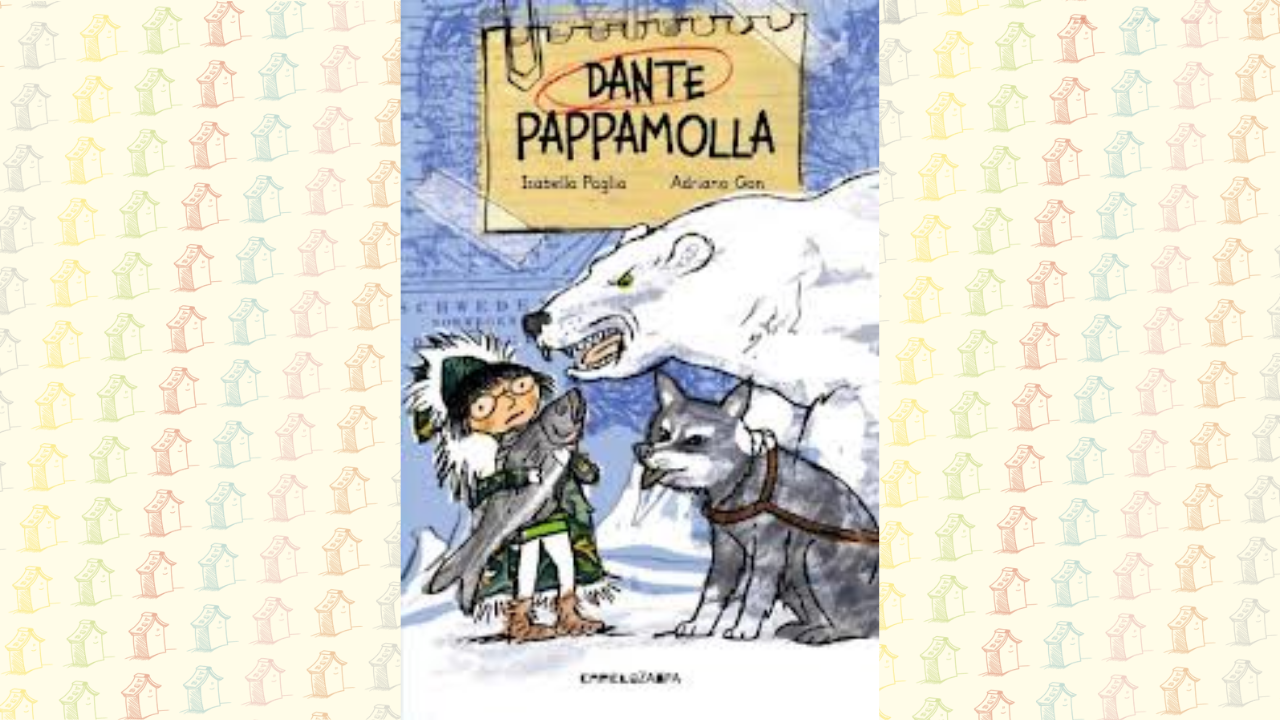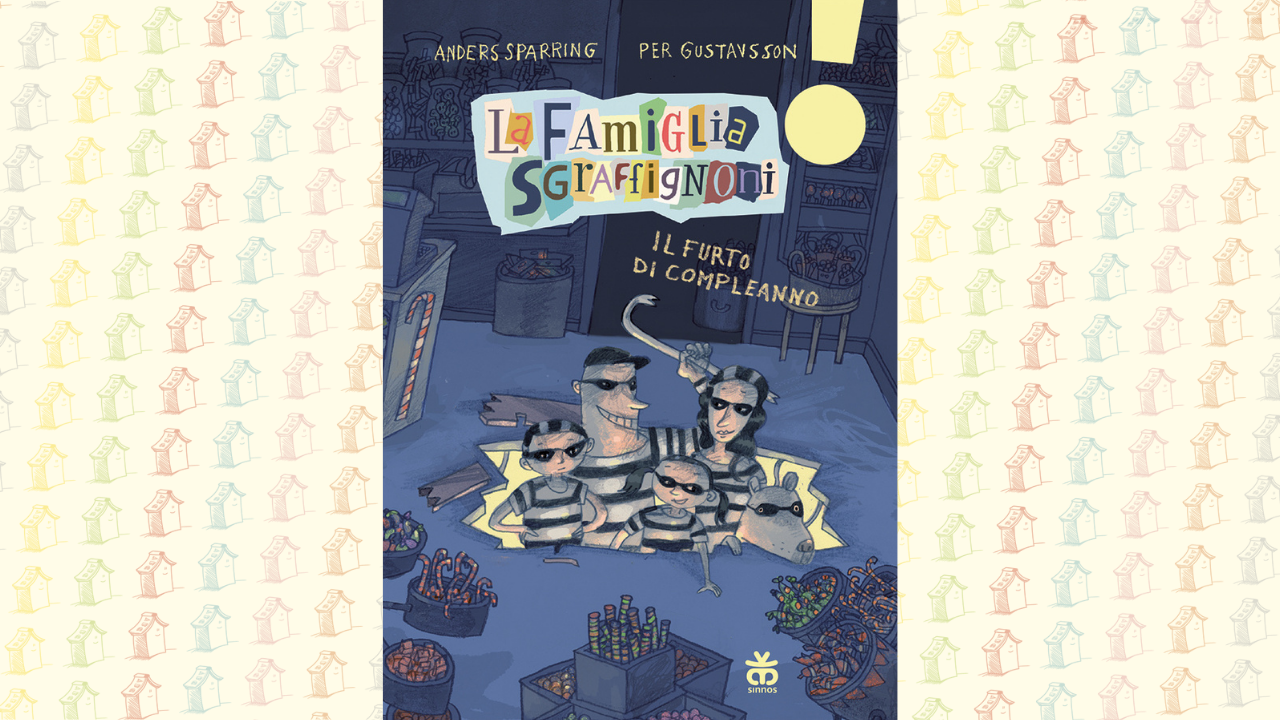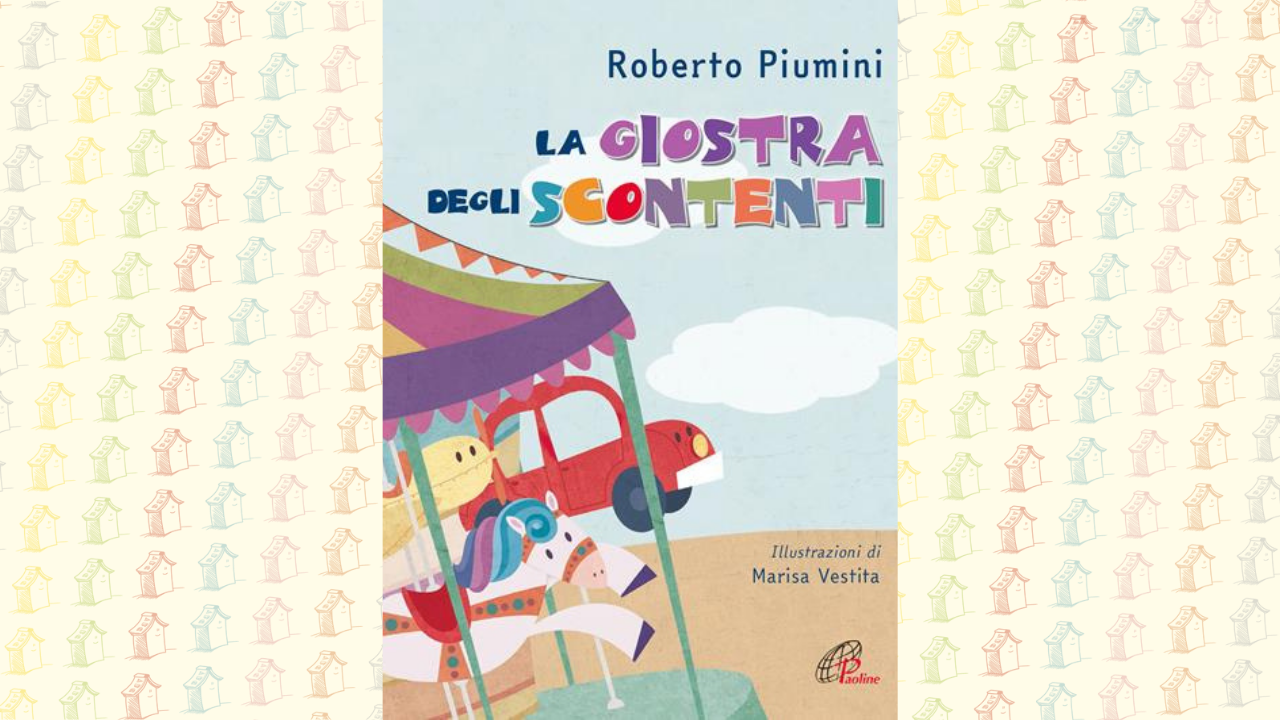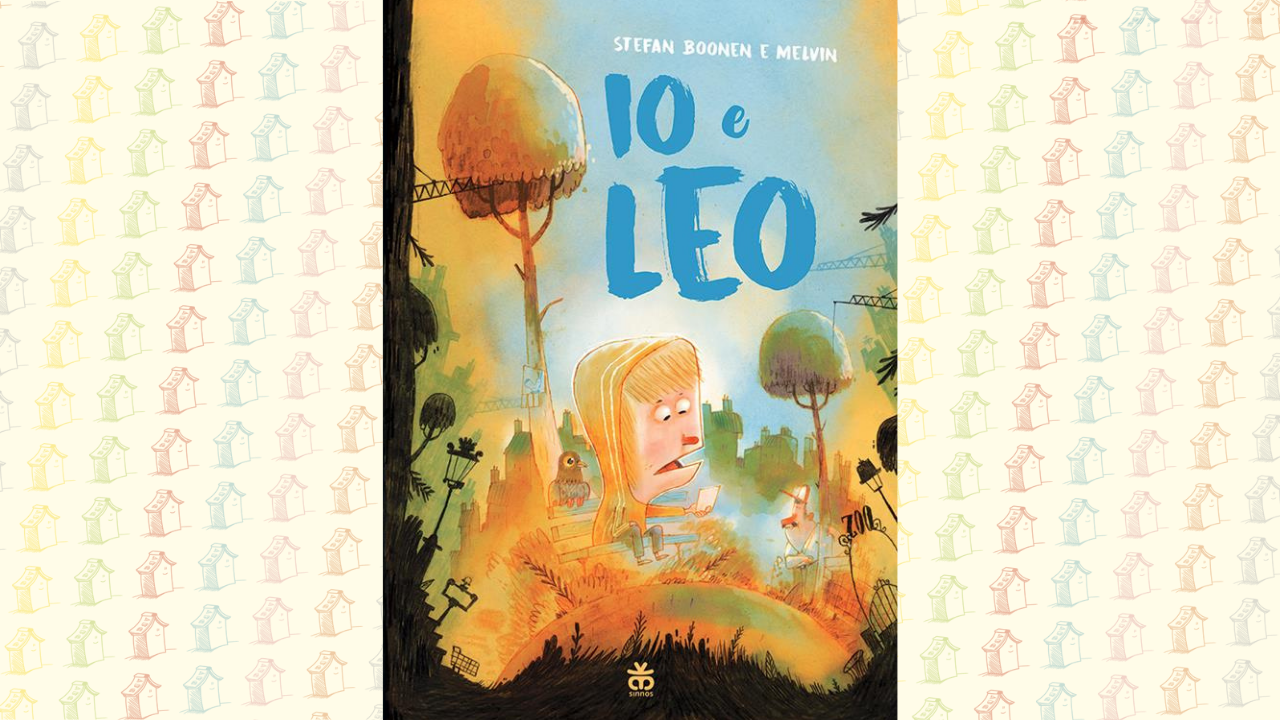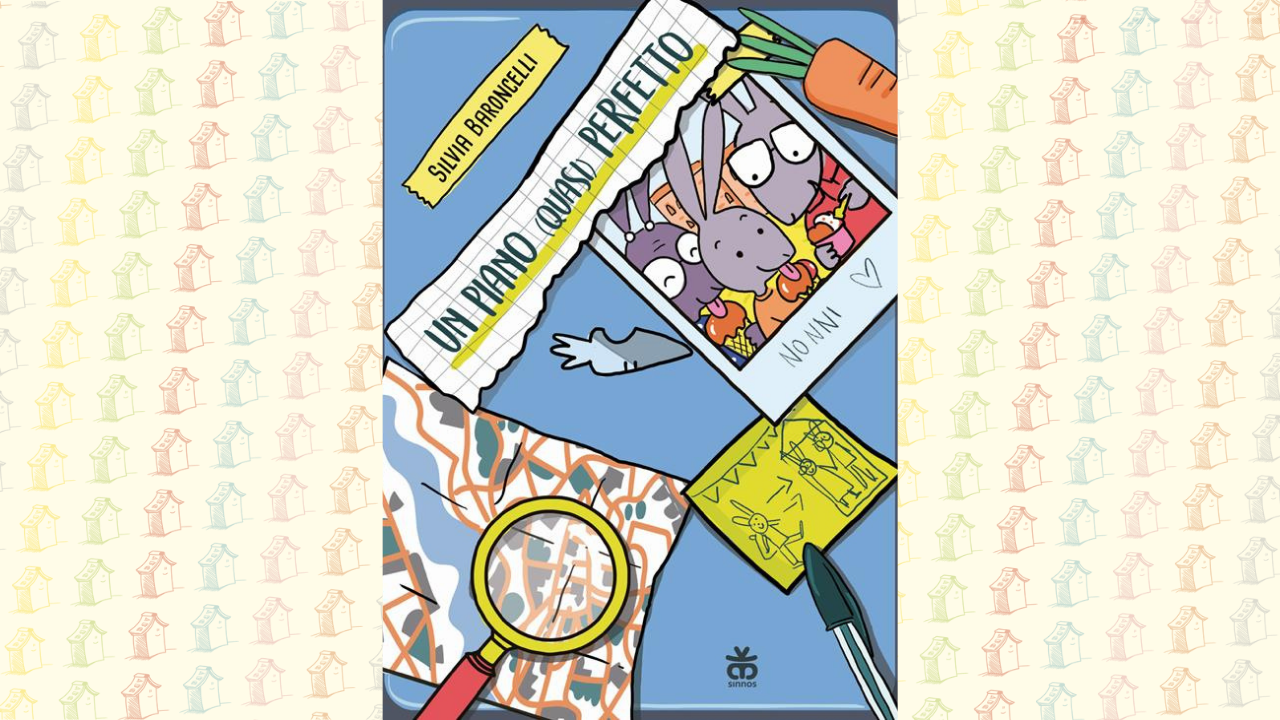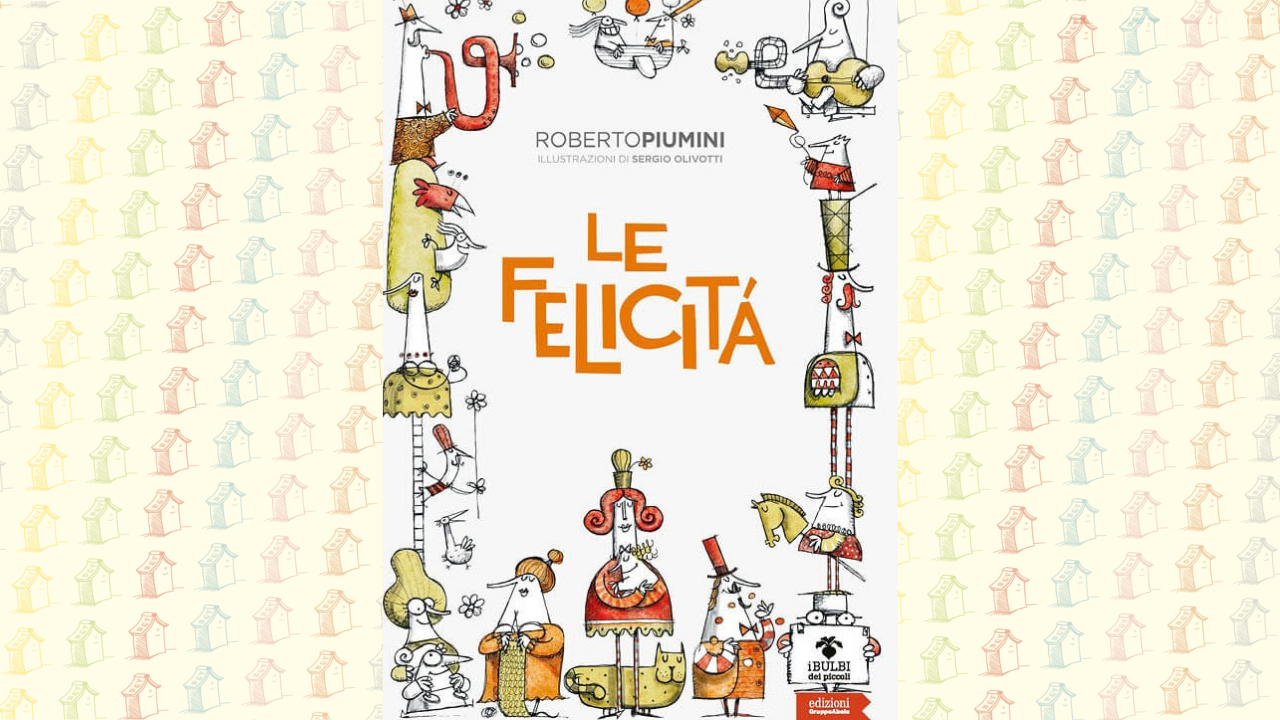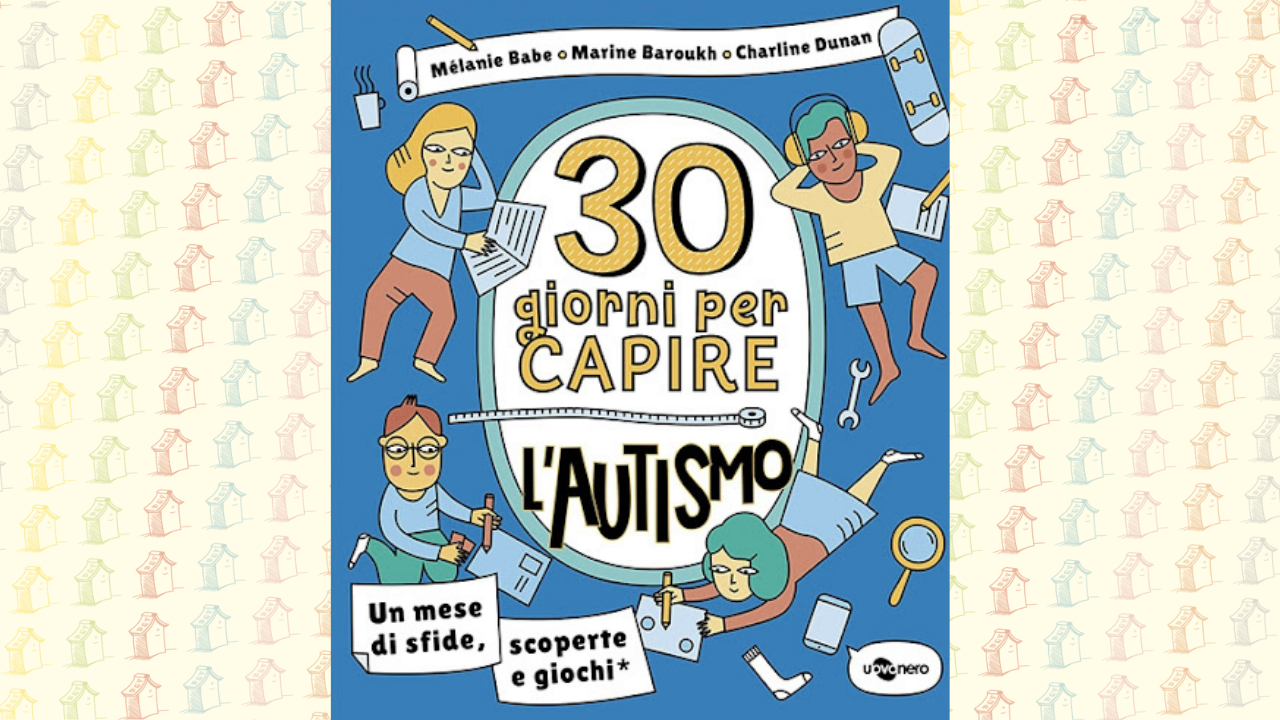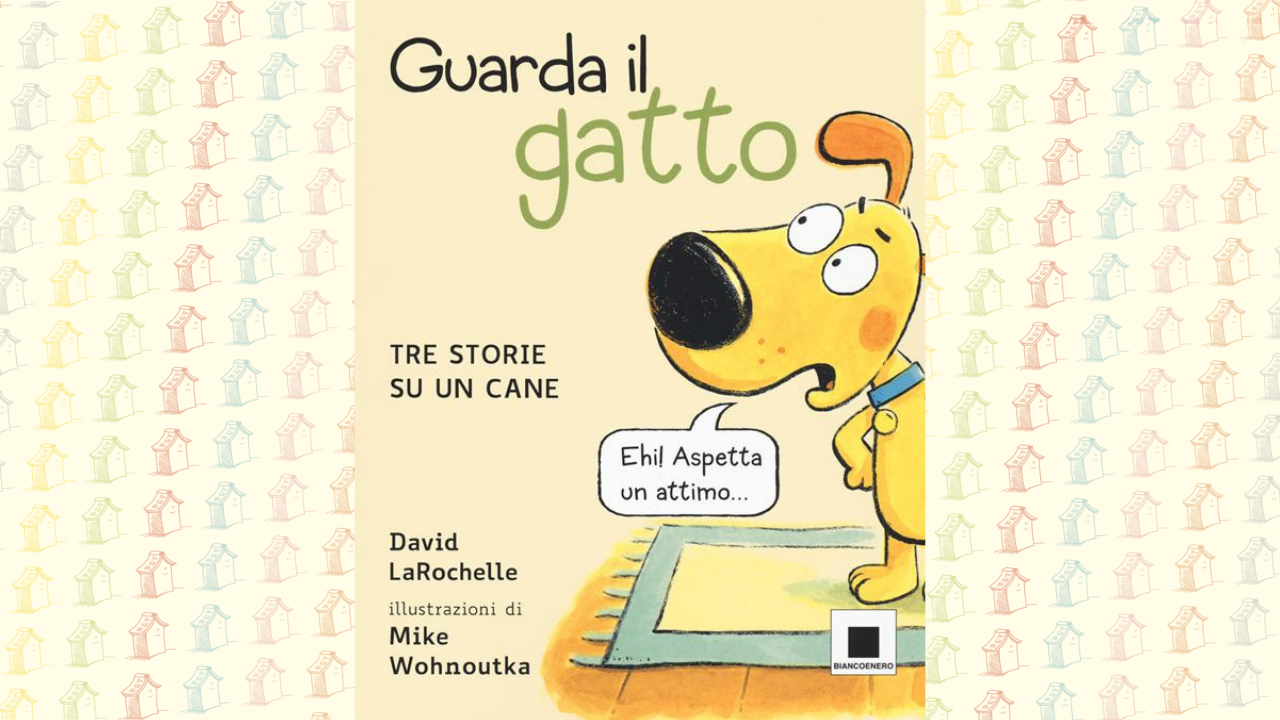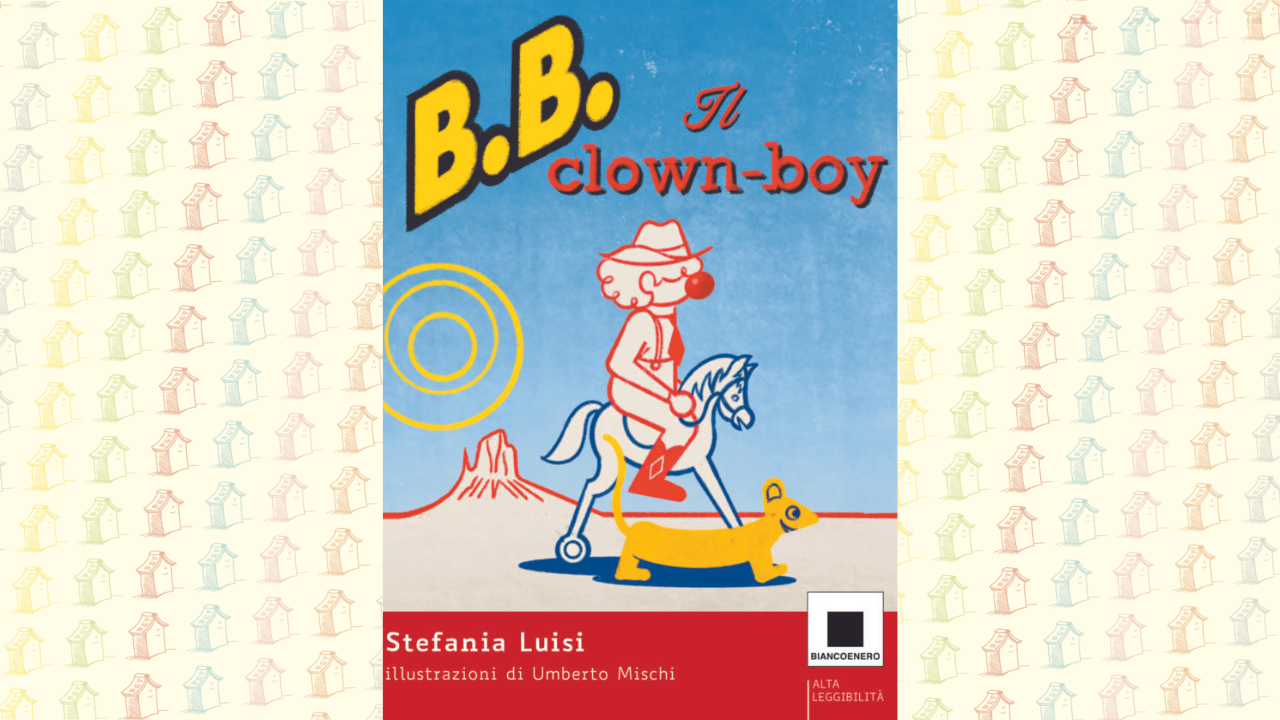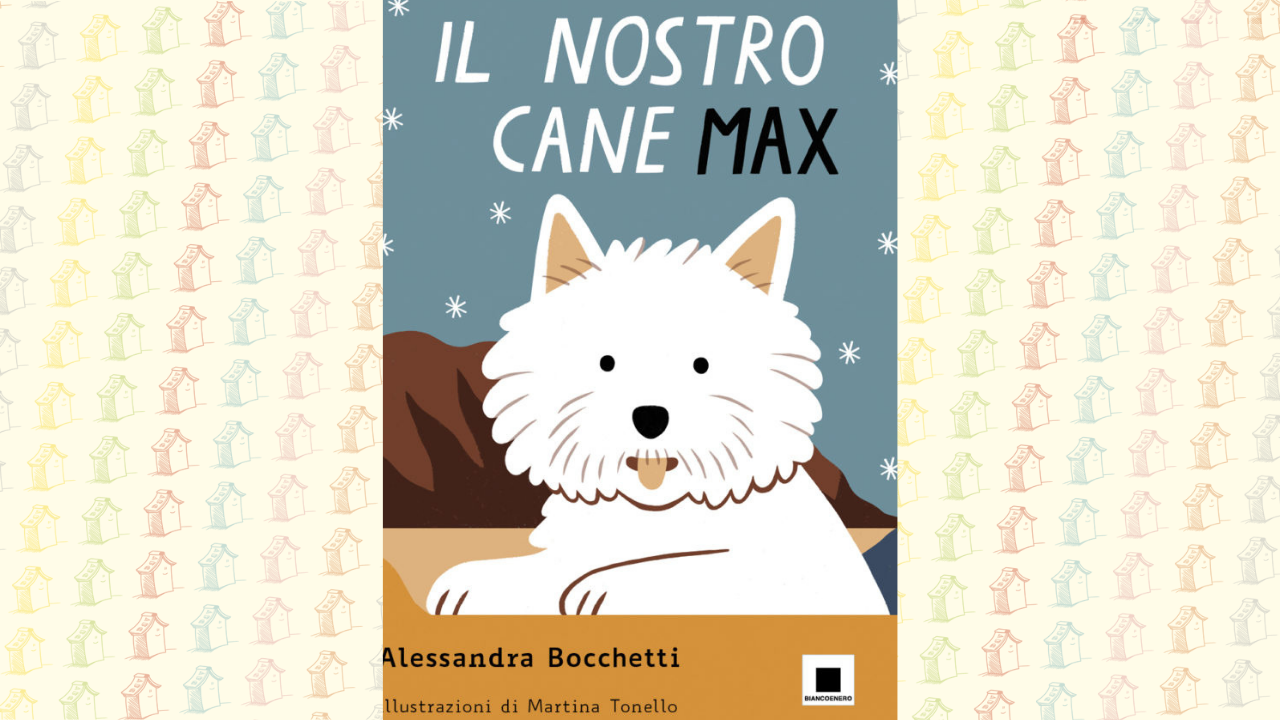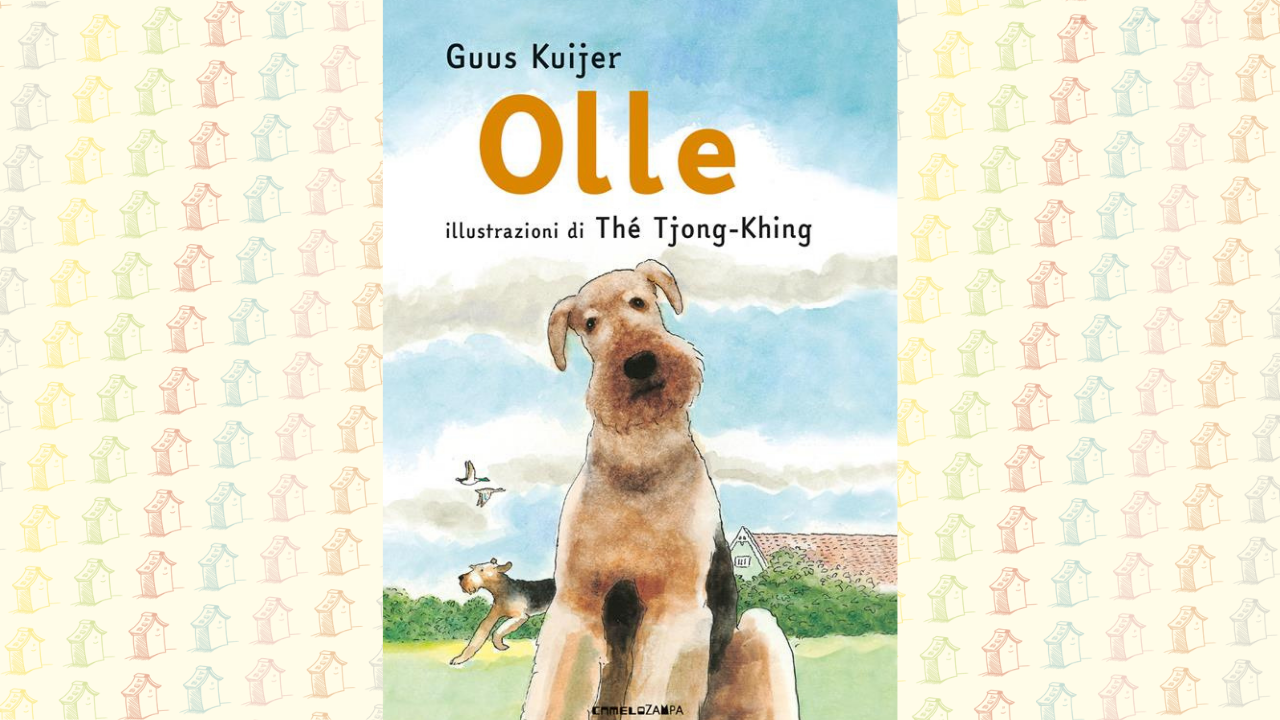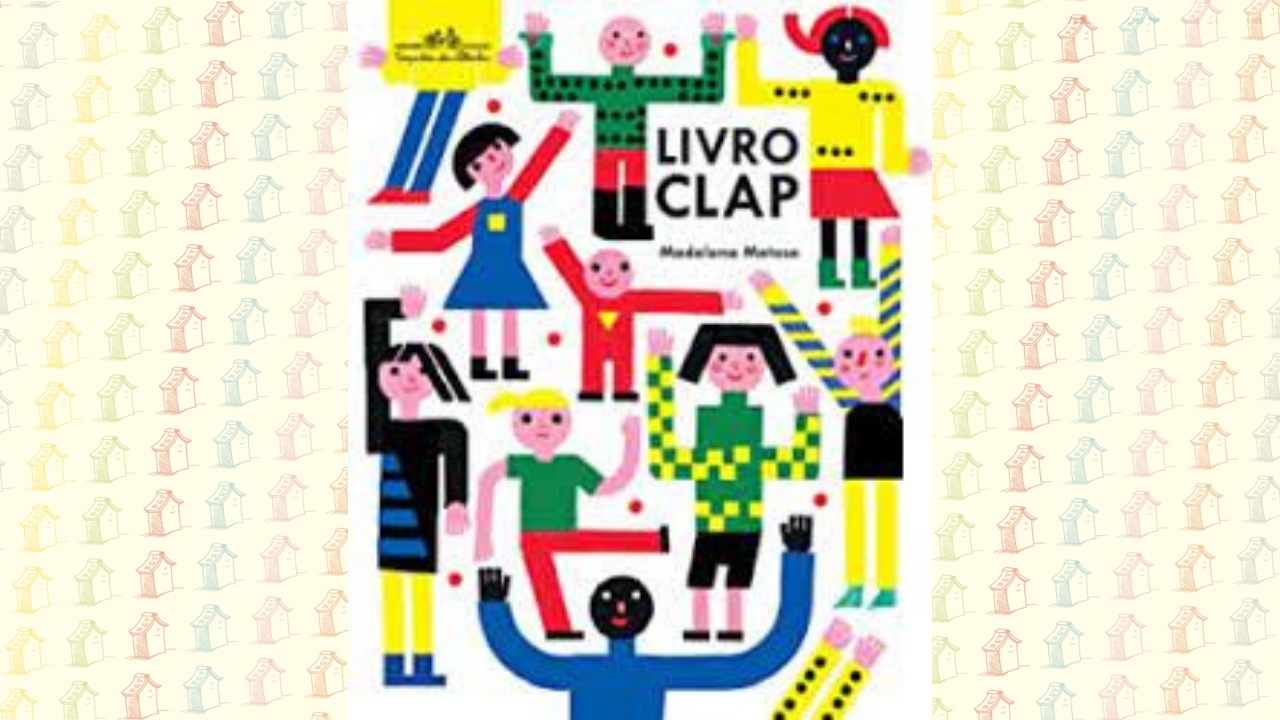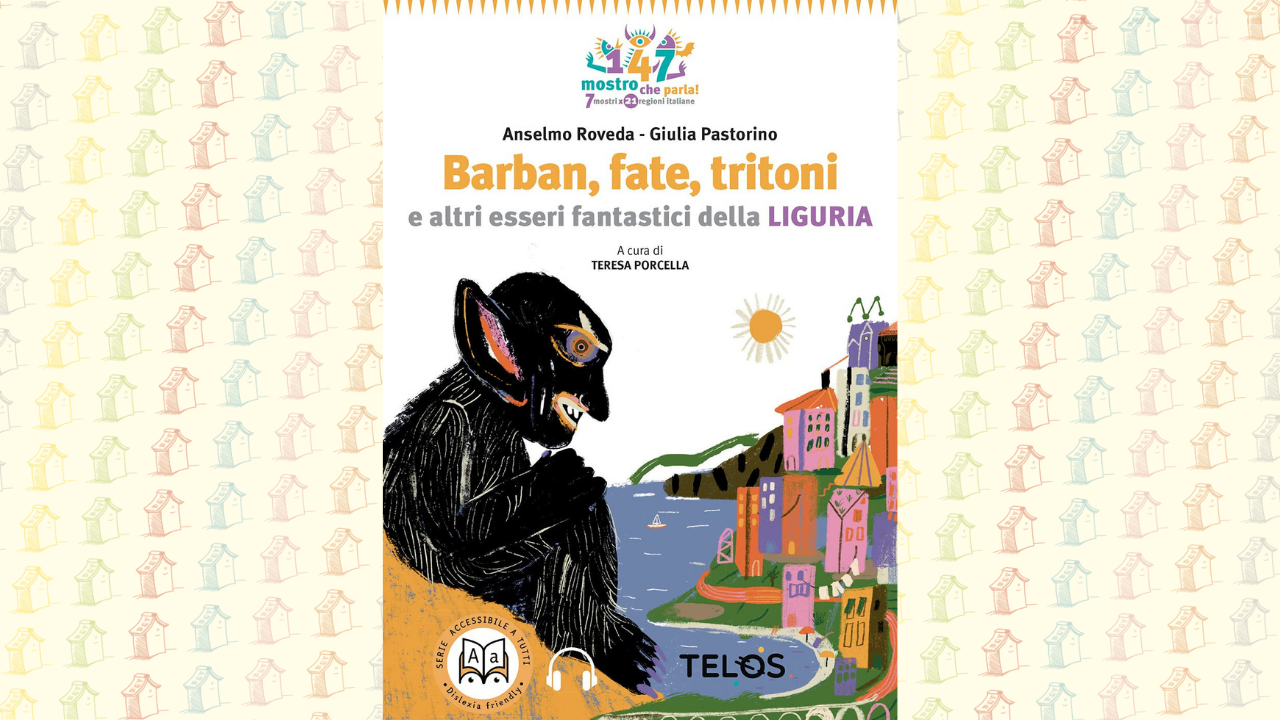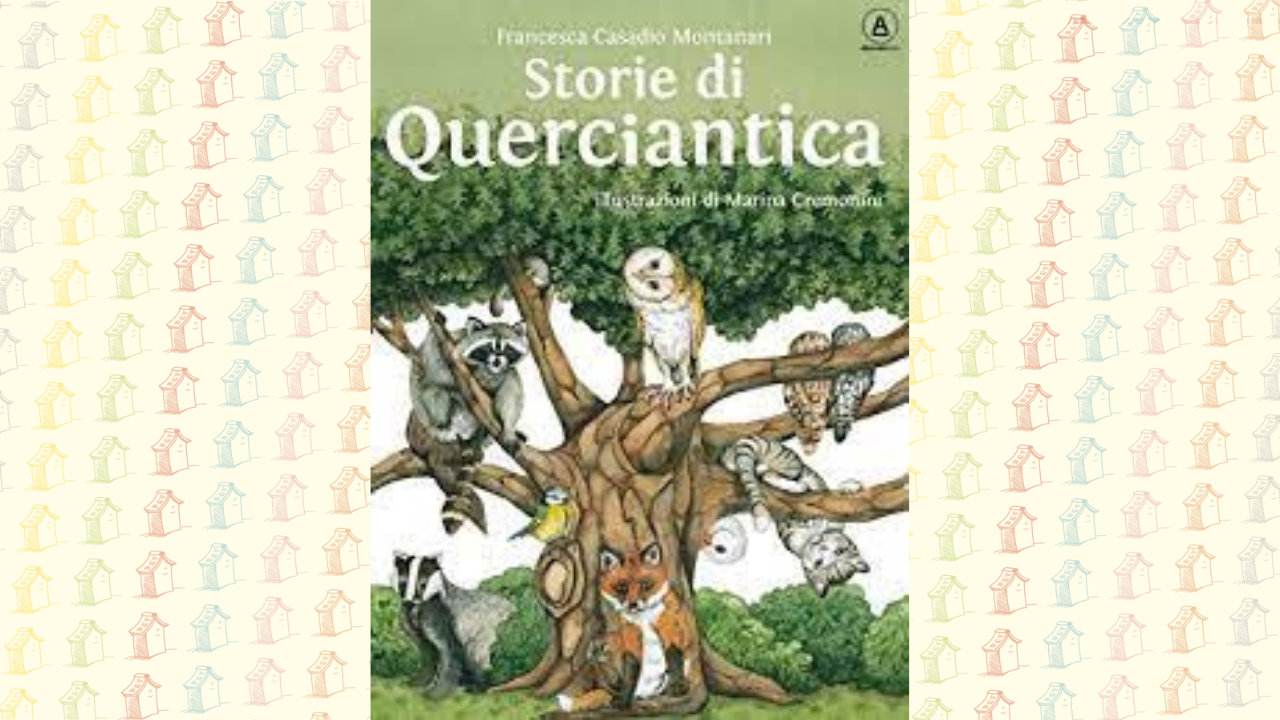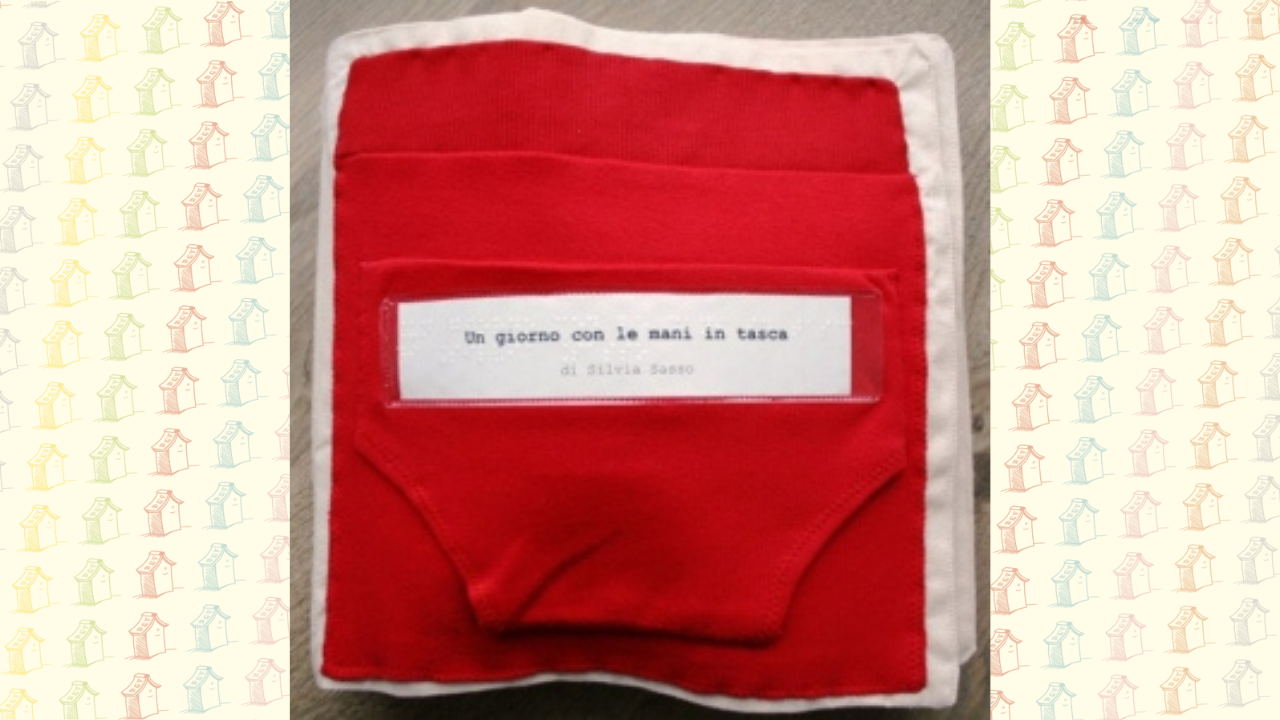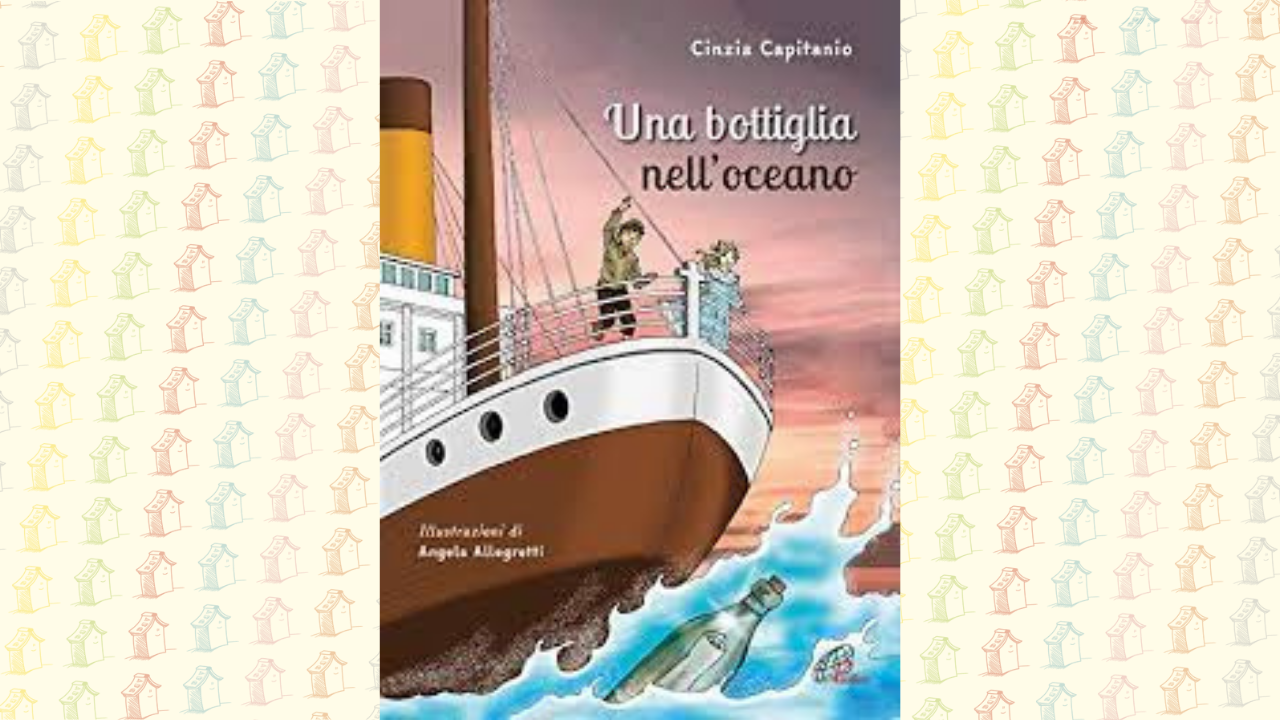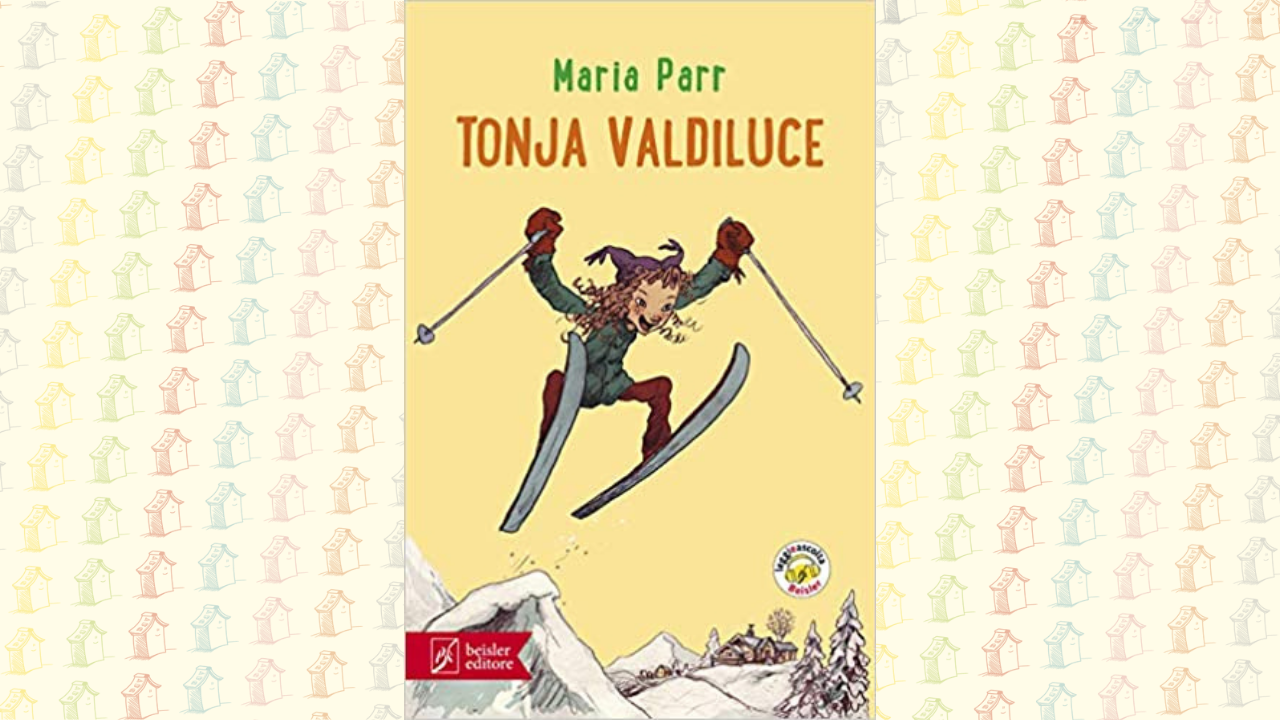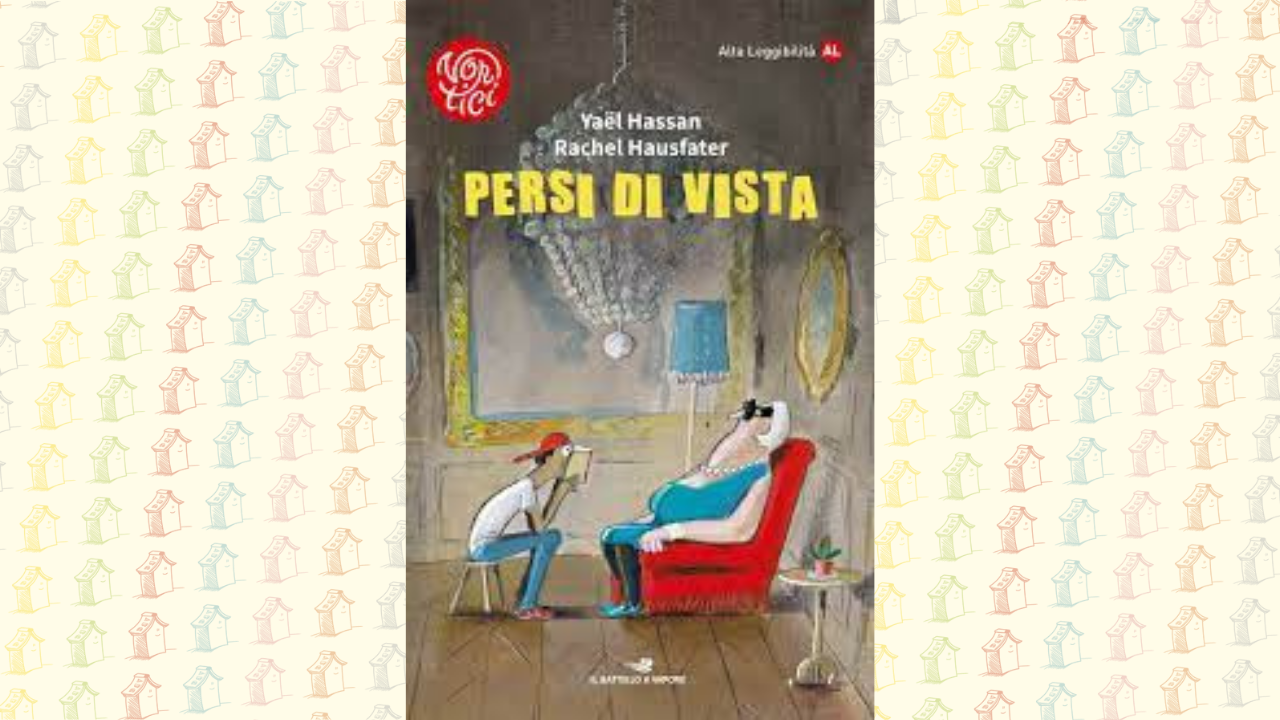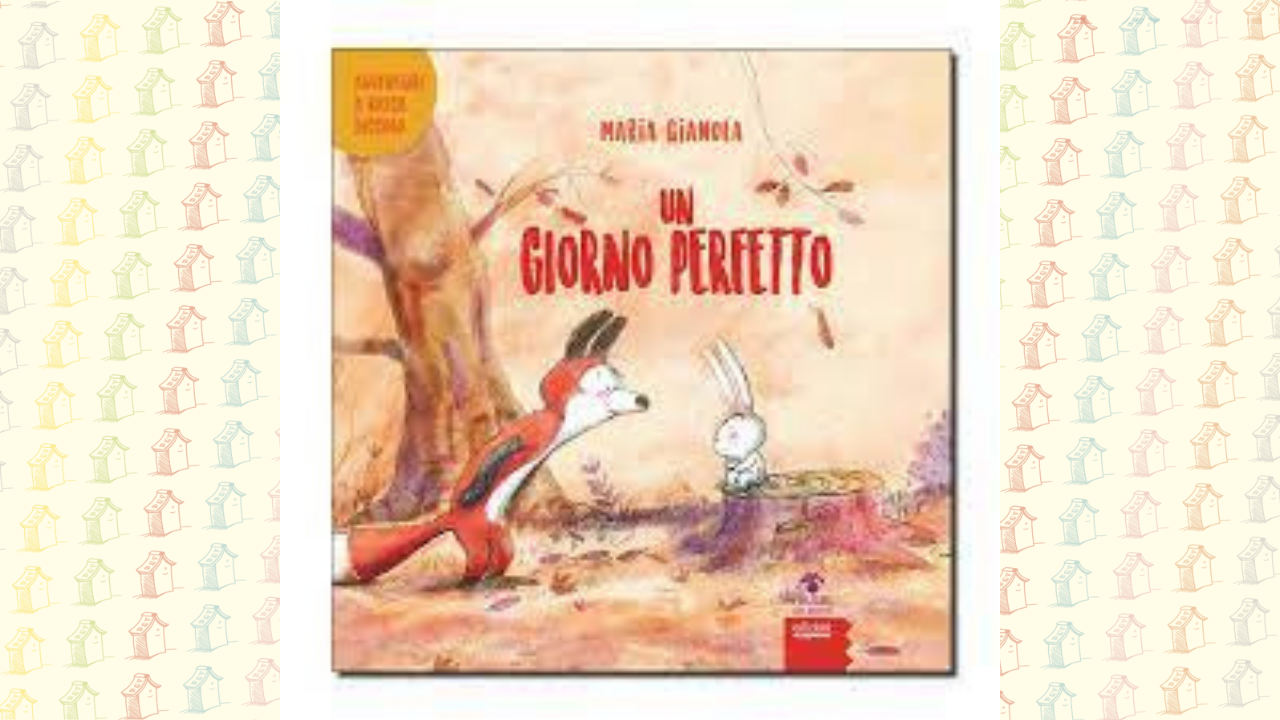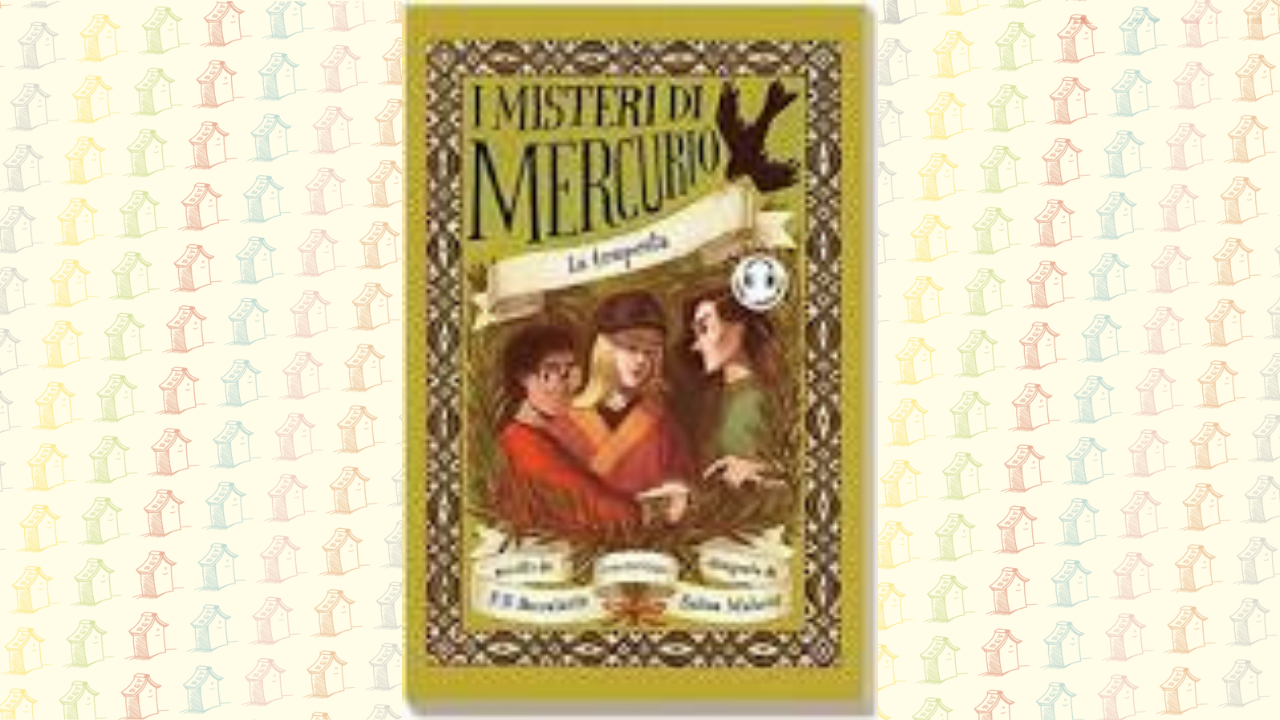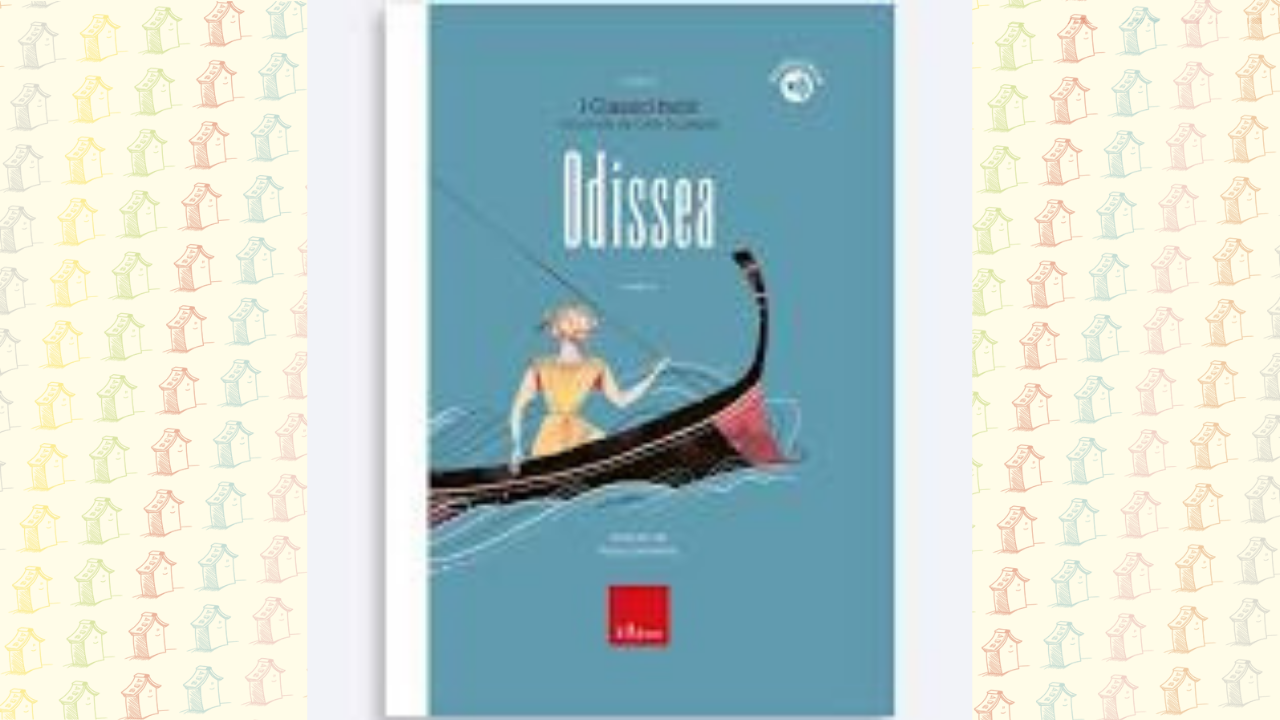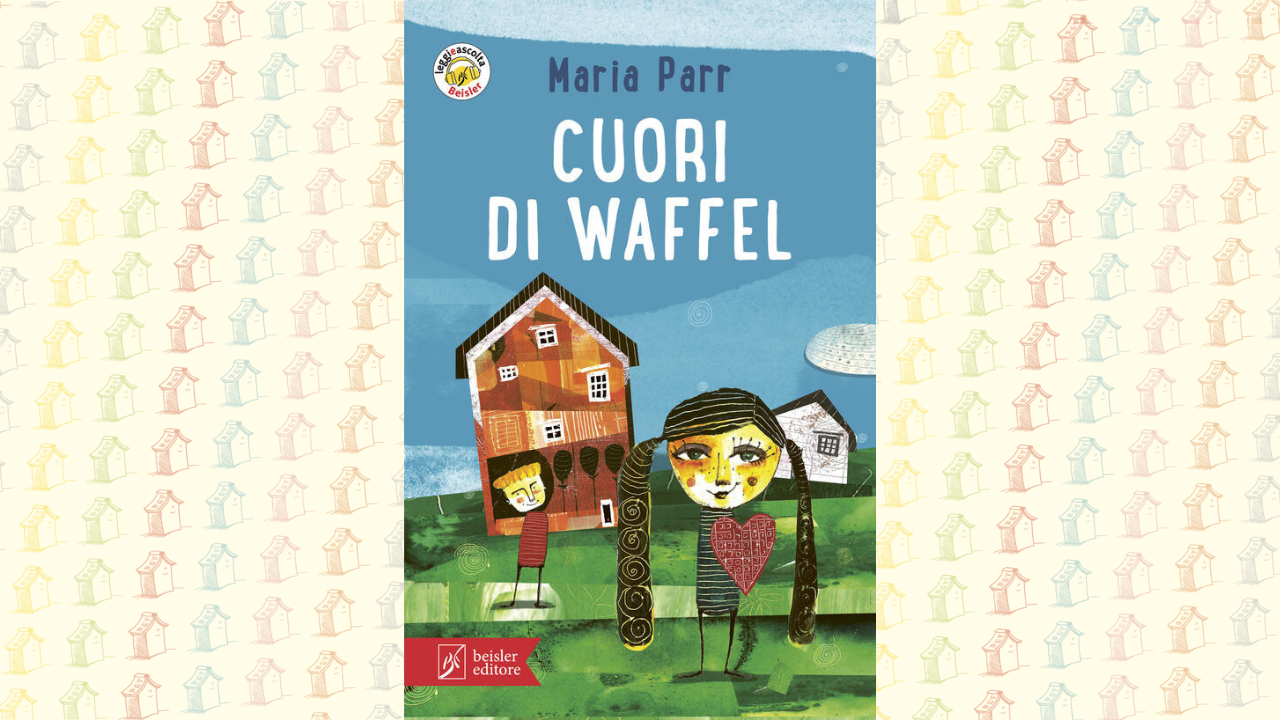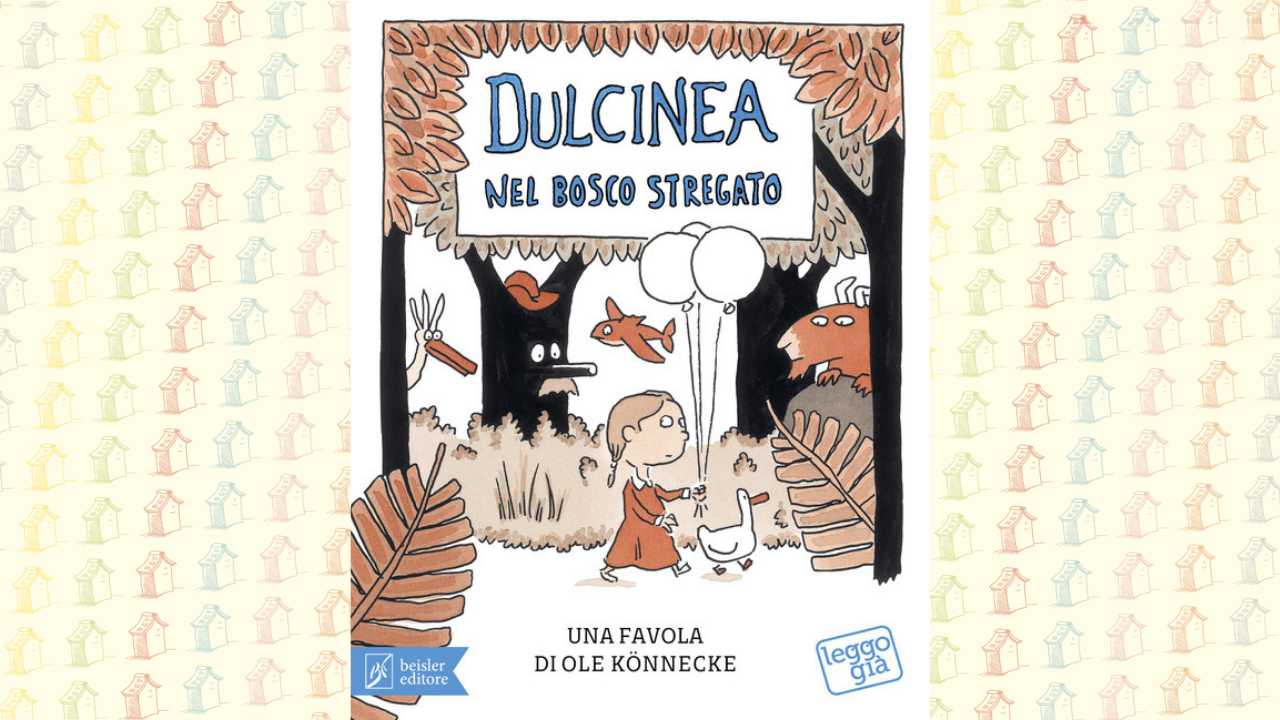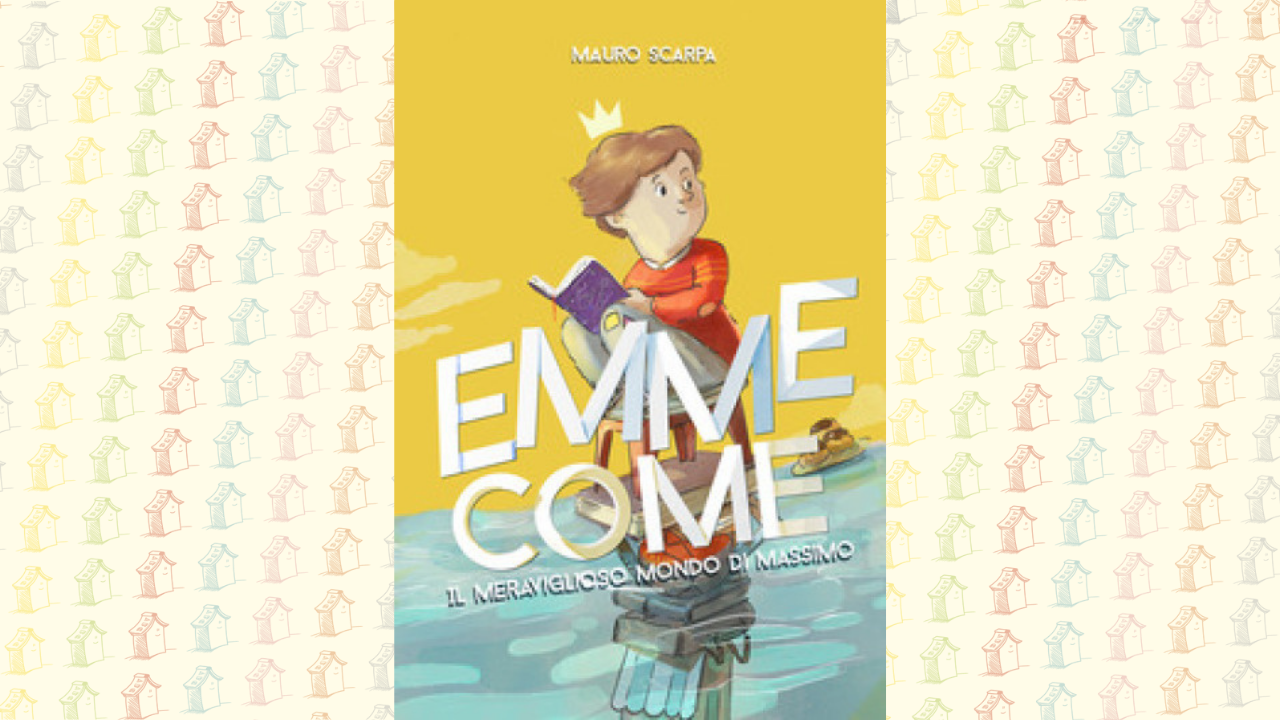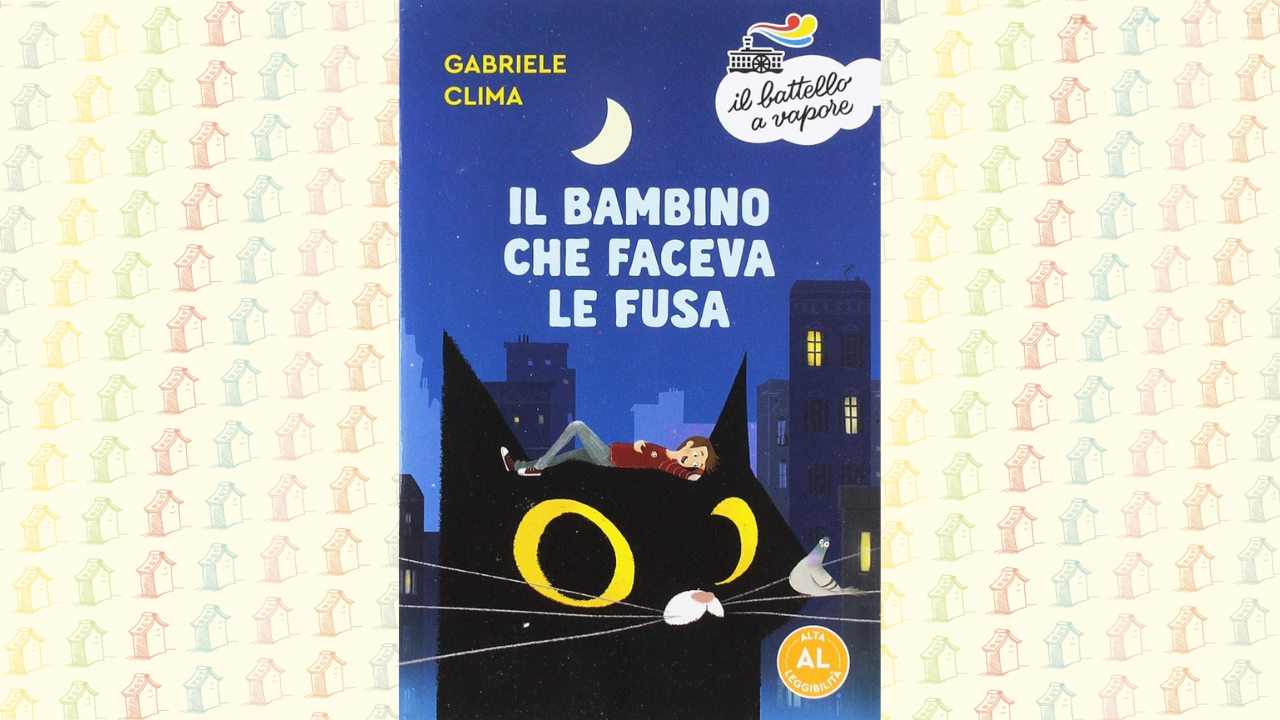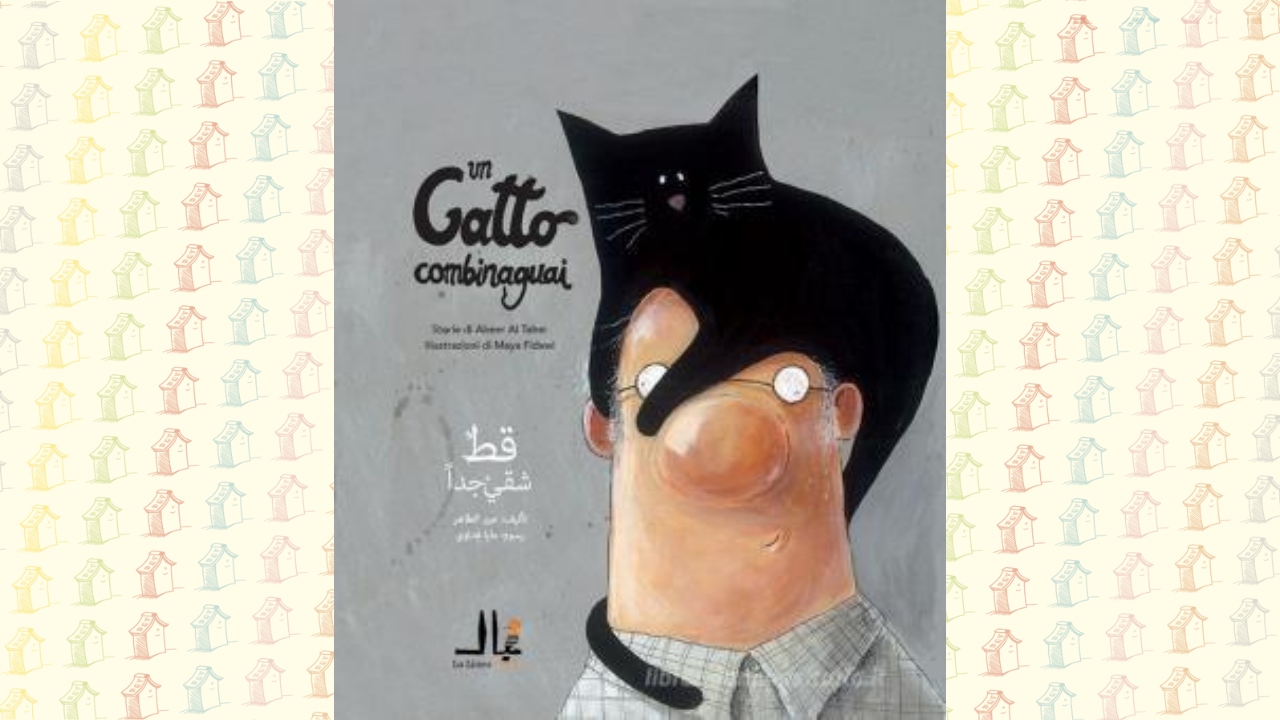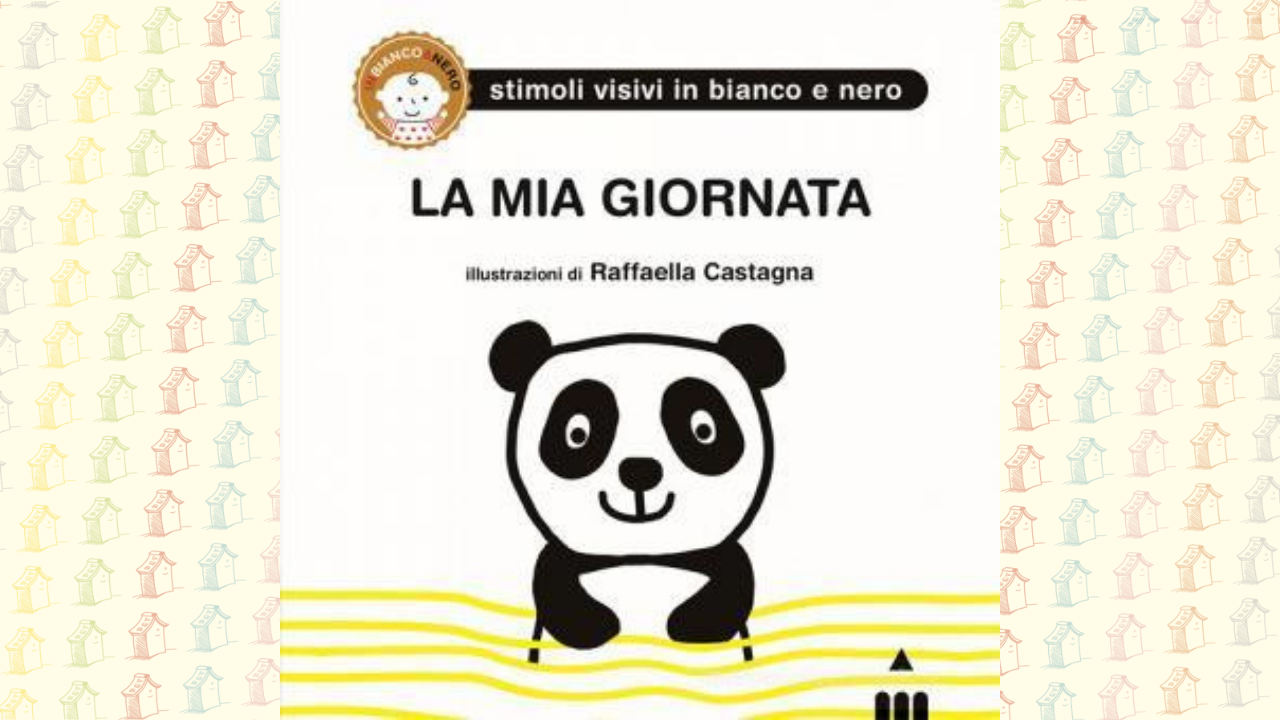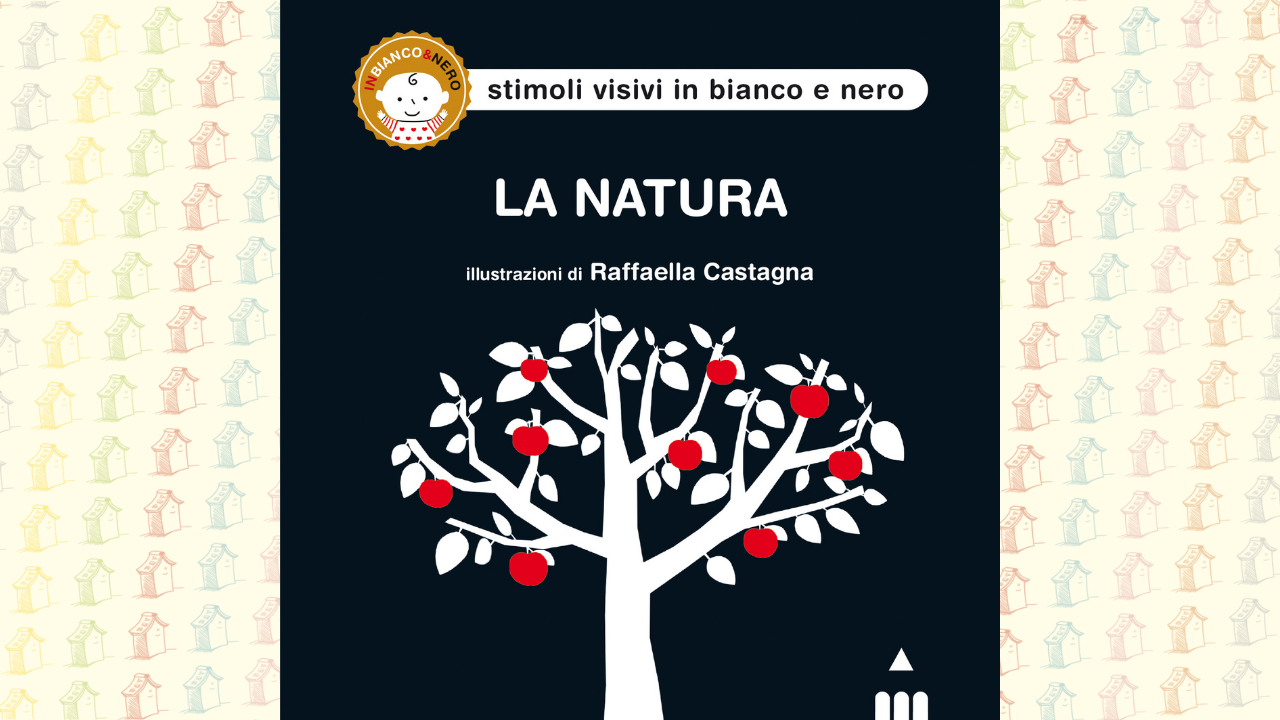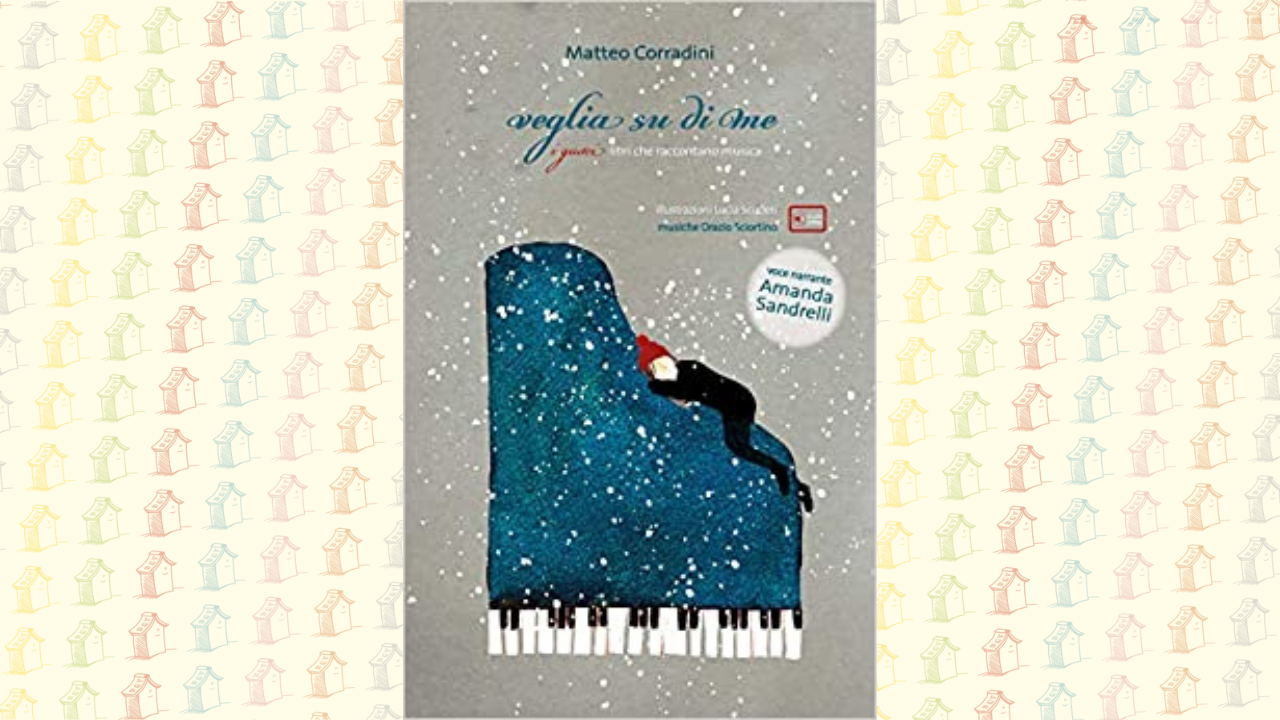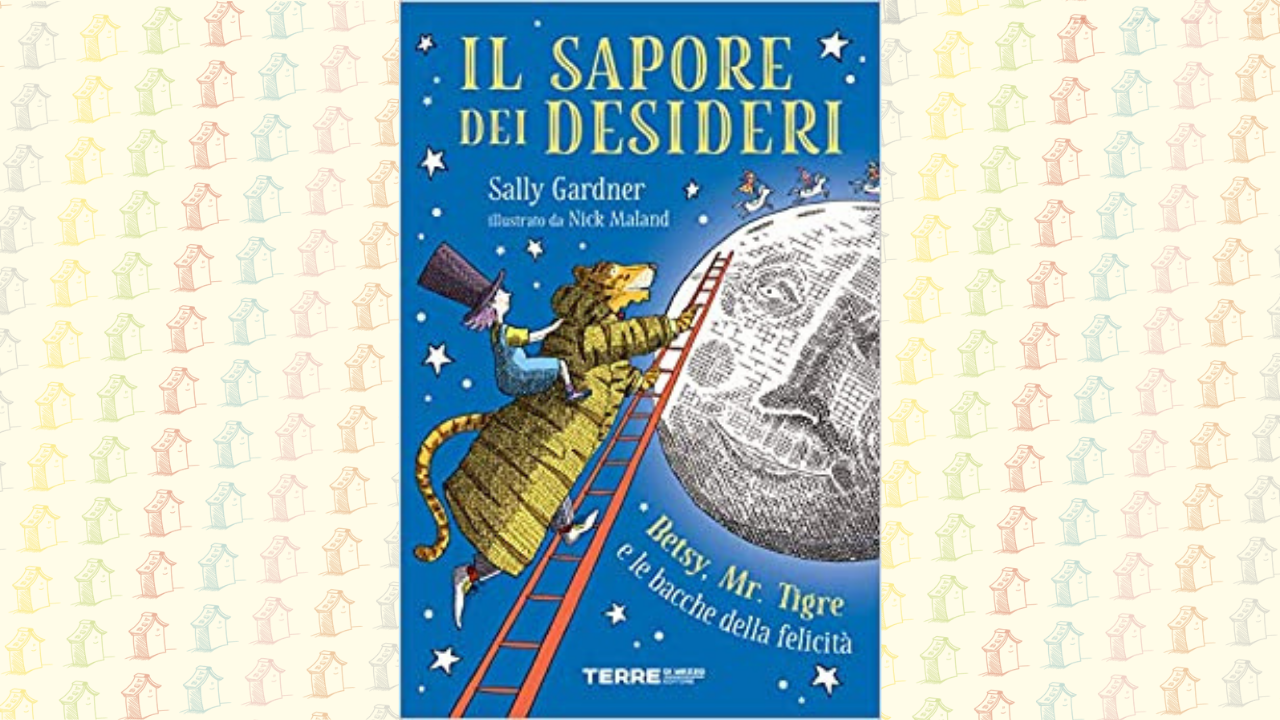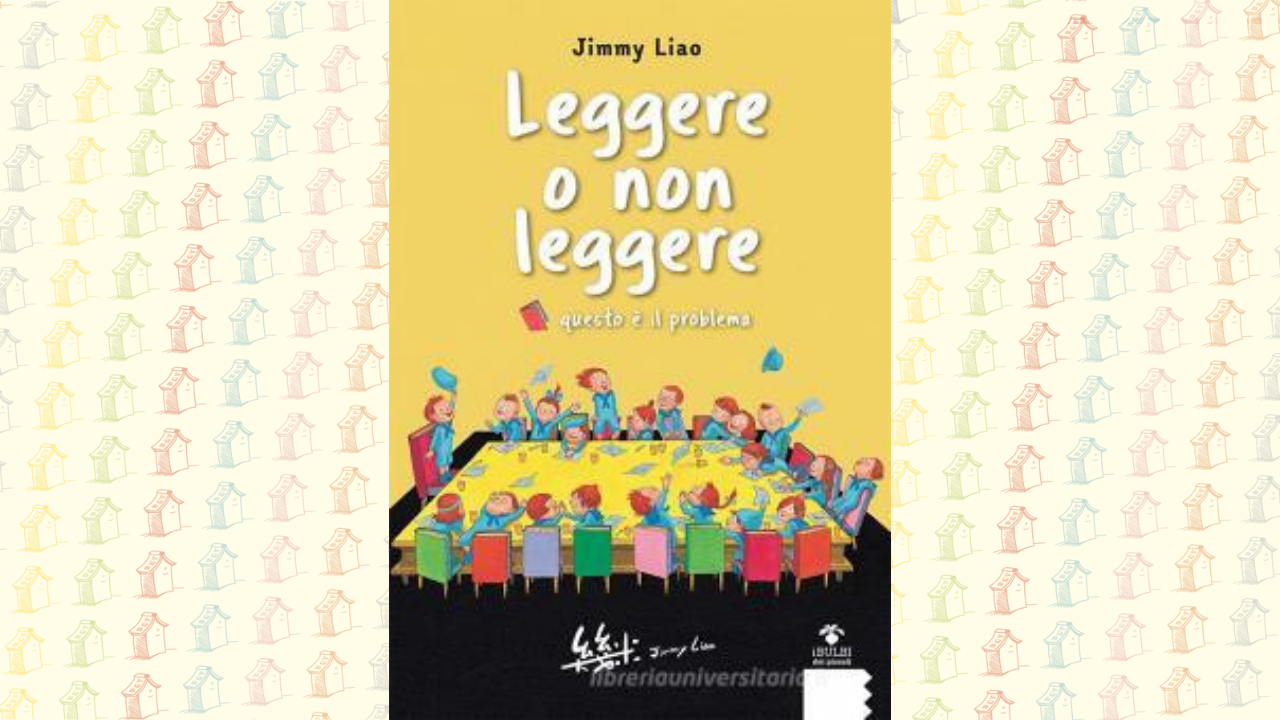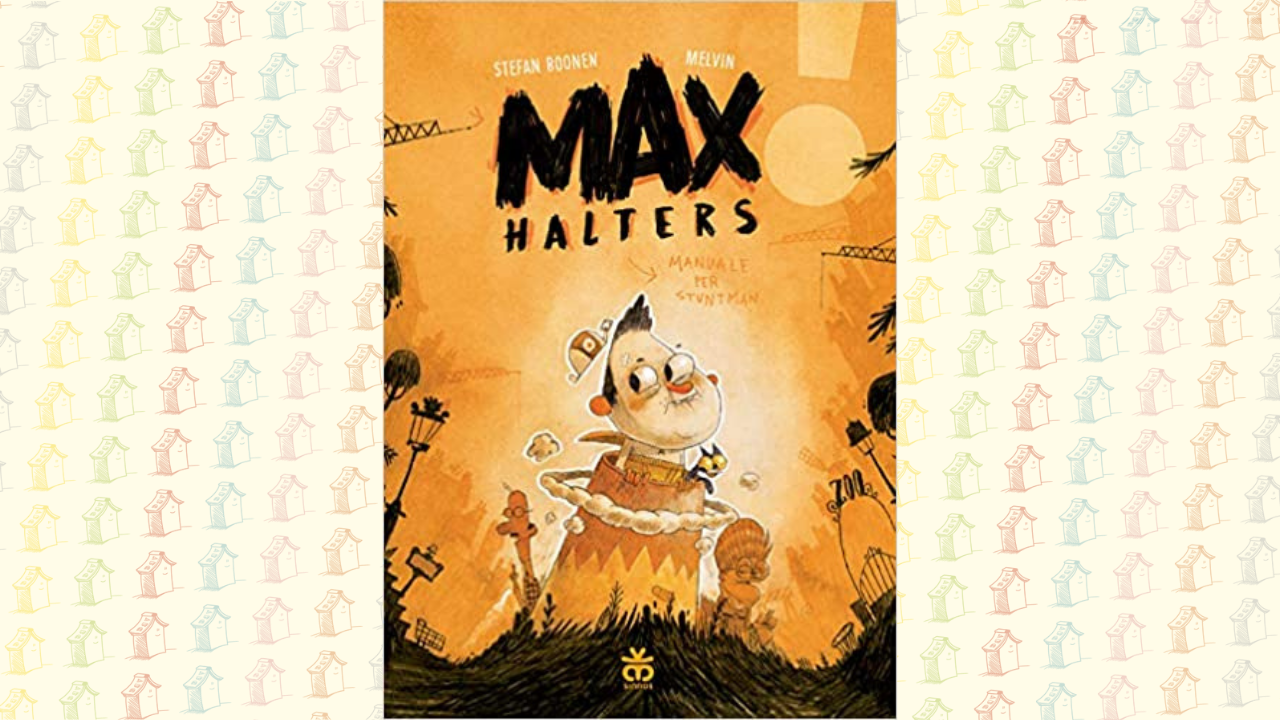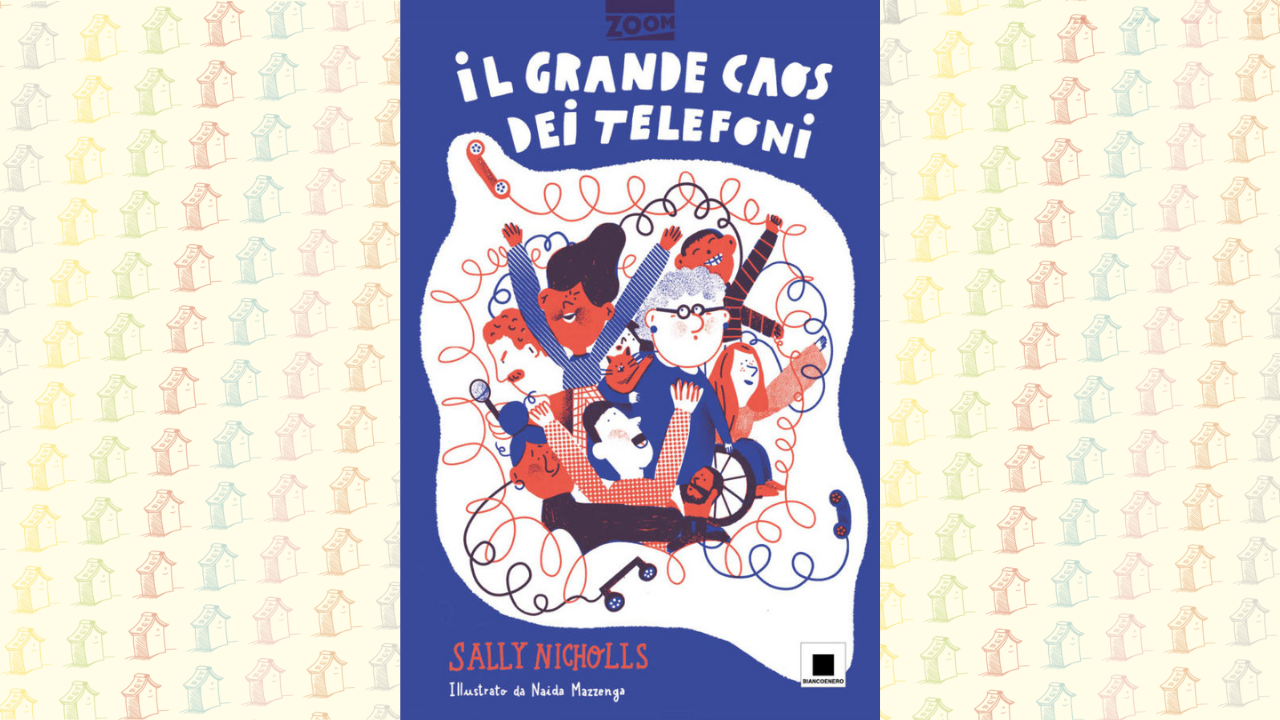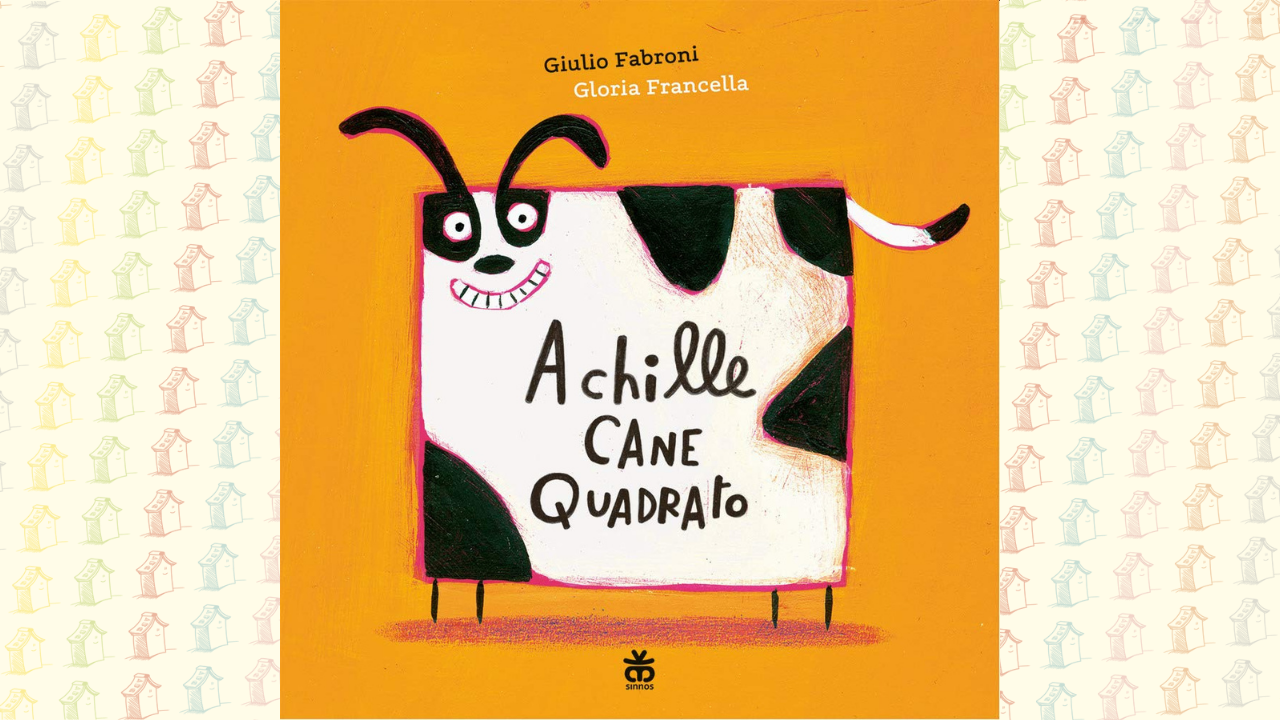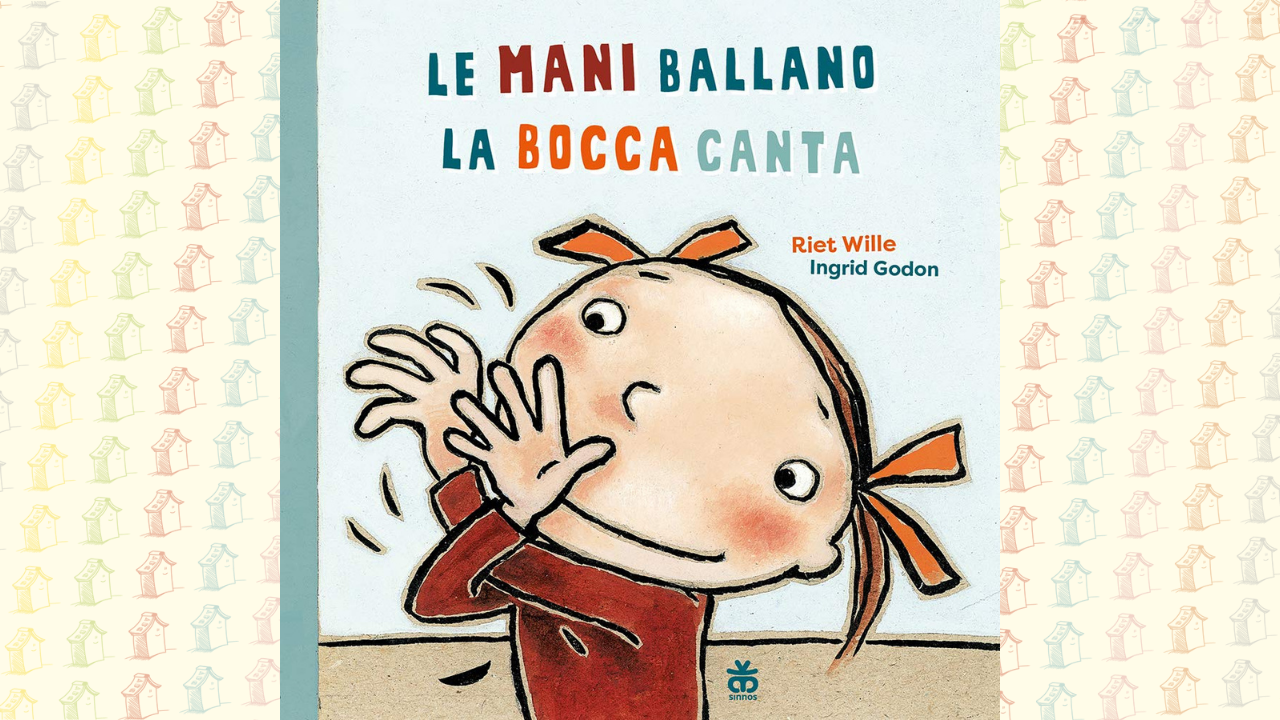Mostraci chi sei
Elle Mc Nicoll è una giovane autrice di grande talento. La sua penna ha, in particolare, due assi nella manica: uno stile affilato come un bisturi e una netta visione rispetto ai temi trattati. Entrambi i romanzi finora da lei scritti, pubblicati in Italia da Uovonero, scelgono come fulcro narrativo la neurodivergenza, argomento che non solo le sta molto a cuore ma che soprattutto conosce in prima persona, essendo lei stessa una persona autistica.
Se Una specie di scintilla mette in luce la difficoltà di convivere con i pregiudizi e le discriminazioni che una diversità tanto marcata è solita generare, Mostraci chi sei si spinge forse un po’ più in là, andando a indagare attraverso lo strumento narrativo il pericolo di considerare qualunque tipo di divergenza un qualcosa da aggiustare.
L’autismo è una forma di errore? Le persone autistiche sono in qualche modo rotte e vanno riparate per poter avere una vita realmente piena e degna? Per gridare con forza il suo NO a questi interrogativi tutt’altro che inauditi, l’autrice costruisce un personaggio dalla grandissima forza, Cora, e una cornice fantascientifica in cui una avanguardistica azienda mette a punto degli avatar che consentano alle persone di continuare a incontrare i loro cari defunti. Direttore di tale azienda, Il melograno, è il signor Magnus Hawkins. Cora, adolescente neurodivergente che ha da poco perso la mamma, vi entra in contatto perché qui lavora suo fratello. Il signor Hawkins e il suo braccio destro, l’affascinante ingegner Gold, mostrano un sospetto e insistente interesse nei confronti di Cora: la sua diversità sarebbe loro utile – dicono – per migliorare gli avatar di chi pensa e sente in modo differente come lei. Dapprima resistente, anche a causa del ferreo divieto da parte del padre di avere contatti con Il melograno, Cora finisce per lasciarsi convincere a collaborare, sottoponendosi a una serie di test e rispondendo a infinite sessioni di domande da parte dell’ingegner Gold. Questa le viene infatti prospettata come l’unica possibilità di continuare a tenere in vita il suo amico Adrien, il figlio del signor Hawkins, con cui Cora ha stretto un’intensa amicizia e rimasto malauguratamente vittima di un grave incidente stradale. Divertente, empatico e perseverante, anche Adrien, con una diagnosi di ADHD, ha un cervello che funziona diversamente e ha conosciuto sulla sua pelle la difficoltà di interagire con un mondo che non è fatto su misura per lui e forse anche per questo capisce davvero Cora e i suoi tormentati sentimenti. Sarà proprio il forte legame che la lega ad Adrien a portare Cora ad andare fino in fondo nel comprendere cosa si celi realmente dietro la facciata del Melograno, impedendo all’azienda di portare a compimento un piano tanto avveniristico quanto raccapricciante.
Avvincente e intenso, Mostraci chi sei non ha paura di mettere sul tavolo questioni scottanti e complesse che pertengono all’etica e diventano sempre più impellenti man mano che la tecnologia consente di fare cose prima inimmaginabili. Al pari del precedente, il romanzo di Elle Mc Nicoll dice a gran voce l’importanza di ascoltare il punto di vista di chi una forma di diversità la vive in prima persona e di considerare il fatto che le categorie del giusto e dello sbagliato poco hanno a che vedere con quelle della tipicità e della divergenza.